
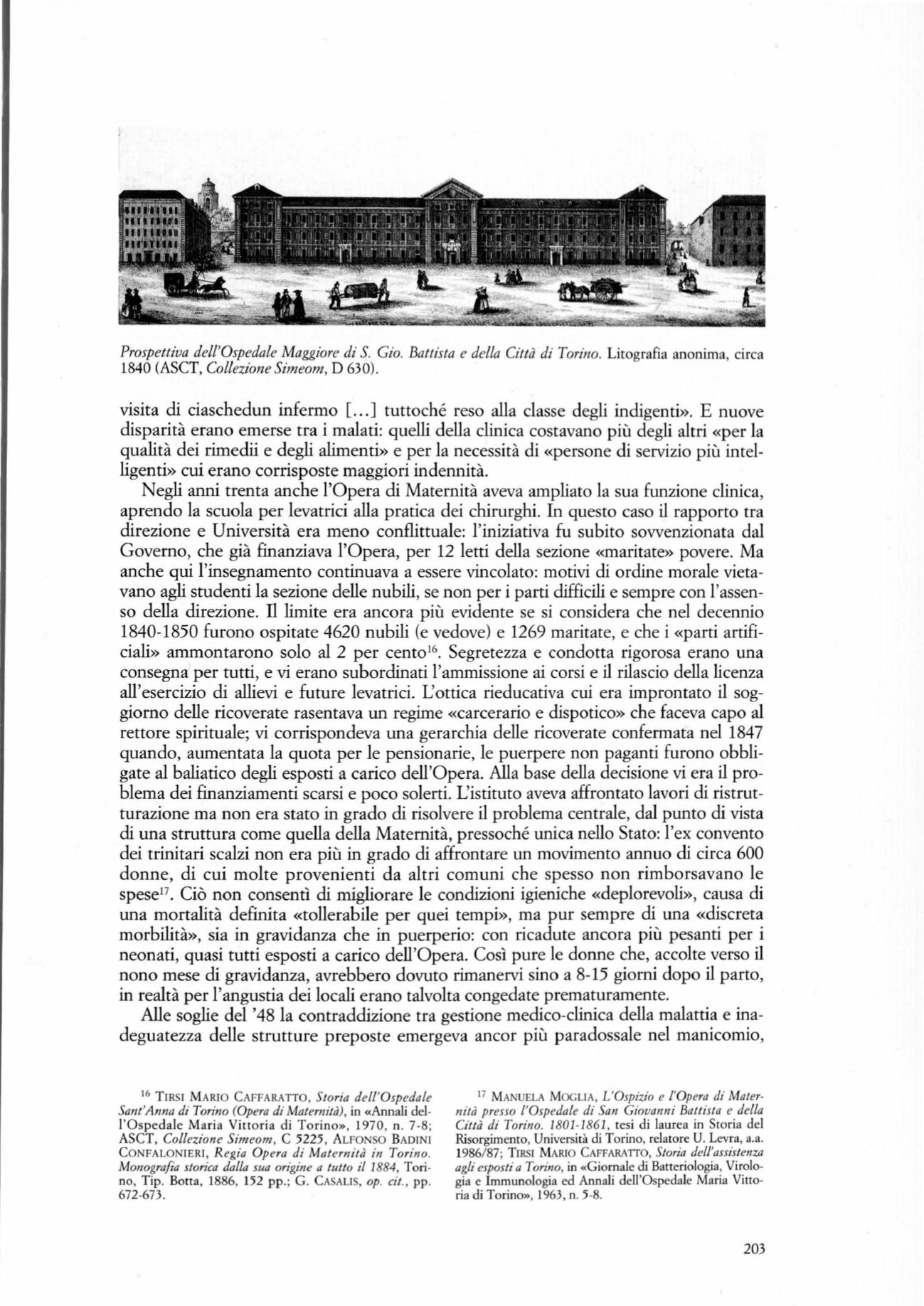
Prospettiva dell'Ospedale Maggiore di
S.
Gio. Battista e della
Città
di Torino.
Litografia anonima, circa
1840 (ASCT,
Collezione Simeom,
D 630).
visita di ciaschedun infermo [. .. ] tuttoché reso alla classe degli indigenti». E nuove
disparità erano emerse tra i malati: quelli della clinica costavano più degli altri «per la
qualità dei rimedii e degli alimenti» e per la necessità di «persone di servizio più intel–
ligenti» cui erano corrisposte maggiori indennità.
Negli anni trenta anche l'Opera di Maternità aveva ampliato la sua funzione clinica,
aprendo la scuola per levatrici alla pratica dei chirurghi. In questo caso il rapporto tra
direzione e Università era meno conflittuale: l'iniziativa fu subito sovvenzionata dal
Governo, che già finanziava l'Opera, per 12 letti della sezione «maritate» povere. Ma
anche qui l'insegnamento continuava a essere vincolato: motivi di ordine morale vieta–
vano agli studenti la sezione delle nubili, se non per i parti difficili e sempre con l'assen–
so della direzione.
il
limite era ancora più evidente se si considera che nel decennio
1840-1850 furono ospitate 4620 nubili (e vedove) e 1269 maritate, e che i «parti artifi–
ciali» ammontarono solo al 2 per cento
l6 •
Segretezza e condotta rigorosa erano una
consegna per tutti, e vi erano subordinati l'ammissione ai corsi e il rilascio della licenza
all'esercizio di allievi e future levatrici. L'ottica rieducativa cui era improntato il sog–
giorno delle ricoverate rasentava un regime «carcerario e dispotico» che faceva capo al
rettore spirituale; vi corrispondeva una gerarchia delle ricoverate confermata nel 1847
quando, aumentata la quota per le pensionarie, le puerpere non paganti furono obbli–
gate al baliatico degli esposti a carico dell'Opera. Alla base della decisione vi era il pro–
blema dei finanziamenti scarsi e poco solerti. L'istituto aveva affrontato lavori di ristrut–
turazione ma non era stato in grado di risolvere il problema centrale, dal punto di vista
di una struttura come quella della Maternità, pressoché unica nello Stato: l'ex convento
dei trinitari scalzi non era più in grado di affrontare un movimento annuo di circa 600
donne, di cui molte provenienti da altri comuni che spesso non rimborsavano le
spese
17 •
Ciò
non consentì di migliorare le condizioni igieniche «deplorevoli», causa di
una mortalità definita «tollerabile per quei tempi», ma pur sempre di una «discreta
morbilità», sia in gravidanza che in puerperio: con ricadute ancora più pesanti per i
neonati, quasi tutti esposti a carico dell'Opera. CosÌ pure le donne che, accolte verso il
nono mese di gravidanza, avrebbero dovuto rimanervi sino a 8-15 giorni dopo il parto,
in realtà per l'angustia dei locali erano talvolta congedate prematuramente.
Alle soglie del '48 la contraddizione tra gestione medico-clinica della malattia e ina–
deguatezza delle strutture preposte emergeva ancor più paradossale nel manicomio,
16
TIRSI MARlo CAFFARATTO,
Storia dell'Ospedale
Sant'Anna di Torino (Opera di Maternità) ,
in «Annali del–
l'Ospedale Maria Vittoria di Torino» , 1970, n . 7-8;
ASCT,
Collezione Simeom ,
C 5225 , ALFONSO BADINI
Co FALONIERJ ,
Regia Opera di Mat ernità in Torino.
Monografia storica dalla sua origine a tutto il
1884, Tori–
no, Tip. Botta, 1886, 152 pp.; G . CASALlS,
op.
cit.,
pp.
672-673.
17
MANUELA MOGLIA,
L'Ospizio e l'Opera di Mater–
nità presso l'Ospedale di San Giovanni Battista e della
Città di Torino. 1801 -1861,
tesi di laurea in Storia del
Risorgimento, Università di Torino, relatore U. Levra, a.a.
1986/ 87; TrRSI MARlO CAFFARATTO,
Storia dell'assistenza
agli esposti a Torino,
in «Giornale di Batteriologia, Virolo–
gia e Immunologia ed Annali dell'Ospedale Maria Vitto–
ria di Torino», 1963 , n. 5-8.
203


















