
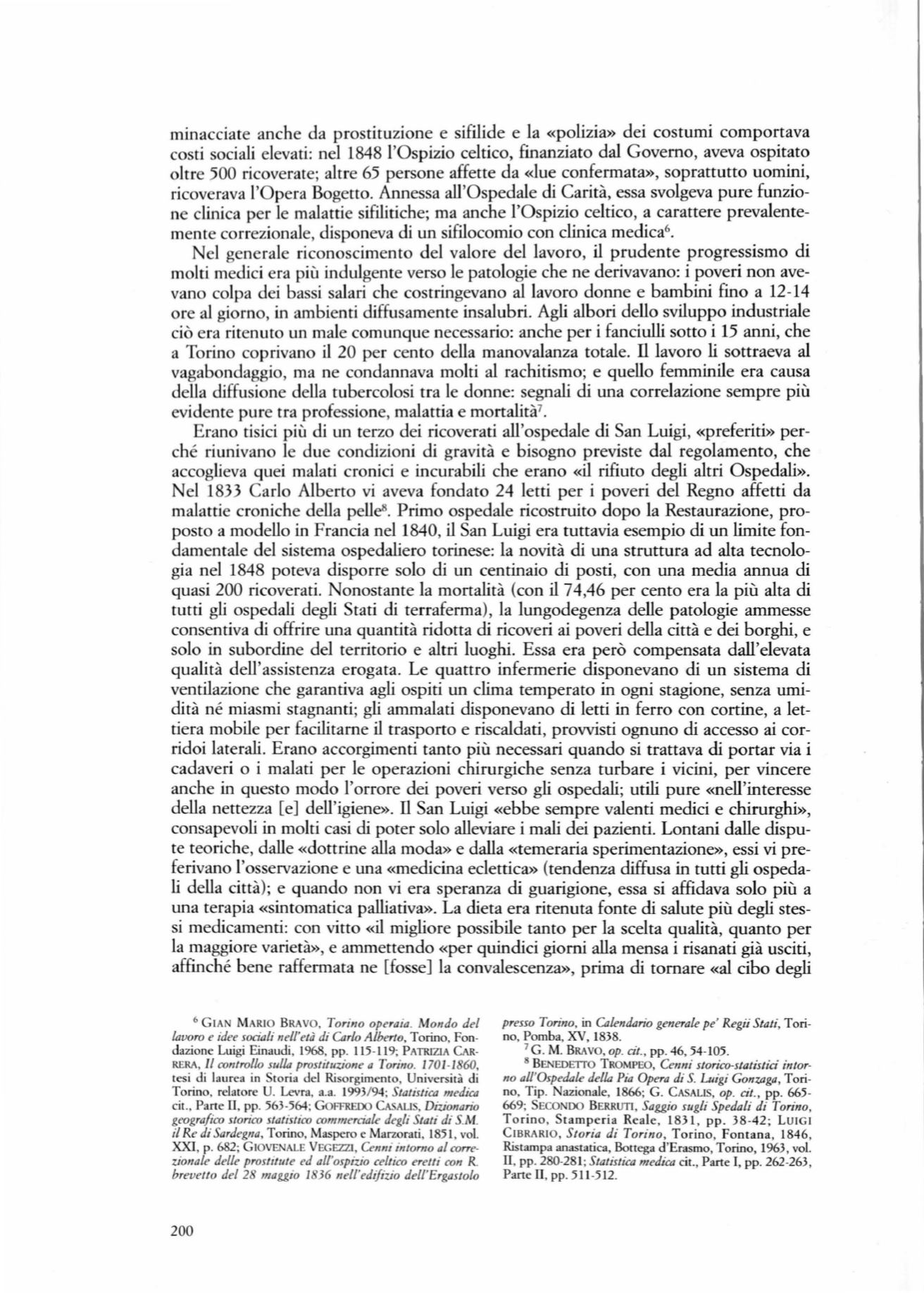
minacciate anche da prostituzione e sifilide e la «polizia» dei costumi comportava
costi sociali elevati: nel 1848 l'Ospizio celtico, finanziato dal Governo, aveva ospitato
oltre 500 ricoverate; altre 65 persone affette da «lue confermata», soprattutto uomini,
ricoverava l'Opera Bogetto. Annessa all'Ospedale di Carità, essa svolgeva pure funzio–
ne clinica per le malattie sifilitiche; ma anche l'Ospizio celtico, a carattere prevalente–
mente correzionale, disponeva di un sifilocomio con clinica medica
6
.
Nel generale riconoscimento del valore del lavoro, il prudente progressismo di
molti medici era più indulgente verso le patologie che ne derivavano: i poveri non ave–
vano colpa dei bassi salari che costringevano al lavoro donne e bambini fino a 12-14
ore al giorno, in ambienti diffusamente insalubri. Agli albori dello sviluppo industriale
ciò era ritenuto un male comunque necessario: anche per i fanciulli sotto i 15 anni, che
a Torino coprivano il 20 per cento della manovalanza totale.
il
lavoro li sottraeva al
vagabondaggio, ma ne condannava molti al rachitismo; e quello femminile era causa
della diffusione della tubercolosi tra le donne: segnali di una correlazione sempre più
evidente pure tra professione, malattia e mortalità
7 •
Erano tisici più di un terzo dei ricoverati all'ospedale di San Luigi, «preferiti» per–
ché riunivano le due condizioni di gravità e bisogno previste dal regolamento, che
accoglieva quei malati cronici e incurabili che erano «il rifiuto degli altri Ospedali».
Nel 1833 Carlo Alberto vi aveva fondato 24 letti per i poveri del Regno affetti da
malattie croniche della pelle
8 .
Primo ospedale ricostruito dopo la Restaurazione, pro–
posto a modello in Francia nel 1840, il San Luigi era tuttavia esempio di un limite fon–
damentale del sistema ospedaliero torinese: la novità di una struttura ad alta tecnolo–
gia nel 1848 poteva disporre solo di un centinaio di posti, con una media annua di
quasi 200 ricoverati. Nonostante la mortalità (con il 74,46 per cento era la più alta di
tutti gli ospedali degli Stati di terraferma) , la lungodegenza delle patologie ammesse
consentiva di offrire una quantità ridotta di ricoveri ai poveri della città e dei borghi, e
solo in subordine del territorio e altri luoghi. Essa era però compensata dall'elevata
qualità dell' assistenza erogata. Le quattro infermerie disponevano di un sistema di
ventilazione che garantiva agli ospiti un clima temperato in ogni stagione, senza umi–
dità né miasmi stagnanti; gli ammalati disponevano di letti in ferro con cortine, a let–
tiera mobile per facilitarne il trasporto e riscaldati, provvisti ognuno di accesso ai cor–
ridoi laterali. Erano accorgimenti tanto più necessari quando si trattava di portar via i
cadaveri o
i
malati per le operazioni chirurgiche senza turbare i vicini, per vincere
anche in questo modo l'orrore dei poveri verso gli ospedali; utili pure «nell'interesse
della nettezza [e] dell'igiene».
il
San Luigi «ebbe sempre valenti medici e chirurghi»,
consapevoli in molti casi di poter solo alleviare i mali dei pazienti. Lontani dalle dispu–
te teoriche, dalle «dottrine alla moda» e dalla «temeraria sperimentazione», essi vi pre–
ferivano l'osservazione e una «medicina eclettica» (tendenza diffusa in tutti gli ospeda–
li della città) ; e quando non vi era speranza di guarigione, essa si affidava solo più a
una terapia «sintomatica palliativa». La dieta era ritenuta fonte di salute più degli stes–
si medicamenti: con vitto
<<il
migliore possibile tanto per la scelta qualità, quanto per
la maggiore varietà», e ammettendo «per quindici giorni alla mensa i risanati già usciti,
affinché bene raffermata ne [fosse] la convalescenza», prima di tornare «al cibo degli
6
GIAN MARIO BRAVO,
Torino operaia. Mondo del
lavoro e idee sociali nell'età di Carlo Alberto,
Torino, Fon–
dazione Luigi Einaudi, 1968, pp. 115-119; PATRIZIACAR–
RERA,
Il controllo sulla prostituvone a Torino. 1701 -1860,
tesi di laurea in toria del Risorgimento, Università di
Torino, relatore U. Levra, a.a. 1993/94;
Statistica medica
cit., Parte II, pp. 563-564; GOFFREDO CASALlS,
Di1.ionario
geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M.
il Re di Sardegna,
Torino, Maspero e Marzorati, 1851 , voI.
XXI, p. 682; GIOVE ALE VEGEZZI,
Cellni intorno al co"e-
1.I'ollale delle prostitute ed all
'ospi1.ioceltico erelli con
R.
brevello del
28
maggio
1836
nell'edifizio dell'Ergastolo
200
presso Torino,
in
Calendario generale pe' Regii Stati,
Tori–
no, Pomba, XV, 1838.
7
G. M. BRAVO,
op. cit.,
pp. 46,54-105.
8
BENEDETTO TROMPEO,
Cenni storico-statistici intor–
no all'Ospedale dello Pia Opera di
S.
Luigi Gonzaga,
Tori–
no, Tip. Nazionale, 1866; G. CASALIS,
op. cit.,
pp. 665-
669; SECONDO BERRUTI,
Saggio sugli Spedali di Torino,
Tor in o, S tamperia Reale, 183 1, pp . 38-42 ; LUIGI
C IBRARIO,
Storia di Torino ,
Torino, Fontana, 1846,
Ristampa anastatica, Bottega d'Erasmo, Torino, 1963, voI.
II, pp. 280-281;
Statistica medica
cit., Parte
I,
pp. 262-263 ,
Parte II, pp. 5 11 -5 12.


















