
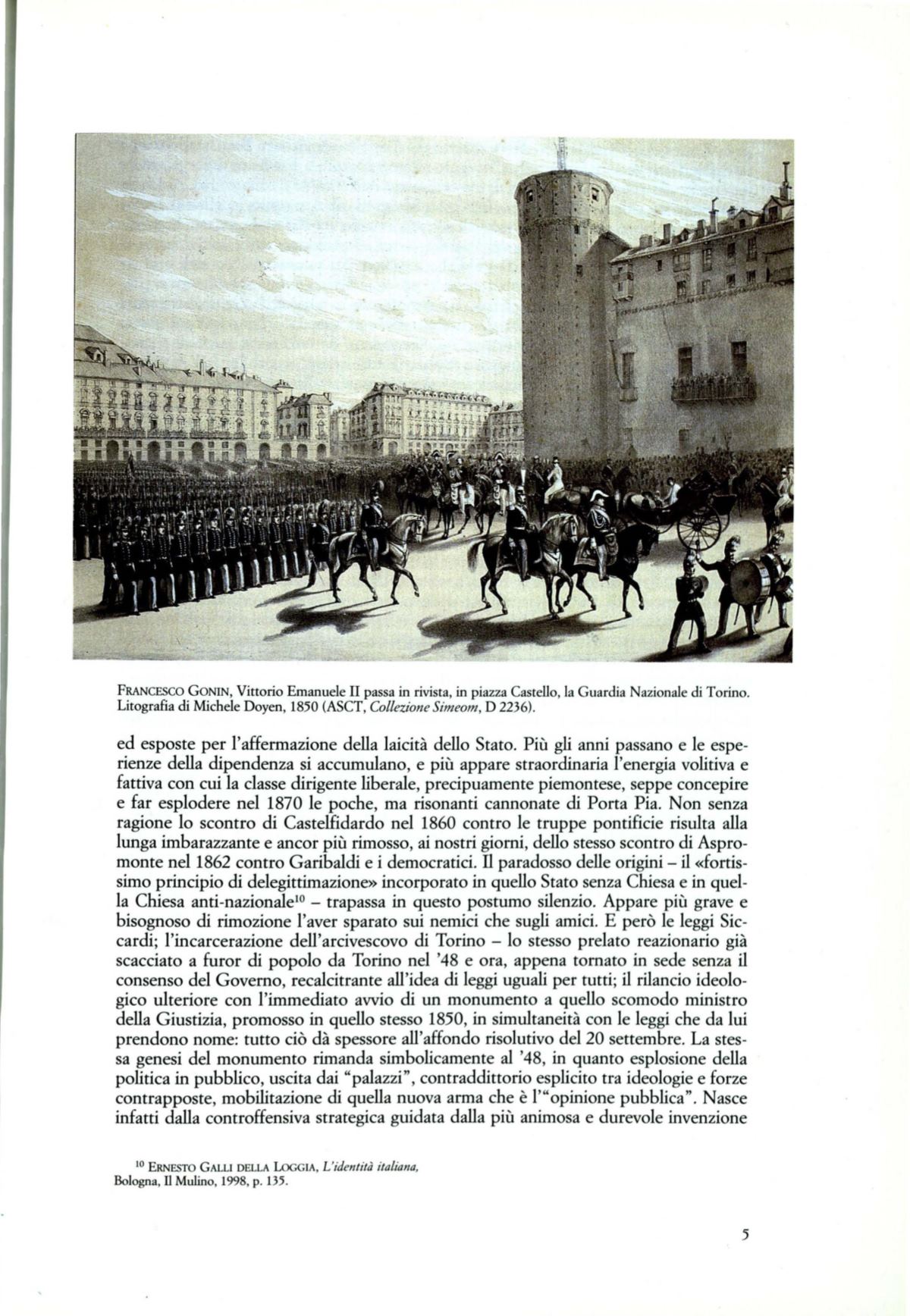
FRANCESCO GONIN, Vittorio Emanuele II passa
in
rivista,
in
piazza Castello, la Guardia Nazionale
eli
Torino.
Litografia di Michele Doyen, 1850 (ASCT,
Collezione Simeom,
D 2236).
ed esposte per l'affermazione della laicità dello Stato. Più gli anni passano e le espe–
rienze della dipendenza si accumulano, e più appare straordinaria l'energia volitiva e
fattiva con cui la classe dirigente liberale, precipuamente piemontese, seppe concepire
e far esplodere nel 1870 le poche, ma risonanti cannonate di Porta Pia. Non senza
ragione lo scontro di Castelfidardo nel 1860 contro le truppe pontificie risulta alla
lunga imbarazzante e ancor più rimosso, ai nostri giorni, dello stesso scontro
di
Aspro–
monte nel 1862 contro Garibaldi e i democratici.
li
paradosso delle origini - il «fortis–
simo principio di delegittimazione» incorporato in quello Stato senza Chiesa e in quel–
la Chiesa anti-nazionale
1o -
trapassa in questo postumo silenzio. Appare più grave e
bisognoso di rimozione l'aver sparato
sui
nemici che sugli amici. E però le leggi Sic–
cardi; l'incarcerazione dell'arcivescovo di Torino - lo stesso prelato reazionario già
scacciato a furor di popolo da Torino nel '48 e ora, appena tornato in sede senza il
consenso del Governo, recalcitrante all 'idea di leggi uguali per tutti; il rilancio ideolo–
gico ulteriore con l'immediato avvio di un monumento a quello scomodo ministro
della Giustizia, promosso in quello stesso 1850, in simultaneità con le leggi che da lui
prendono nome: tutto ciò dà spessore all'affondo risolutivo del 20 settembre. La stes–
sa genesi del monumento rimanda simbolicamente al '48, in quanto esplosione della
politica in pubblico, uscita dai "palazzi", contraddittorio esplicito tra ideologie e forze
contrapposte, mobilitazione di quella nuova arma che è l'''opinione pubblica". Nasce
infatti dalla controffensiva strategica guidata dalla più animosa e durevole invenzione
lO
ERNESTO GALLI
DELLA LoGGIA,
L'identità italiana,
Bologna, TI Mulino, 1998, p. 135.
5


















