
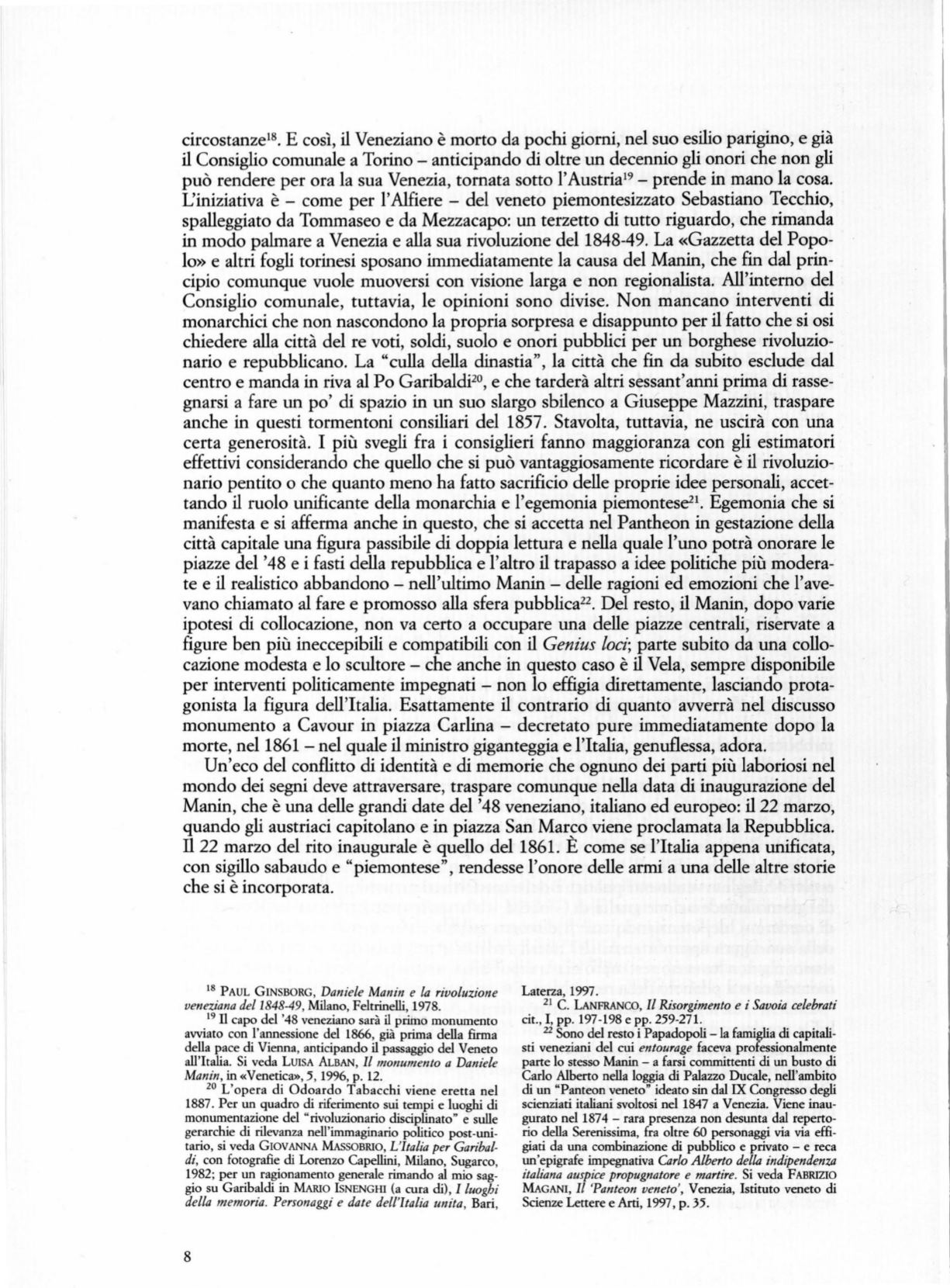
circostanzel
8 .
E cosi, il Veneziano
è
morto da pochi giorni, nel suo esilio parigino, e già
il Consiglio comunale a Torino - anticipando di oltre un decennio gli onori che non gli
può rendere per ora la sua Venezia, tornata sotto l'Austria
19 -
prende in mano la cosa.
L'iniziativa
è -
come per l'Alfiere - del veneto piemontesizzato Sebastiano Tecchio,
spalleggiato da Tommaseo e da Mezzacapo: un terzetto di tutto riguardo, che rimanda
in modo palmare a Venezia e alla sua rivoluzione del 1848-49. La «Gazzetta del Popo–
lo» e altri fogli torinesi sposano immediatamente la causa del Manin, che fin dal prin–
cipio comunque vuole muoversi con visione larga e non regionalista. All'interno del
Consiglio comunale, tuttavia, le opinioni sono divise. Non mancano interventi di
monarchici che non nascondono la propria sorpresa e disappunto per il fatto che si osi
chiedere alla città del re voti, soldi, suolo e onori pubblici per un borghese rivoluzio–
nario e repubblicano. La "culla della dinastia", la città che fin da subito esclude dal
centro e manda in riva al Po Garibaldi
20 ,
e che tarderà altri sessant'anni prima di rasse–
gnarsi a fare un po' di spazio in un suo slargo sbilenco a Giuseppe Mazzini, traspare
anche in questi tormentoni consiliari del 1857. Stavolta, tuttavia, ne uscirà con una
certa generosità. I più svegli fra i consiglieri fanno maggioranza con gli estimatori
effettivi considerando che quello che si può vantaggiosamente ricordare
è
il rivoluzio–
nario pentito o che quanto meno ha fatto sacrificio delle proprie idee personali, accet–
tando il ruolo unificante della monarchia e l'egemonia piemontese2
1 •
Egemonia che si
manifesta e si afferma anche in questo, che si accetta nel Pantheon in gestazione della
città capitale una figura passibile di doppia lettura e nella quale l'uno potrà onorare le
piazze del '48 e i fasti della repubblica e l'altro il trapasso a idee politiche più modera–
te e il realistico abbandono - nell'ultimo Manin - delle ragioni ed emozioni che l'ave–
vano chiamato al fare e promosso alla sfera pubblica
22 •
Del resto, il Manin, dopo varie
ipotesi di collocazione, non va certo a occupare una delle piazze centrali, riservate a
figure ben più ineccepibili e compatibili con il
Genius toci;
parte subito da una collo–
cazione modesta e lo scultore - che anche in questo caso
è
il Vela, sempre disponibile
per interventi politicamente impegnati - non lo effigia direttamente, lasciando prota–
gonista la figura dell'Italia. Esattamente il contrario di quanto avverrà nel discusso
monumento a Cavour in piazza Carlina - decretato pure immediatamente dopo la
morte, nel 1861 - nel quale il ministro giganteggia e l'Italia, genuflessa, adora.
Un'eco del conflitto di identità e di memorie che ognuno dei parti più laboriosi nel
mondo dei segni deve attraversare, traspare comunque nella data di inaugurazione del
Manin, che è una delle grandi date del '48 veneziano, italiano ed europeo: il
22
marzo,
quando gli austriaci capitolano e in piazza San Marco viene proclamata la Repubblica.
li
22
marzo del rito inaugurale
è
quello del 1861.
È
come se l'Italia appena unificata,
con sigillo sabaudo e "piemontese", rendesse l'onore delle armi a una delle altre storie
che si
è
incorporata.
18
PAUL GINSBORG,
Daniele Manin e lo rivoluzione
veneziana del
1848-49, Milano, Fdtrindli, 1978.
19
TI capo dd '48 veneziano sarà il primo monumento
avviato con l'annessione dd 1866, già prima ddIa firma
ddIa pace di Vienna, anticipando il passaggio dd Veneto
all'Italia. Si veda LUISA ALBAN,
Il monumento a Daniele
Manin,
in «Venetica», 5,1996, p. 12.
20
L'opera di Odoardo Tabacchi viene eretta nel
1887. Per un quadro di riferimento sui tempi e luoghi di
monumentazione dd "rivoluzionario disciplinato" e sulle
gerarchie di rilevanza ndI'immaginario politico post-uni–
tario, si veda GIOVANNA MASSOBRIO,
L'Italia per Garibal–
di,
con fotografie di Lorenzo Capellini, Milano, Sugarco,
1982; per un ragionamento generale rimando al mio sag–
gio su Garibaldi in
MARIo
ISNENGHI (a cura di),
I luoghi
della memoria. Personaggi e date dell'Italia unita,
Bari,
8
Laterza, 1997.
21
C.
LANFRANco,
Il Risorgimento e i Savoia celebrati
cit., I, pp. 197-198 e pp. 259-271.
22
Sono dd resto i Papadopoli -la famiglia di capitali–
sti veneziani dd cui
entourage
faceva professionalmente
parte lo stesso Manin - a farsi committenti di un busto di
Carlo Alberto ndIa loggia di Palazzo Ducale, ndI'ambito
di un "Panteon veneto" ideato sin dal IX Congresso degli
scienziati italiani svoltosi nd 1847 a Venezia. Viene inau–
gurato nd 1874 - rara presenza non desunta dal reperto–
rio ddIa Serenissima, fra oltre 60 personaggi via via
effi–
giati da una combinazione di pubblico e privato - e reca
un'epigrafe impegnativa
Carlo Alberto della indipendenza
italiana auspice propugnatore e martire.
Si veda FABRIZIO
MAGANI,
Il 'Panteon veneto',
Venezia, Istituto veneto di
Scienze Lettere e
Arti,
1997, p. 35.


















