
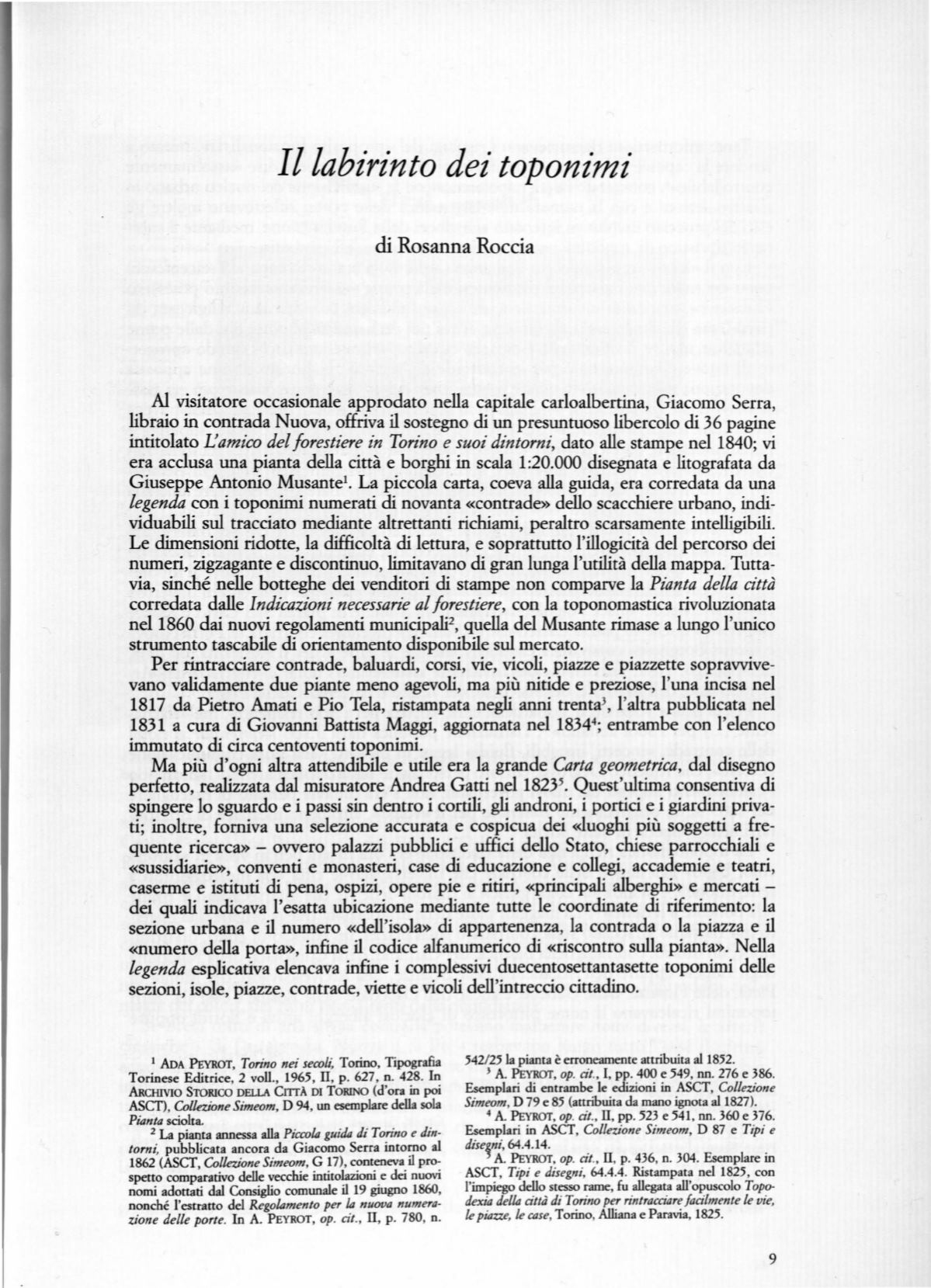
li
labirinto dei toponimi
di Rosanna Roccia
Al visitatore occasionale approdato nella capitale carloalbertina, Giacomo Serra,
libraio in contrada Nuova, offriva il sostegno di un presuntuoso libercolo di 36 pagine
intitolato
I:amico del forestiere in Torino e suoi dintorni,
dato alle stampe nel 1840; vi
era acclusa una pianta della città e borghi in scala 1:20.000 disegnata e litografata da
Giuseppe Antonio Musante
1 •
La piccola carta, coeva alla guida, era corredata da una
legenda
con i toponimi numerati di novanta «contrade» dello scacchiere urbano, indi–
viduabili sul tracciato mediante altrettanti richiami, peraltro scarsamente intelligibili.
Le dimensioni ridotte, la difficoltà di lettura, e soprattutto l'illogicità del percorso dei
numeri, zigzagante e discontinuo, limitavano di gran lunga l'utilità della mappa. Tutta–
via, sinché nelle botteghe dei venditori di stampe non comparve la
Pianta della
città
corredata dalle
Indicazioni necessarie al forestiere,
con la toponomastica rivoluzionata
nel 1860 dai nuovi regolamenti municipali
2 ,
quella del Musante rimase a lungo l'unico
strumento tascabile di orientamento disponibile sul mercato.
Per rintracciare contrade, baluardi, corsi, vie, vicoli, piazze e piazzette sopravvive–
vano validamente due piante meno agevoli, ma più nitide e preziose, l'una incisa nel
1817 da Pietro Amati e Pio Tela, ristampata negli anni trenta3, l'altra pubblicata nel
1831 a cura di Giovanni Battista Maggi, aggiornata nel 1834
4 ;
entrambe con l'elenco
immutato di circa centoventi toponimi.
Ma più d'ogni altra attendibile e utile era la grande
Carta geometrica ,
dal disegno
perfetto, realizzata dal misuratore Andrea Gatti nel 182J5. Quest'ultima consentiva di
spingere lo sguardo e i passi sin dentro i cortili, gli androni, i portici e i giardini priva–
ti; inoltre, forniva una selezione accurata e cospicua dei «luoghi più soggetti a fre–
quente ricerca» - ovvero palazzi pubblici e uffici dello Stato, chiese parrocchiali e
«sussidiarie», conventi e monasteri, case di educazione e collegi, accademie e teatri,
caserme e istituti di pena, ospizi, opere pie e ritiri, «principali alberghi» e mercati -
dei quali indicava l'esatta ubicazione mediante tutte le coordinate di riferimento: la
sezione urbana e il numero «dell'isola» di appartenenza, la contrada o la piazza e il
«numero della porta», infine il codice alfanumerico di «riscontro sulla pianta». Nella
legenda
esplicativa elencava infine i complessivi duecentosettantasette toponimi delle
sezioni, isole, piazze, contrade, viette e vicoli dell'intreccio cittadino.
1
ADA
PEYROT,
Torino nei
secol~
Torino, Tipografia
Torinese Editrice, 2 voll. , 1965, II, p. 627, n. 428. In
ARCHIVIO STORICO
DELLA
CITTA
DI
TORINO (d'ora in poi
ASCT),
Collezione Simeom,
D 94, un esemplare della sola
Pianta
sciolta.
2
La pianta annessa alla
Piccola guida di Torino e din–
torm;
pubblicata ancora da Giacomo Serra intorno al
1862 (ASCT,
Collezione Simeom,
G 17), conteneva
il
pro–
spetto comparativo delle vecchie intitolazioni e dei nuovi
nomi adottati dal Consiglio comunale
il
19 giugno 1860,
nonché l'estratto dd
Regolamento per la nuova numera–
zione delle porte.
In A. PEYROT,
op. cit.,
II, p. 780, n.
542/25 la pianta è erroneamente attribuita al 1852.
3
A.
PEYROT,
op. cit.,
I, pp. 400 e 549, nn. 276 e 386.
Esemplari di entrambe le edizioni
in
ASCT,
Collezione
Simeom,
D 79 e 85 (attribuita da mano ignota al 1827).
4
A.
PEYROT,
op. cit.,
II, pp. 523 e 541, nn. 360 e 376.
Esemplari in ASCT,
Collezione Simeom,
D 87 e
Tipi e
dise~ni,
64.4.14.
A.
PEYROT,
op. cit.,
II, p. 436, n. 304. Esemplare
in
ASCT,
Tipi e disegni,
64.4.4. Ristampata nd 1825, con
l'impiego dello stesso rame,
fu
allegata all'opuscolo
Topo–
dexia della città di Torino per rintracciare facilmente le vie,
le pia1.1.e, le case,
Torino, Alliana e Paravia, 1825.
9


















