
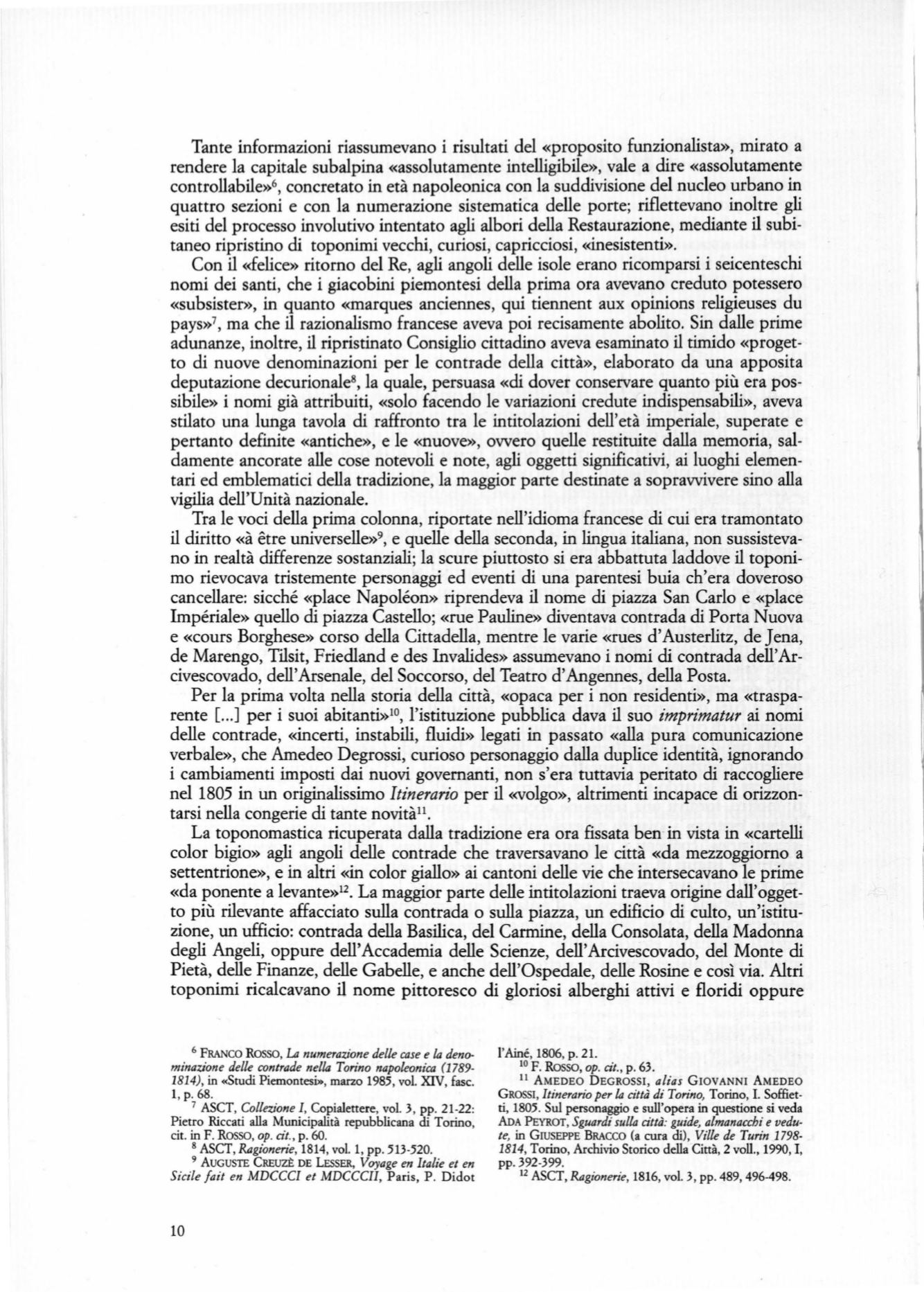
Tante informazioni riassumevano i risultati del «proposito funzionalista», mirato a
rendere la capitale subalpina «assolutamente intelligibile», vale a dire «assolutamente
controllabile»6, concretato in età napoleonica con la suddivisione del nucleo urbano in
quattro sezioni e con la numerazione sistematica delle porte; riflettevano inoltre gli
esiti del processo involutivo intentato agli albori della Restaurazione, mediante il subi–
taneo ripristino di toponimi vecchi, curiosi, capricciosi, «inesistenti».
Con il «felice» ritorno del Re, agli angoli delle isole erano ricomparsi i seicenteschi
nomi dei santi, che i giacobini piemontesi della prima ora avevano creduto potessero
«subsister», in quanto «marques anciennes, qui tiennent aux opinions religieuses du
pays»7, ma che il razionalismo francese aveva poi recisamente abolito. Sin dalle prime
adunanze, inoltre, il ripristinato Consiglio cittadino aveva esaminato il timido «proget–
to di nuove denominazioni per le contrade della città», elaborato da una apposita
deputazione decurionale
8 ,
la quale, persuasa «di dover conservare quanto più era pos–
sibile» i nomi già attribuiti, «solo facendo le variazioni credute indispensabili», aveva
stilato una lunga tavola di raffronto tra le intitolazioni dell'età imperiale, superate e
pertanto definite «antiche», e le «nuove», ovvero quelle restituite dalla memoria, sal–
damente ancorate alle cose notevoli e note, agli oggetti significativi, ai luoghi elemen–
tari ed emblematici della tradizione, la maggior parte destinate a sopravvivere sino alla
vigilia dell'Unità nazionale.
Tra le voci della prima colonna, riportate nell'idioma francese di cui era tramontato
il diritto «à etre universelle»9, e quelle della seconda, in lingua italiana, non sussisteva–
no in realtà differenze sostanziali; la scure piuttosto si era abbattuta laddove il toponi–
mo rievocava tristemente personaggi ed eventi di una parentesi buia ch'era doveroso
cancellare: sicché «pIace Napoléon» riprendeva il nome di piazza San Carlo e «pIace
Impériale» quello di piazza Castello; «rue Pauline» diventava contrada di Porta Nuova
e «cours Borghese» corso della Cittadella, mentre le varie «rues d 'Austerlitz, de lena,
de Marengo, Tilsit, Friedland e des Invalides» assumevano i nomi di contrada dell'Ar–
civescovado, dell'Arsenale, del Soccorso, del Teatro d'Angennes, della Posta.
Per la prima volta nella storia della città, «opaca per i non residenti», ma «traspa–
rente [..
.J
per i suoi abitanti»lO, l'istituzione pubblica dava il suo
imprimatur
ai nomi
delle contrade, «incerti, instabili, fluidi» legati in passato «alla pura comunicazione
verbale», che Amedeo Degrossi, curioso personaggio dalla duplice identità, ignorando
i cambiamenti imposti dai nuovi governanti, non s'era tuttavia peritato di raccogliere
nel
1805
in un originalissimo
Itinerario
per il «volgo», altrimenti incapace di orizzon–
tarsi nella congerie di tante novità
Il.
La toponomastica ricuperata dalla tradizione era ora fissata ben- in vista in «cartelli
color bigio» agli angoli delle contrade che traversavano le città «da mezzoggiorno a
settentrione», e in altri «in color giallo» ai cantoni delle vie che intersecavano le prime
«da ponente a levante»12. La maggior parte delle intitolazioni traeva origine dall'ogget–
to più rilevante affacciato sulla contrada o sulla piazza, un edificio di culto, un'istitu–
zione, un ufficio: contrada della Basilica, del Carmine, della Consolata, della Madonna
degli Angeli, oppure dell'Accademia delle Scienze, dell'Arcivescovado, del Monte di
Pietà, delle Finanze, delle Gabelle, e anche dell'Ospedale, delle Rosine e così via. Altri
toponimi ricalcavano
il
nome pittoresco di gloriosi alberghi attivi e floridi oppure
6
FRANco Rosso,
La
numerazione delle case e la deno–
minazione delle contrade nella Torino napoleonica (1789-
1814),
in «Studi Piemontesi», marzo
1985,
voI. XIV, fase.
l ,
p.
68.
7
ASCT,
Collezione I,
Copialettere, voI.
3,
pp.
21-22:
Pietro Riccati alla Municipalità repubblicana di Torino,
cito in
F. Rosso,
op. cit.,
p.
60.
8
ASCT,
Ragionerie,
1814,
voI.
l ,
pp.
513-520.
9
AUGUSTE CREUZÈ DE LESSER,
Voyage en Italie et en
Sicile f ait en MDCCCI et MDCCCII,
Paris, P . Didot
10
l'Ainé, 1806,
p.
2l.
lO
F. Rosso,
op. cit.,
p.
63.
11
AMEDEO DEGROSSI,
alias
GIOVANNI AMEDEO
GROSSI,
Itinerario per la città di Torino,
Torino,
I.
Soffiet–
ti,
1805.
Sul personaggio e sull'opera in questione si veda
ADAPEYROT,
Sguardi sulla città: guide, almanacchi e vedu–
te,
in GIUSEPPE BRACCO (a cura di),
Ville de Turin 1798-
1814,
Torino, Archivio Storico della Città,
2
voll.,
1990, I,
pp.
392-399.
12
ASCT,
Ragionerie,
1816,
voI.
3,
pp.
489, 496-498.


















