
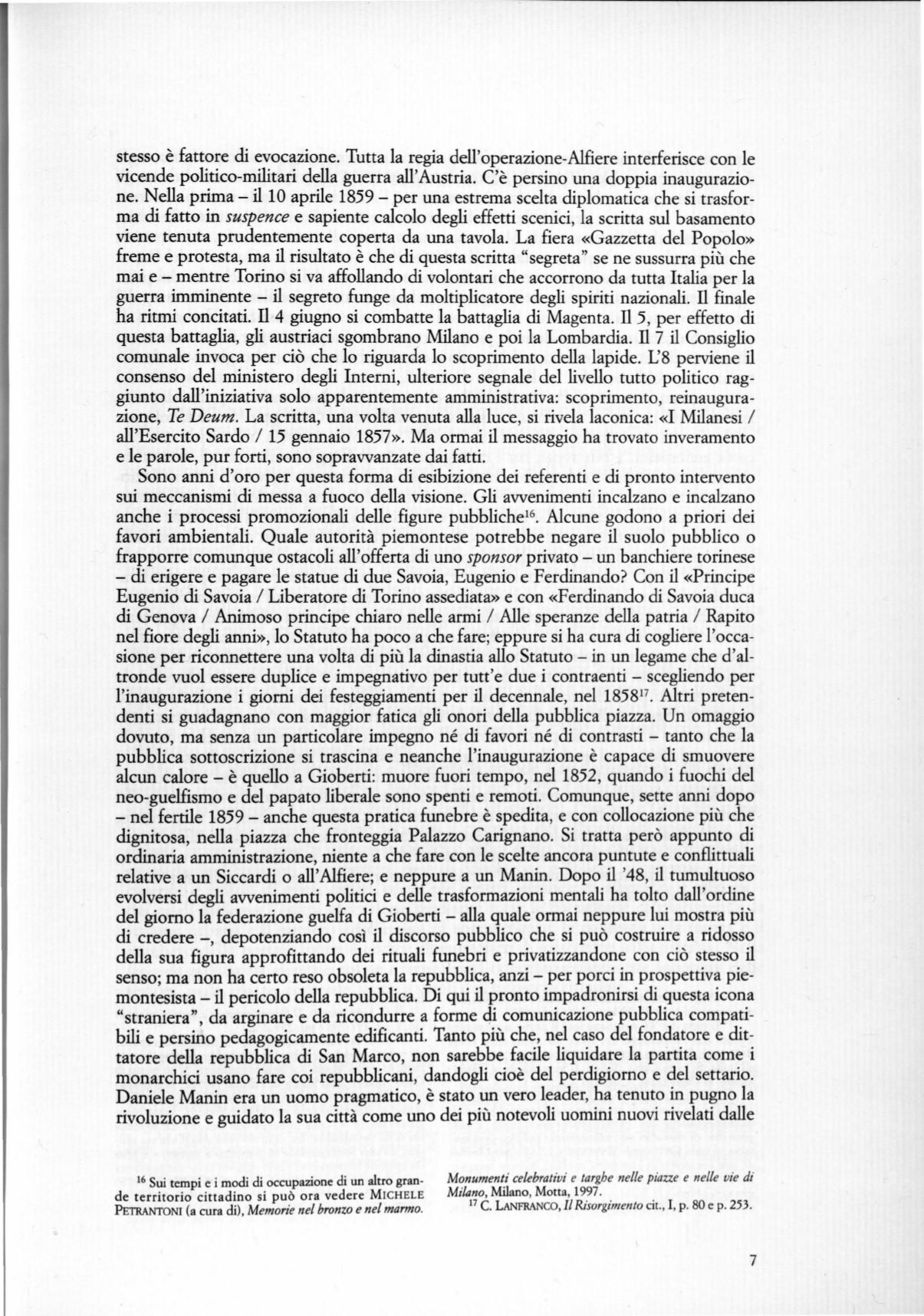
stesso è fattore
di
evocazione. Tutta la regia dell'operazione-Alfiere interferisce con le
vicende politico-militari della guerra all'Austria.
C'è
persino una doppia inaugurazio–
ne. Nella prima - ilIO aprile 1859 - per una estrema scelta diplomatica che si trasfor–
ma di fatto in
suspence
e sapiente calcolo degli effetti scenici, la scritta sul basamento
viene tenuta prudentemente coperta da una tavola. La fiera «Gazzetta del Popolo»
freme e protesta, ma il risultato
è
che di questa scritta "segreta" se ne sussurra più che
mai e - mentre Torino si va affollando di volontari che accorrono da tutta Italia per la
guerra imminente - il segreto funge da moltiplicatore degli spiriti nazionali.
li
finale
ha ritmi concitati.
li
4 giugno si combatte la battaglia di Magenta.
li
5, per effetto di
questa battaglia, gli austriaci sgombrano Milano e poi la Lombardia.
li
7 il Consiglio
comunale invoca per ciò che lo riguarda lo scoprimento della lapide. L'8 perviene il
consenso del ministero degli Interni, ulteriore segnale del livello tutto politico rag–
giunto dall'iniziativa solo apparentemente amministrativa: scoprimento, reinaugura–
zione,
Te Deum.
La scritta, una volta venuta alla luce, si rivela laconica: «I Milanesi /
all'Esercito Sardo / 15 gennaio 1857». Ma ormai il messaggio ha trovato inveramento
e le parole, pur forti, sono sopravvanzate dai fatti.
Sono anni d'oro per questa forma di esibizione dei referenti e di pronto intervento
sui meccanismi di messa a fuoco della visione. Gli avvenimenti incalzano e incalzano
anche i processi promozionali delle figure pubbliche
16 .
Alcune godono a priori dei
favori ambientali. Quale autorità piemontese potrebbe negare il suolo pubblico o
frapporre comunque ostacoli all'offerta di uno
sponsor
privato - un banchiere torinese
- di erigere e pagare le statue di due Savoia, Eugenio e Ferdinando? Con il «Principe
Eugenio
di
Savoia / Liberatore di Torino assediata» e con «Ferdinando di Savoia duca
di Genova / Animoso principe chiaro nelle armi / Alle speranze della patria / Rapito
nel fiore degli anni», lo Statuto ha poco a che fare; eppure si ha cura di cogliere l'occa–
sione per riconnettere una volta
di
più la dinastia allo Statuto - in un legame che d'al–
tronde vuoI essere duplice e impegnativo per tutt'e due i contraenti - scegliendo per
l'inaugurazione i giorni dei festeggiamenti per il decennale, nel 1858
17 •
Altri preten–
denti si guadagnano con maggior fatica gli onori della pubblica piazza. Un omaggio
dovuto, ma senza un particolare impegno né di favori né di contrasti - tanto che la
pubblica sottoscrizione si trascina e neanche l'inaugurazione
è
capace di smuovere
alcun calore -
è
quello a Gioberti: muore fuori tempo, nel 1852, quando i fuochi del
neo-guelfismo e del papato liberale sono spenti e remoti. Comunque, sette anni dopo
- nel fertile 1859 - anche questa pratica funebre è spedita, e con collocazione più che
dignitosa, nella piazza che fronteggia Palazzo Carignano. Si tratta però appunto di
ordinaria amministrazione, niente a che fare con le scelte ancora puntute e conflittuali
relative a un Siccardi o all'Alfiere; e neppure a un Manin. Dopo il '48, il tumultuoso
evolversi degli avvenimenti politici e delle trasformazioni mentali ha tolto dall'ordine
del giorno la federazione guelfa di Gioberti - alla quale ormai neppure lui mostra più
di credere -, depotenziando così il discorso pubblico che si può costruire a ridosso
della sua figura approfittando dei rituali funebri e privatizzandone con ciò stesso il
senso; ma non ha certo reso obsoleta la repubblica, anzi - per porci in prospettiva pie–
montesista - il pericolo della repubblica. Di qui il pronto impadronirsi di questa icona
"straniera", da arginare e da ricondurre a forme qi comunicazione pubblica compati–
bili e persino pedagogicamente edificanti. Tanto più che, nel caso del fondatore e dit–
tatore della repubblica di San Marco, non sarebbe facile liquidare la partita come i
monarchici usano fare coi repubblicani, dandogli cioè del perdigiorno e del settario.
Daniele Manin era un uomo pragmatico, è stato un vero leader, ha tenuto in pugno la
rivoluzione e guidato la sua città come uno dei più notevoli uomini nuovi rivelati dalle
16
Sui tempi e i modi di occupazione di un altro gran–
de territorio cittadino si può ora vedere MICHELE
PETRANTONI (a cura di),
Memorie nel bronzo e nel marmo.
Monumenti celebrativi e targhe nelle piazze e nelle vie di
Milano,
Milano, Motta, 1997.
17
C.
LANFRANCO,
Il Risorgimento
cit.,
I,
p.
80
e p.
253.
7


















