
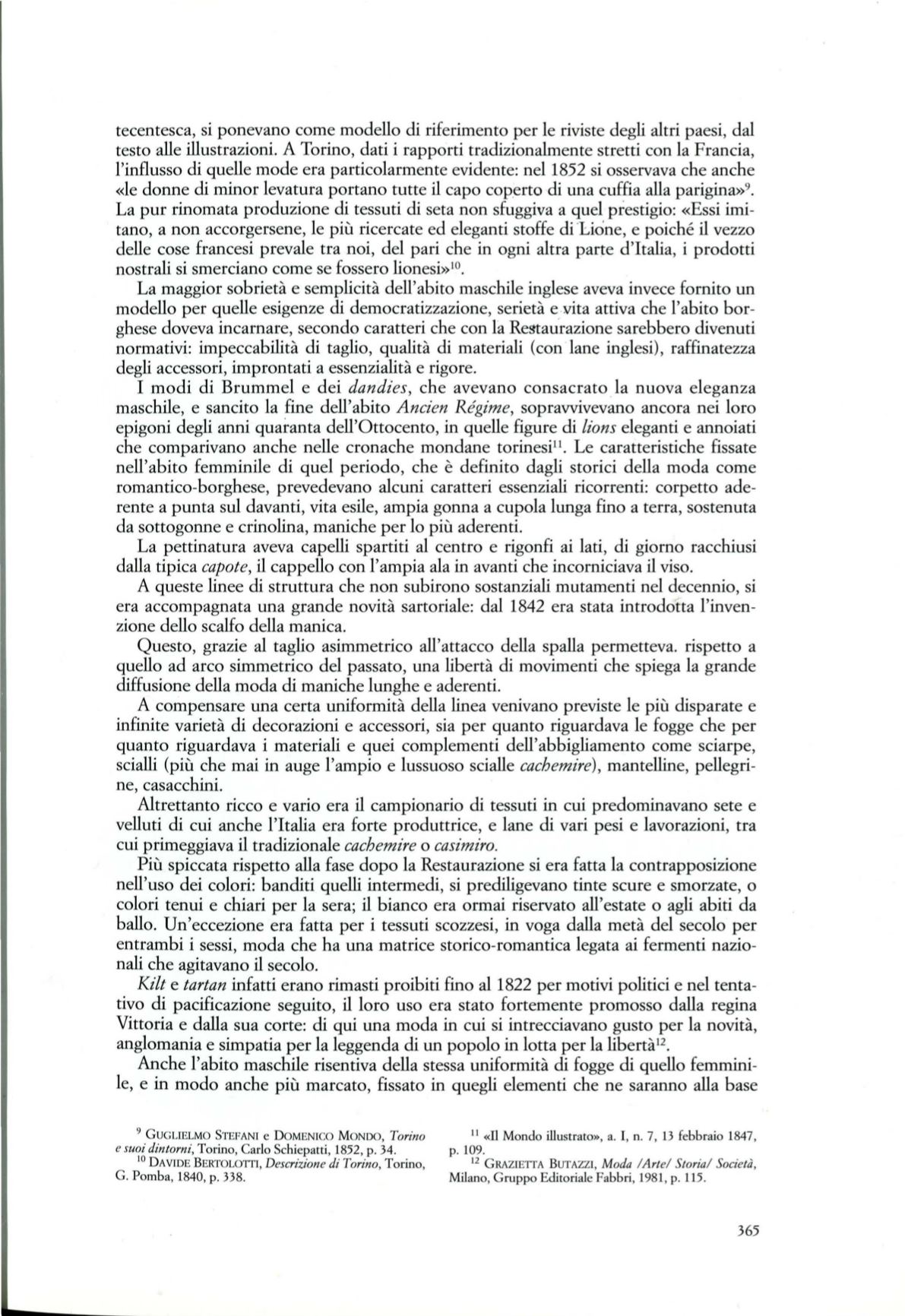
tecentesca, si ponevano come modello di riferimento per le riviste degli altri paesi, dal
testo alle illustrazioni. A Torino, dati i rapporti tradizionalmente stretti con la Francia,
l'influsso di quelle mode era particolarmente evidente: nel
1852
si osservava che anche
«le donne di minor levatura portano tutte il capo coperto di una cuffia alla parigina»9.
La pur rinomata produzione di tessuti di seta non sfuggiva a quel prestigio: «Essi imi–
tano, a non accorgersene, le più ricercate ed eleganti stoffe di Lione, e poiché il vezzo
delle cose francesi prevale tra noi, del pari che in ogni altra parte d'Italia, i prodotti
nostrali si smerciano come se fossero lionesi»lO.
La maggior sobrietà e semplicità dell' abito maschile inglese aveva invece fornito un
modello per quelle esigenze di democratizzazione, serietà evita attiva che l'abito bor–
ghese doveva incarnare, secondo caratteri che con la Regtaurazione sarebbero divenuti
normativi: impeccabilità di taglio, qualità di materiali (con lane inglesi), raffinatezza
degli accessori, improntati a essenzialità e rigore.
I modi di Brummel e dei
dandies
,
che avevano consacratola nuova eleganza
maschile, e sancito la fine dell' abito
Ancien Régime,
sopravvivevano ancora nei loro
epigoni degli anni quaranta dell'Ottocento, in quelle figure di
lions
eleganti e annoiati
che comparivano anche nelle cronache mondane torinesi
ll
.
Le caratteristiche fissate
nell' abito femminile di quel periodo, che è definito dagli storici della moda come
romantico-borghese, prevedevano alcuni caratteri essenziali ricorrenti: corpetto ade–
rente a punta sul davanti, vita esile, ampia gonna a cupola lunga fino a terra, sostenuta
da sottogonne e crinolina, maniche per lo più aderenti.
La pettinatura aveva capelli spartiti al centro e rigonfi ai lati, di giorno racchiusi
dalla tipica
capote,
il cappello con l'ampia ala in avanti che incorniciava il viso.
A queste linee di struttura che non subirono sostanziali mutamenti nel decennio, si
era accompagnata una grande novità sartoriale: dal
1842
era stata introdotta l'inven–
zione dello scalfo della manica.
Questo, grazie al taglio asimmetrico all' attacco della spalla permetteva. rispetto a
quello ad arco simmetrico del passato, una libertà di movimenti che spiega la grande
diffusione della moda di maniche lunghe e aderenti.
A compensare una certa uniformità della linea venivano previste le più disparate e
infinite varietà di decorazioni e accessori, sia per quanto riguardava le fogge che per
quanto riguardava i materiali e quei complementi dell' abbigliamento come sciarpe,
scialli (più che mai in auge l'ampio e lussuoso scialle
cachemire),
mantelline, pellegri–
ne, casacchini.
Altrettanto ricco e vario era il campionario di tessuti in cui predominavano sete e
velluti di cui anche l'Italia era forte produttrice, e lane di vari pesi e lavorazioni, tra
cui primeggiava il tradizionale
cachemire
o
casimiro.
Più spiccata rispetto alla fase dopo la Restaurazione si era fatta la contrapposizione
nell'uso dei colori: banditi quelli intermedi, si prediligevano tinte scure e smorzate, o
colori tenui e chiari per la sera; il bianco era ormai riservato all' estate o agli abiti da
ballo. Un'eccezione era fatta per i tessuti scozzesi, in voga dalla metà del secolo per
entrambi i sessi, moda che ha una matrice storico-romantica legata ai fermenti nazio–
nali che agitavano il secolo.
Kilt
e
tartan
infatti erano rimasti proibiti fino al
1822
per motivi politici e nel tenta–
tivo
di
pacificazione seguito, il loro uso era stato fortemente promosso dalla regina
Vittoria e dalla sua corte: di qui una moda in cui si intrecciavano gusto per la novità,
anglomania e simpatia per la leggenda di un popolo in lotta per la libertà
12 •
Anche l'abito maschile risentiva della stessa uniformità di fogge di quello femmini–
le, e in modo anche più marcato, fissato in quegli elementi che ne saranno alla base
9
GUGLIELMO STEFANI e DOMENICO MONDO,
Torino
e suoi dintorni,
Torino, Carlo Schiepatti, 1852, p. 34.
lO
DAVIDE BERTOLOTTI ,
Descrizione di Torino,
Torino,
G. Pomba, 1840, p. 338.
11
«li
Mondo illustrato», a.
I,
n. 7, 13 febbraio 1847,
p.
lO9.
12
G RAZlETTA BUTAZZI,
Moda /Arte/ Storia/ Società,
Milano, Gruppo Editoriale Fabbri, 1981, p. 115.
365


















