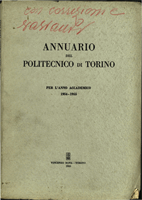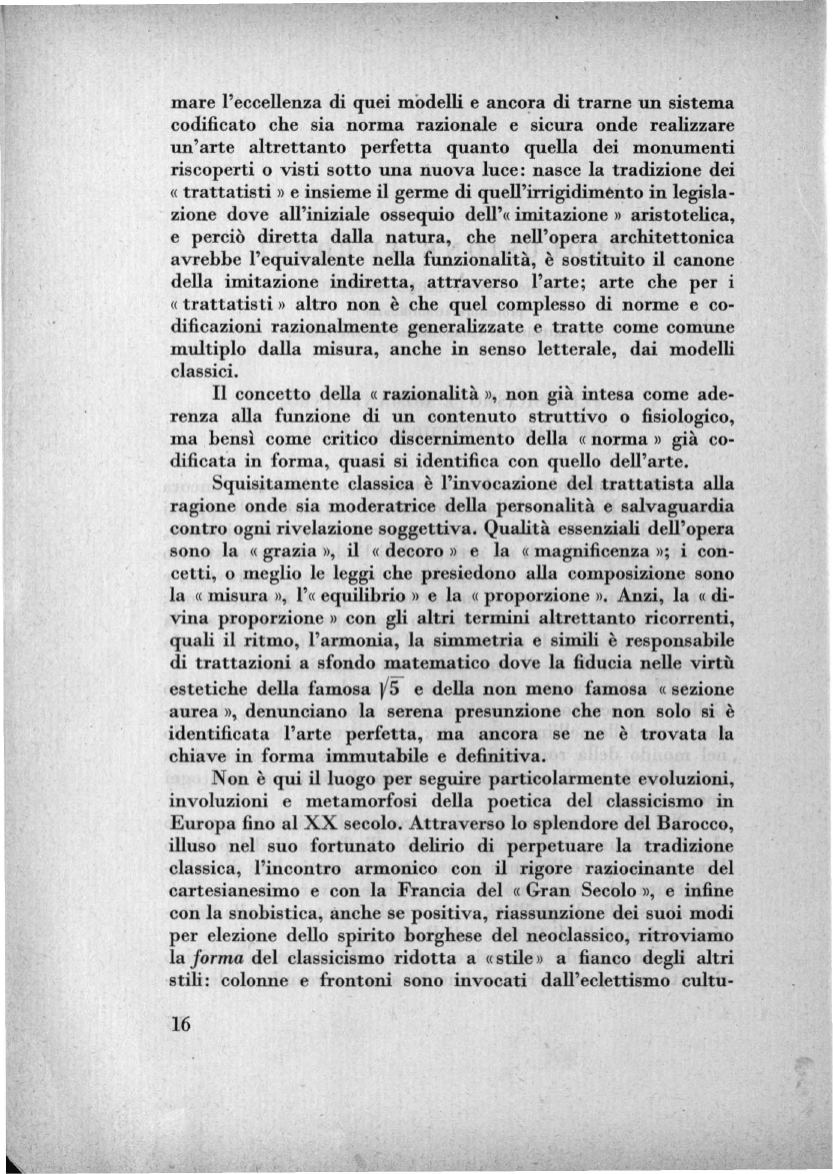
mare l'eccellenza di quei modelli e anco:ra di trarne un sistema
codificato che sia norma razionale e sicura onde realizzare
un'arte altrettanto perfetta quanto quella dei monumenti
riscoperti o visti sotto una nuova luce: nasce la tradizione dei
« trattatisti » e insieme
il
germe di quell'irrigidimento in legisla–
zione dove all'iniziale ossequio dell'« imitazione» aristotelica,
e perciò diretta dalla natura, che nell'opera architettonica
avrebbe l'equivalente nella funzionalità,
è
sostituito
il
canone ·
della imitazione indiretta, attraverso l'arte; arte che per i
« trattatisti » altro non
è
che quel complesso di norme e co–
dificazioni razionalmente generalizzate e tratte come comune
multiplo dalla misura, anche in senso letterale, dai modelli
classici.
Il concetto della « razionalità », non già intesa come ade–
r enza alla funzione di un contenuto struttivo o fisiologico,
ma bensì come critico discernimento della « norma» già co–
dificata in forma , quasi si identifica con quello dell'arte.
,
Squisitamente classica
è
l'invocazione del trattatista alla
ragione onde sia moderatrice della personalità e salvaguardia
contro ogni rivelazione soggettiva. Qualità essenziali dell'opera
sono la « grazia »,
il
« decoro » e la «magnificenza »; i con–
cetti, o meglio le leggi che presiedono alla composizione sono
la «misura », 1'« equilibrio» e la
«
proporzione». Anzi, la
«
di –
vina proporzione » con gli altri termini altrettanto ricorrenti,
quali
il
ritmo, l'armonia, la simmetria e simili
è
responsabile
di trattazioni a sfondo matematico dove la fiducia nelle virtù
estetiche della famosa
YS
e della non meno famosa « sezione
aurea », denunciano la serena presunzione che non solo si
è
identificata l'arte perfetta, ma ancora se ne
è
trovata la
chiave in forma immutabile e definitiva.
Non
è
qui
il
luogo per seguire particolarmente evoluzioni,
involuzioni e metamorfosi della poetica del classicismo in
Europa fino al XX secolo. Attraverso lo splendore del Barocco,
illuso nel suo fortunato delirio di perpetuare la tradizione
classica, l'incontro armonico con
il
rigore raziocinante del
cartesianesimo e con la Francia del
«
Gran Secolo », e infine
con la snobistica, anche se positiva, riassunzione dei suoi modi
per elezione dello spirit o borghese del neoclassico, ritroviamo
la
forma
del cla ssicismo ridotta a
«
stile » a fianco degli altri
'st ili : colonne e frontoni sono invocati dall'eclettismo cultu-
16