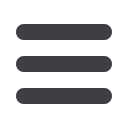
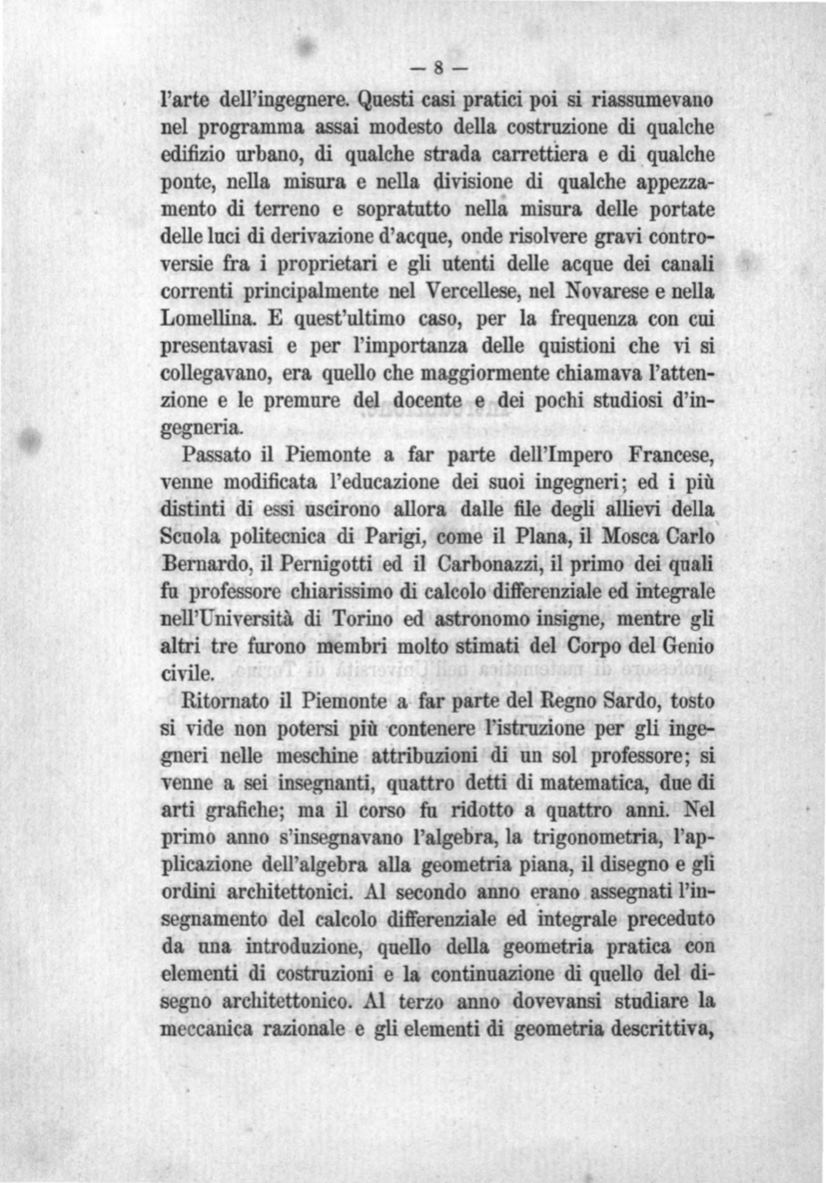
-8-
l'arte dell'ingegnere. Questi casi pratici poi si riassumevano
nel programma assai modesto della costruzione di qualche
edifizio urbano, di qualche strada carrettiera e di .qualche
ponte, nella misura e nella divisione di qualche appezza–
mento di terreno e sopratutto nella misura delle portate
delle luci di derivazione d'acque, onde risolvere gravi contro–
versie fra i proprietari e gli utenti delle acque dei canali
correnti principalmente nel Vercellese, nel Novarese e nella
Lomellina. E quest'ultimo caso, per la frequenza con cui
presentavasi e per l'importanza delle quistioni che vi si
collegavano, era quello che maggiormente chiamava l'atten–
zione e le premure del docente e dei pochi studiosi d'in–
gegneria.
Passato
il
Piemonte a far parte dell'Impero Francese,
venne modificata l'educazione dei suoi ingegneri; ed i più
distinti di essi uscirono allora dalle file degli allievi della
Scuola politecnica di Parigi, come il Plana,
il
Mosca Carlo
Bernardo,
il
Pernigotti ed
il
Carbonazzi,
il
primo dei quali
fu professore chiarissimo di calcolo differenziale ed integrale
nell'Università di Torino ed astronomo insigne, mentre gli
altri tre furono membri molto stimati del Corpo del Genio
civile.
Ritornato
il
Piemonte a· far parte del Regno Sardo, tosto
si vide non potersi più 'contenere l'istruzione per gli inge–
gneri nelle meschine attribuzioni di un sol professore; si
venne a sei insegnanti, quattro detti di matematica, due di
arti grafiche; ma il corso fu ridotto a quattro anni. Nel
primo anno s'insegnavano l'algebra, la trigonometria, l'ap–
plicazione dell'algebra alla geometria piana,
il
disegno e gli
ordini architettonici. Al secondo anno
~rano
assegnati l'in–
segnamento del calcolo differenziale ed integrale preceduto
da una introduzione, quello della geometria pratica con
elementi di costruzioni e la continuazione di quello del di–
segno architettonico. Al terzo anno dovevansi studiare la
meccanica razionale e gli elementi di geometria descrittiva,


















