
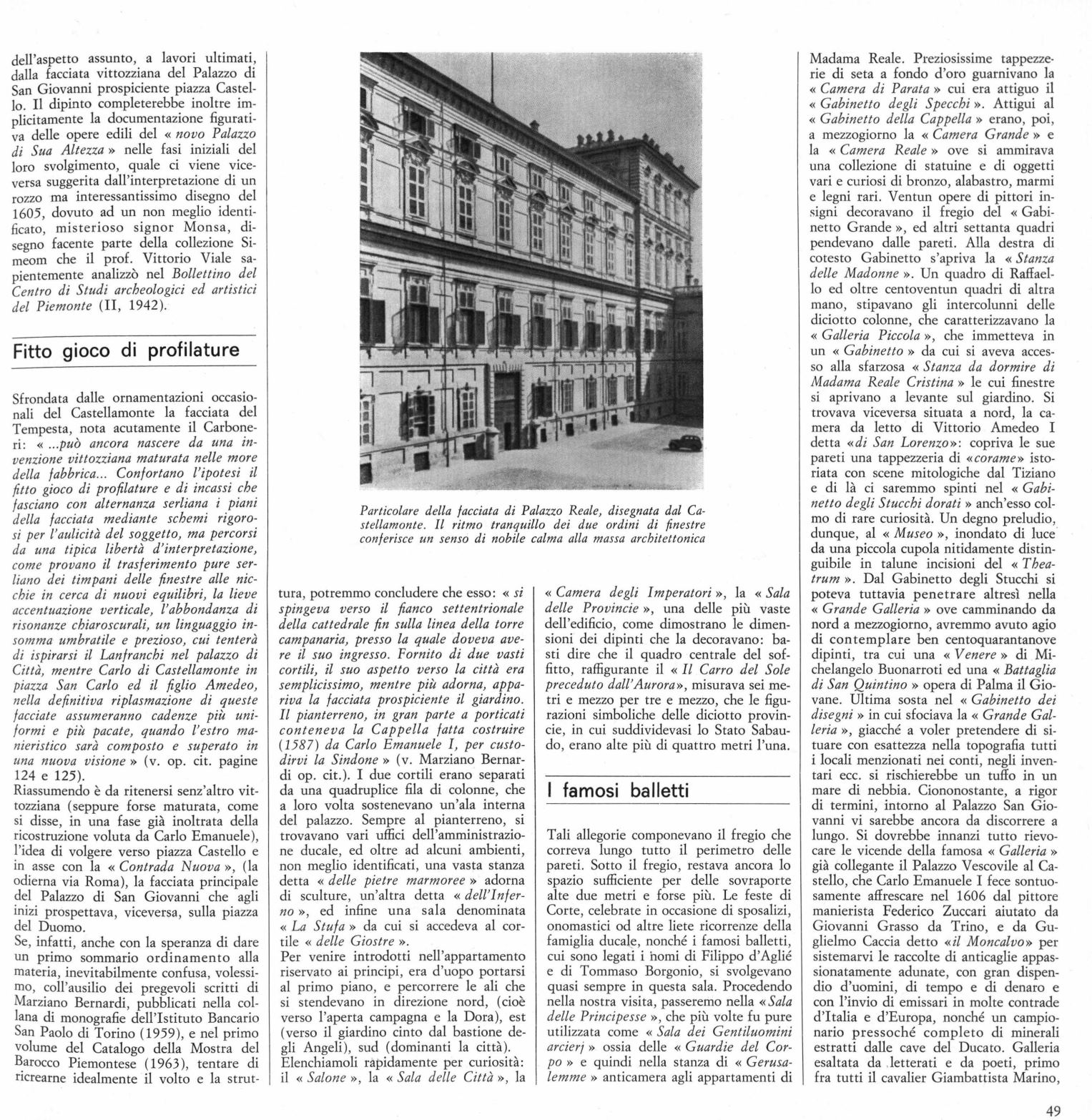
dell'aspetto assunto, a lavori ultimati,
dalla facciata vittozziana del Palazzo di
San Giovanni prospiciente piazza Castel–
lo. Il dipinto completerebbe inoltre im–
plicitamente la documentazione figurati–
va delle opere edili del
« novo Palazzo
di Sua Altezza»
nelle fasi iniziali del
loro svolgimento, quale ci viene vice–
versa suggerita dall'interpretazione di un
rozzo ma interessantissimo disegno del
1605, dovuto ad un non meglio identi–
ficato , misterioso signor Monsa, di–
segno facente parte della collezione Si–
meom che il prof. Vittorio Viale sa–
pientemente analizzò nel
Bollettino del
Centro di Studi archeologici ed artistici
del Piemonte
(II,
1942).
Fitto gioco di profilature
Sfrondata dalle ornamentazioni occasio–
nali del Castellamonte la facciata del
Tempesta, nota acutamente il Carbone–
ri :
« .. .può ancora nascere da una in–
venzione vittozziana maturata nelle more
della fabbrica.. . Confortano l'ipotesi il
fitto gioco di profilature e di incassi che
fasciano con alternanza serliana i piani
della facciata mediante schemi rigoro–
si per l'aulicità del soggetto, ma percorsi
da una tipica libertà d'interpretazione,
come provano il trasferimento pure ser–
liano dei timpani delle finestre alle nic–
chie in cerca di nuovi equilibri, la lieve
accentuazione verticale, l'abbondanza di
risonanze chiaroscurali, un linguaggio in–
somma umbratile e prezioso, cui tenterà
di ispirarsi il Lanfranchi nel palazzo di
Città, mentre Carlo di Castellamonte in
piazza San Carlo ed il figlio Amedeo,
nella definitiva riplasmazione di queste
facciate assumeranno cadenze più uni–
formi e più pacate, quando l'estro ma–
nieristico sarà composto e superato in
una nuova visione»
(v. op. cit. pagine
124
e
125).
Riassumendo è da ritenersi senz'altro vit–
tozziana (seppure forse maturata, come
si disse, in una fase già inoltrata della
ricostruzione voluta da Carlo Emanuele),
l'idea di volgere verso piazza Castello e
in asse con la
«Contrada Nuova
»,
(la
odierna via Roma), la facciata principale
del Palazzo di San Giovanni che agli
inizi prospettava, viceversa, sulla piazza
del Duomo.
Se, infatti, anche con la speranza di dare
un primo sommario ordinamento alla
materia, inevitabilmente confusa, volessi–
mo, coll'ausilio dei pregevoli scritti di
Marziano Bernardi, pubblicati nella col–
lana di monografie dell'Istituto Bancario
San Paolo di Torino (1959), e nel primo
volume del Catalogo della Mostra del
Barocco Piemontese (1963), tentare di
ricrearne idealmente il volto e la strut-
Particolare della facciata di Palazzo Reale, disegnata dal Ca–
stellamonte. Il ritmo tranquillo dei due ordini di finestre
conferisce un senso di nobile calma alla massa architettonica
tura, potremmo concludere che esso:
«si
spingeva verso il fianco settentrionale
della cattedrale fin sulla linea della torre
campanaria, presso la quale doveva ave–
re il suo ingresso. Fornito di due vasti
cortili, il suo aspetto verso la città era
semplicissimo, mentre più adorna, appa–
riva la facciata prospiciente il giardino.
I!
pianterreno, in gran parte a porticati
conteneva la Cappella fatta costruire
(1587)
da Carlo Emanuele I, per custo–
dirvi la Sindone»
(v. Marziano Bernar–
di op. cit.). I due cortili erano separati
da una quadruplice fila di colonne, che
a loro volta sostenevano un'ala interna
del palazzo. Sempre al pianterreno, si
trovavano vari uffici dell'amministrazio–
ne ducale , ed oltre ad alcuni ambienti,
non meglio identificati, una vasta stanza
detta
«delle pietre marmoree»
adorna
di sculture, un'altra detta
« dell'Infer–
no
»,
ed infine una sala denominata
«
La Stufa »
da cui si accedeva al cor–
tile
«
delle Giostre
».
Per venire introdotti nell'appartamento
riservato ai principi, era d'uopo portarsi
al primo piano, e percorrere le ali che
si stendevano in direzione nord , (cioè
verso l'aperta campagna e la Dora), est
(verso
il
giardino cinto dal bas tione de–
gli Angeli), sud (dominanti la città).
Elenchiamoli rapidamente per curiosità:
il
« Salone
»,
la
« Sala delle Città
»,
la
« Camera degli Imperatori
»,
la
«Sala
delle Provincie
»,
una delle più vaste
dell'edificio, come dimostrano le dimen–
sioni dei dipinti che la decoravano: ba–
sti dire che il quadro centrale del sof–
fitto, raffigurante il
«
I!
Carro del Sole
preceduto dall'Aurora» ,
misurava sei me–
tri e mezzo per tre e mezzo, che le figu–
razioni simboliche delle diciotto provin–
cie, in cui suddividevasi lo Stato Sabau–
do, erano alte più di quattro metri l'una.
I famosi ballett i
Tali allegorie componevano il fregio che
correva lungo tutto il perimetro delle
pareti. Sotto il fregio , restava ancora lo
spazio sufficiente per delle sovraporte
alte due metri e forse più. Le feste di
Corte, celebrate in occasione di sposalizi,
onomastici od altre liete ricorrenze della
famiglia ducale, nonché i famosi balletti,
cui sono legati i homi di Filippo d'Aglié
e di Tommaso Borgonio, si svolgevano
quasi sempre in questa sala. Procedendo
nella nostra visita, passeremo nella
«Sala
delle Principesse
»,
che più volte fu pure
utilizzata come
« Sala dei Gentiluomini
arcierj »
ossia delle
«Guardie del Cor–
po »
e quindi nella stanza di
«
Gerusa–
lemme»
anticamera agli appartamenti di
Madama Reale. Preziosissime tappezze·
rie di seta a fondo d'oro guarnivano la
«
Camera di Parata»
cui era attiguo
il
« Gabinetto degli Specchi
».
Attigui al
«
Gabinetto della Cappella»
erano, poi,
a mezzogiorno la «
Camera Grande»
e
la
« Camera Reale»
ove si ammirava
una collezione di statuine e di oggetti
vari e curiosi di bronzo, alabastro, marmi
e legni rari. Ventun opere di pittori in–
~igni
decoravano il fregio del « Gabi–
netto Grande
»,
ed altri settanta quadri
pendevano dalle pareti. Alla destra di
cotesto Gabinetto s'apriva la
« Stanza
delle Madonne
» .
Un quadro di Raffael–
lo ed oltre centoventun quadri di altra
mano, stipavano gli intercolunni delle
diciotto colonne, che caratterizzavano la
« Galleria Piccola
»,
che immetteva in
un
«Gabinetto»
da cui si aveva acces–
so alla sfarzosa
« Stanza da dormire di
Madama Reale Cristina »
le cui finestre
si aprivano a levante sul giardino. Si
trovava viceversa situata a nord, la ca–
mera da letto di Vittorio Amedeo I
detta
«di San Lorenzo»:
copriva le sue
pareti una tappezzeria di
«corame»
isto–
riata con scene mitologiche dal Tiziano
e di là ci saremmo spinti nel
«Gabi–
netto degli Stucchi dorati »
anch'esso col–
mo di rare curiosità. Un degno preludio,
dunque, al
«Museo
»,
inondato di luce'
da una piccola cupola nitidamente distin–
guibile in talune incisioni del
«Thea–
trum
».
Dal Gabinetto degli Stucchi si
poteva tuttavia penetrare altresl nella
«
Grande Galleria»
ove camminando da
nord a mezzogiorno, avremmo avuto agio
di contemplare ben centoquarantanove
dipinti , tra cui una
«Venere»
di Mi–
chelangelo Buonarroti ed una «
Battaglia
di San Quintino
»
opera di Palma il Gio–
vane. Ultima sosta nel
«Gabinetto dei
disegni»
in cui sfociava la
«
Grande Gal–
leria
»,
giacché a voler pretendere di si–
tuare con esattezza nella topografia tutti
i locali menzionati nei conti, negli inven–
tari ecc. si rischierebbe un tuffo in un
mare di nebbia. Ciononostante, a rigor
di termini, intorno al Palazzo San Gio–
vanni vi sarebbe ancora da discorrere a
lungo. Si dovrebbe innanzi tutto rievo–
care le vicende della famosa «
Galleria »
già collegante il Palazzo Vescovile al Ca–
stello, che Carlo Emanuele I fece sontuo–
samente affrescare nel 1606 dal pittore
manierista Federico Zuccari aiutato da
Giovanni Grasso da Trino, e da Gu–
glielmo Caccia detto
«il Moncalvo »
per
sistemarvi le raccolte di anticaglie appas–
sionatamente adunate , con gran dispen–
dio d'uomini, di tempo e di denaro e
con l'invio di emissari in molte contrade
d'Italia e d'Europa, nonché un campio–
nario pressoché completo di minerali
estratti dalle cave del Ducato. Galleria
esaltata da .letterati e da poeti, primo
fra tutti il cavalier Giambattista Marino ,
49


















