
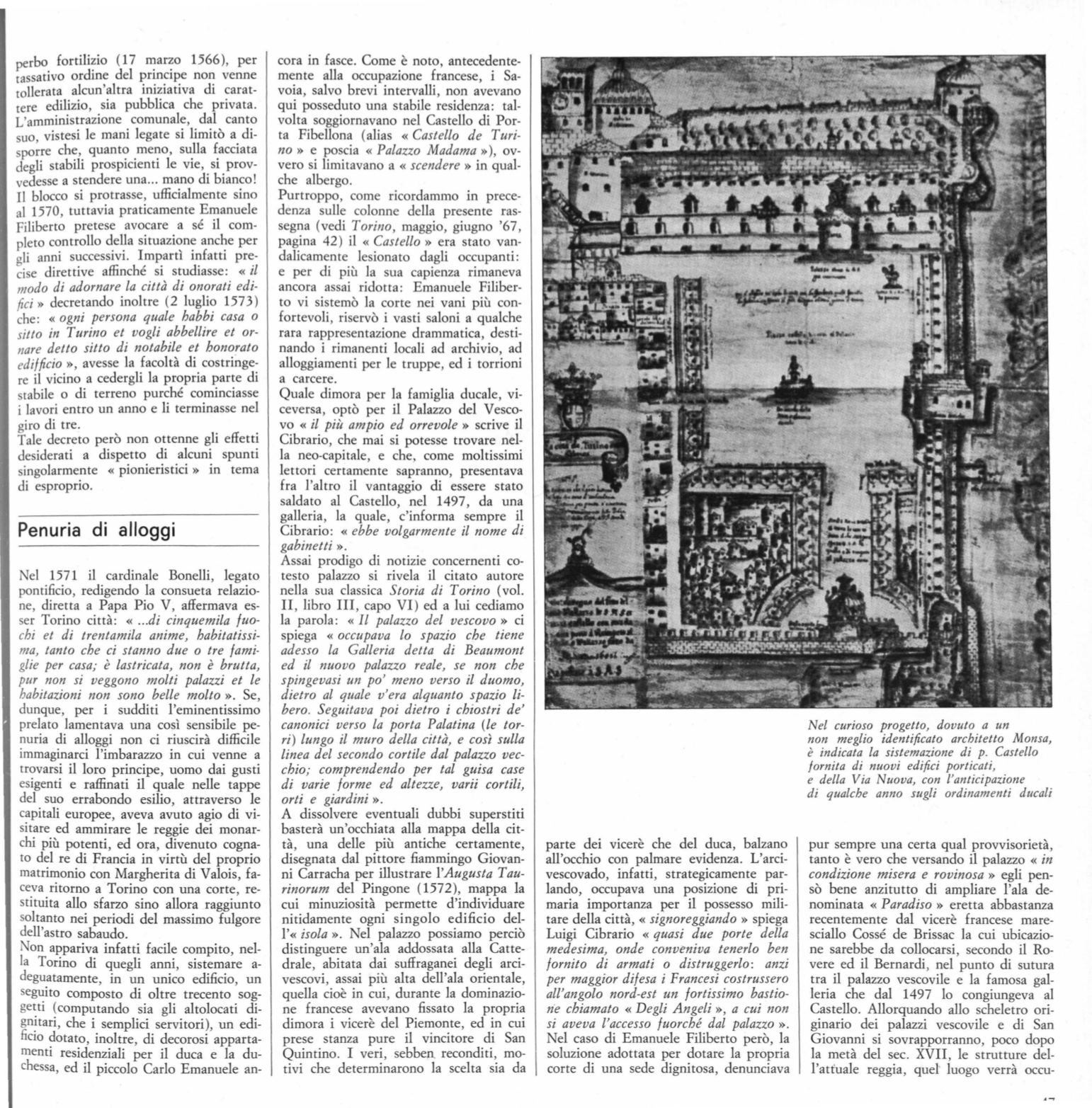
perbo
fortili~io
(17
~ar~o
1566), per
tassativo ordme del pnnclpe non venne
tollerata alcun'altra iniziativa di carat–
tere edilizio, sia pubblica che privata.
L'amministrazione comunale, dal canto
suo vistesi le mani legate si limitò a di–
spo~re
ch:,. quant? .mer:o, su.ila
~acciata
degli stabll1 prospiCienti le Vie,
SI
prov–
vedesse a stendere una... mano di bianco!
Il blocco si protrasse, ufficialmente sino
al 1570, tuttavia praticamente Emanuele
Filiberto pretese avocare a sé
il
com–
pleto controllo della situazione anche per
oli anni successivi. Impartì infatti pre–
~ise
direttive affinché si studiasse:
« il
modo di adornare la città di onorati edi·
fici»
decretando inoltre (2 luglio 1573)
che :
«ogni persona quale habbi casa o
sitto in Turino et vogli abbellire et or–
nare detto sitto di notabile et honorato
edifficio
», avesse la facoltà di costringe–
re
il
vicino a cedergli la propria parte di
stabile o di terreno purché cominciasse
i lavori entro un anno e li terminasse nel
giro di tre.
TaIe decreto però non ottenne gli effetti
desiderati a dispetto di alcuni spunti
singolarmente «pionieristici» in tema
di esproprio.
Penuria di alloggi
Nel 1571
il
cardinale Bonelli, legato
pontificio, redigendo la consueta relazio–
ne, diretta a Papa Pio V, affermava es–
ser Torino città:
« ...di cinquemila fuo–
chi et di trentamila anime, habitatissi–
ma, tanto che
ci
stanno due o tre fami·
glie per casa;
è
lastricata, non
è
brutta,
pur non si veggono molti palazzi et le
habitazioni non sono belle molto
».
Se,
dunque, per i sudditi l'eminentissimo
prelato lamentava una così sensibile pe–
nuria di alloggi non ci riuscirà difficile
immaginarci l'imbarazzo in cui venne a
trovarsi
il
loro principe, uomo dai gusti
esigenti e raffinati
il
quale nelle tappe
del suo errabondo esilio, attraverso le
capitali europee, aveva avuto agio di vi–
sitare ed ammirare le reggie dei monar–
chi più potenti, ed ora, divenuto cogna–
to del re di Francia in virtù del proprio
matrimonio con Margherita di Valois, fa–
ceva ritorno a Torino con una corte, re–
stituita allo sfarzo sino allora raggiunto
soltanto nei periodi del massimo fulgore
dell'astro sabaudo.
Non appariva infatti facile compito, nel–
la Torino di quegli anni, sistemare a–
deguatamente, in un unico edificio, un
seguito composto di oltre trecento sog–
getti (computando sia gli altolocati di–
gn~tari,
che i semplici servitori), un edi–
ficIO dotato, inoltre, di decorosi apparta–
menti residenziali per
il
duca e la du–
chessa, ed il piccolo Carlo Emanuele an-
cora in fasce. Come è noto, antecedente–
mente alla occupazione francese, i Sa–
voia, salvo brevi intervalli, non avevano
qui posseduto una stabile residenza: tal–
volta soggiornavano nel Castello di Por–
ta Fibellona (alias
«Castello de Turi–
no
» e poscia «
Palazzo Madama»),
ov–
vero si limitavano a «
scendere»
in qual–
che albergo.
Purtroppo, come ricordammo in prece–
denza sulle colonne della presente ras–
segna (vedi
Torino,
maggio, giugno '67,
pagina
42)
il «
Castello»
era stato van–
dalicamente lesionato dagli occupanti:
e per di più la sua capienza rimaneva
ancora assai ridotta : Emanuele Filiber–
to vi sistemò la corte nei vani più con–
fortevoli , riservò i vasti saloni a qualche
rara rappresentazione drammatica, desti–
nando i rimanenti locali ad archivio, ad
alloggiamenti per le truppe, ed i torrioni
a carcere.
Quale dimora per la famiglia ducale, vi–
ceversa, optò per
il
Palazzo del Vesco–
vo
«
il più ampio ed orrevole
»
scrive il
Cibrario, che mai si potesse trovare nel–
la neo·capitale, e che. come moltissimi
lettori certamente sapranno, presentava
fra l'altro
il
vantaggio di essere stato
saldato al Castello, nel 1497, da una
galleria, la quale, c'informa sempre il
Cibrario :
«ebbe volgarmente il nome di
gabinetti
».
Assai prodigo di notizie concernenti co–
testo palazzo si rivela
il
citato autore
nella sua classica
Storia di T orino
(voI.
II, libro III, capo VI) ed a lui cediamo
la parola:
« Il palazzo del vescovo»
ci
spiega
«occupava lo spazio che tiene
adesso la Galleria detta di Beaumont
ed il nuovo palazzo reale, se non che
spingevasi un po' meno verso il duomo,
dietro al quale v'era alquanto spazio li–
bero. Seguitava poi dietro i chiostri de'
canonici verso la porta Palatina (le tor–
ri) lungo il muro della città, e così sulla
linea del secondo cortile dal palazzo vec–
chio; comprendendo per tal guisa case
di varie forme ed altezze, varii cortili,
orti e giardini
».
A dissolvere eventuali dubbi superstiti
basterà un'occhiata alla mappa della cit–
tà , una delle più antiche certamente,
disegnata dal pittore fiammingo Giovan–
ni Carracha per illustrare
l'Augusta Tau–
rinorum
del Pingone (1572), mappa la
cui minuziosità permette d'individuare
nitidamente ogni singolo edificio del-
1'« isola
».
Nel palazzo possiamo perciò
distinguere un'ala addossata alla Catte–
drale, abitata dai suffraganei degli arci–
vescovi, assai più alta dell'ala orientale,
quella cioè in cui, durante la dominazio–
ne francese avevano fissato la propria
dimora
i
vicerè del Piemonte, ed in cui
prese stanza pure il vincitore di San
Quintino. I veri, sebben reconditi, mo–
tivi che determinarono la scelta sia da
parte dei vicerè che del duca, balzano
all'occhio con palmare evidenza. L'arci–
vescovado, infatti, strategicamente par–
lando, occupava una posizione di pri–
maria importanza per il possesso mili–
tare della città, «
signoreggiando
»
spiega
Luigi Cibrario
«quasi due porte della
medesima, onde conveniva tenerlo ben
fornito di armati o distruggerlo: anzi
per maggior difesa i Francesi costrussero
all'angolo nord-est un fortissimo bastio–
né chiamato «Degli Angeli
»,
a cui non
si aveva l'accesso fuorché dal palazzo
».
Nel caso di Emanuele Filiberto però, la
soluzione adottata per dotare la propria
corte di una sede dignitosa, denunciava
Nel curioso progetto, dovuto a un
non meglio identificato architetto Monsa,
è
indicata la sistemazione di p. Castello
fornita di nuovi edifici porticati,
e della Via Nuova, con l'anticipazione
di qualche anno sugli ordinamenti ducali
pur sempre una certa qual provvisorietà,
tanto è vero che versando
il
palazzo
«
in
condizione misera e rovinosa»
egli pen–
sò bene anzitutto di ampliare l'ala de–
nominata
«
Paradiso»
eretta abbastanza
recentemente dal vicerè francese mare–
sciallo Cossé de Brissac la cui ubicazio–
ne sarebbe da collocarsi, secondo
il
Ro–
vere ed
il
Bernardi, nel punto di sutura
tra il palazzo vescovile e la famosa gal–
leria che dal 1497 lo congiungeva al
Castello. Allorquando allo scheletro ori–
ginario dei palazzi vescovile e di San
Giovanni si sovrapporranno, poco dopo
la metà del sec. XVII, le strutture del–
l'attuale reggia, quel luogo verrà occu-


















