
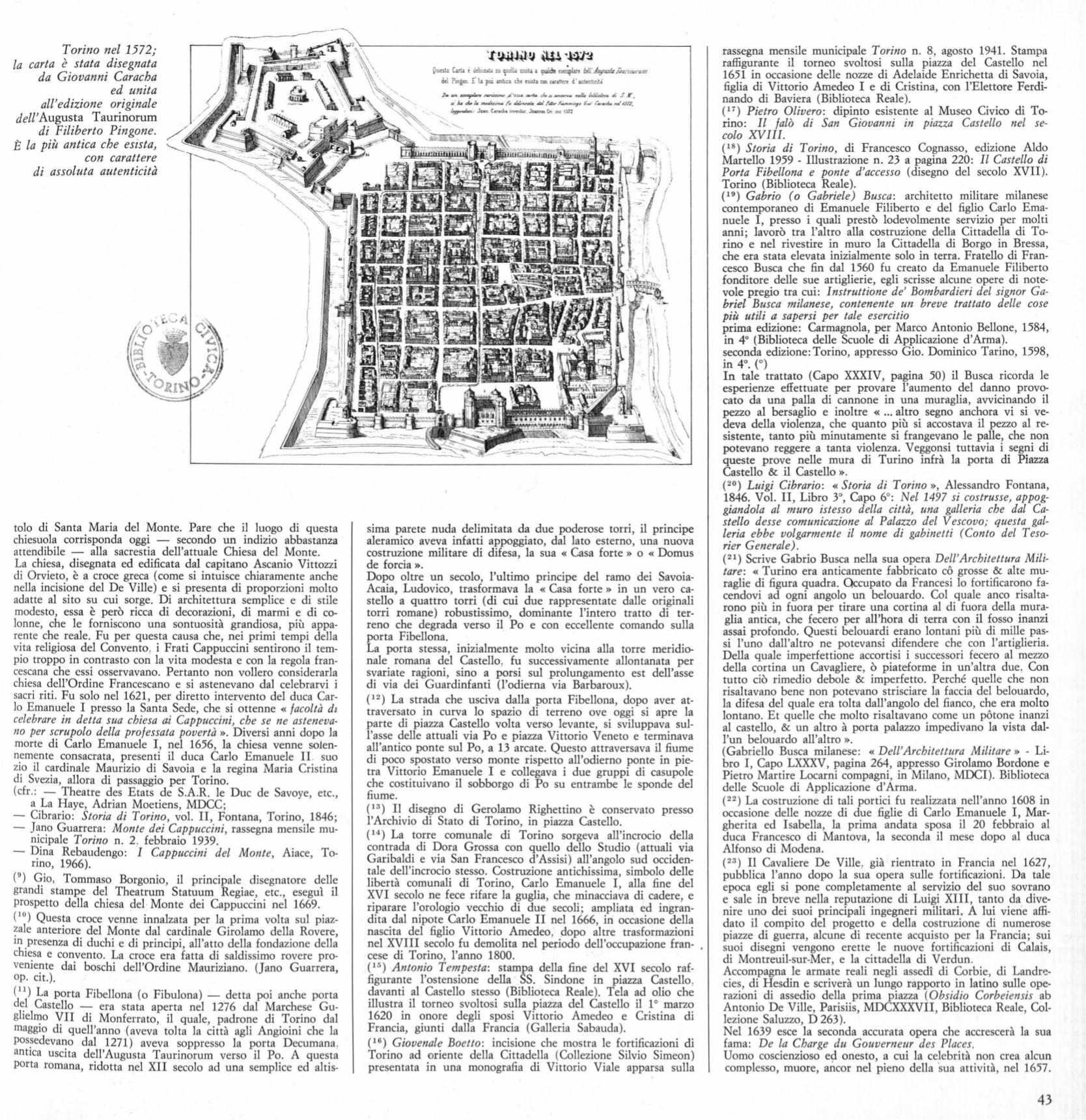
Torino nel 1572;
la carta
è
stata disegnata
da Giovanni Caracha
ed unita
all'edizione originale
dell'Augusta
Taurinorum
di Filiberto Pingone.
È
la più antica che esista,
con carattere
di assoluta autenticità
tolo di Santa Maria del Monte. Pare che il luogo di questa
chiesuola corrisponda oggi - secondo un indizio abbastanza
attendibile - alla sacrestia dell'attuale Chiesa del Monte.
La chiesa, disegnata ed edificata dal capitano Ascanio Vittozzi
di Orvieto,
è
a croce greca (come si intuisce chiaramente anche
nella incisione del De Ville) e si presenta di proporzioni molto
adatte al sito su cui sorge. Di architettura semplice e di stile
modesto, essa
è
però ricca di decorazioni, di marmi e di co–
lonne, che le forniscono una sontuosità grandiosa, più appa–
rente che reale. Fu per questa causa che, nei primi tempi della
vita religiosa del Convento, i Frati Cappuccini sentirono il tem–
pio troppo in contrasto con la vita modesta e con la regola fran–
cescana che essi osservavano. Pertanto non vollero considerarla
chiesa dell'Ordine Francescano e si astenevano dal celebrarvi i
sacri riti. Fu solo nel 1621, per diretto intervento del duca Car–
lo Emanuele I presso la Santa Sede, che si ottenne
«
facoltà di
celebrare in detta sua chiesa ai Cappuccini, che se ne asteneva–
no per scrupolo della professata povertà
». Diversi anni dopo la
morte di Carlo Emanuele I, nel 1656, la chiesa venne
solen–
nemente consacrata, presenti il duca Carlo Emanuele II . suo
zio il cardinale Maurizio di Savoia e la regina Maria Cristina
di Svezia, allora di passaggio per Torino.
(cfr.: - Theatre des Etats de S.A.R. le Due de Savoye, etc.,
a La Haye, Adrian Moetiens, MDCC;
- Cibrario:
Storia di Torino,
voI. II, Fontana, Torino, 1846;
- Jano Guarrera:
Monte dei Cappuccini,
rassegna mensile mu-
nicipale
Torino
n. 2, febbraio 1939.
- Dina Rebaudengo:
I Cappuccini del Monte,
Aiace, To-
rino, 1966).
(9)
Gio, Tommaso Borgonio, il principale disegnatore delle
grandi stampe del Theatrum Statuum Regiae, etc., esegui il
prospetto della chiesa del Monte dei Cappuccini nel 1669.
(l0 )
Questa croce
ven~e
innalzata per la prima volta sul piaz–
zale anteriore del Monte dal cardinale Girolamo della Rovere,
in .presenza di duchi e di principi, all'atto della fondazione della
chIesa e convento. La croce era fatta di saldissimo rovere pro–
veniente dai boschi dell'Ordine Mauriziano. (Jano Guarrera,
op. cit.).
(Il)
La porta Fibellona (o Fibulona) - detta poi anche porta
d~l
Castello - era stata aperta nel 1276 dal Marchese Gu–
ghelll?o VII di Monferrato, il quale, padrone di Torino dal
maggIo di quell'anno (aveva tolta la città agli Angioini che la
pos~edevano
dal 1271) aveva soppresso la porta Decumana,
antIca uscita dell'Augusta Taurinorum verso il Po. A questa
porta romana, ridotta nel XII secolo ad una semplice ed altis-
Olltsta Carla
t
dtlill~liI
SII
qudl~
Ulula
a.
qtljldl!
m~lm
dill'
Ato/UJltllDllmUlI"II1Il
del Pingclt
r
la
piÙ
antica. che
emla
con
carathrt
d'
lulenlltlli
~&.IV~.......,..,.,.
,.,.iu......
j/'~u
..
0."''''
d,."
_,V'_
"di..
4.(1""",,,
""
S K ,
,/M "'"
,&
"'~-'WmD.
/u
"..tIlU&
"'"
'ihr
r.:.u...,,,,~,
C..,,
('
~
n,/
IJf1',
....,
~~""
JUII
C.r&~h
in..ntor Joan_Cn mC 1!l12
-'''----
sima parete nuda delimitata da due poderose torri, il principe
aleramico aveva infatti appoggiato, dal lato esterno, una nuova
costruzione militare di difesa, la sua « Casa forte» o
«
Domus
de forcia ».
Dopo oltre un secolo, l'ultimo principe del ramo dei Savoia–
Acaia Ludovico trasformava la «Casa forte » in un vero ca–
stello' a quattro' torri (di cui due rappresentate dalle originali
torri romane) robustissimo, dominante l'intero tratto di ter–
reno che degrada verso il Po e con eccellen te comando sulla
porta Fibellona.
La porta stessa, inizialmente molto vicina alla torre meridio–
nale romana del Castello. fu successivamente allontanata per
svariate ragioni, sino a porsi sul prolungamento est dell'asse
di via dei Guardinfanti (l'odierna via Barbaroux).
(12)
La strada che usciva dalla porta Fibellona, dopo aver at–
traversato in curva lo spazio di terreno ove oggi si apre la
parte di piazza Castello volta verso levante, si sviluppava sul–
l'asse delle attuali via Po e piazza Vittorio Veneto e terminava
all'antico ponte sul Po, a
13
arcate. Questo attraversava il fiume
di poco spostato verso monte rispetto all'odierno ponte in pie–
tra Vittorio Emanuele I e collegava i due gruppi di casupole
che costituivano il sobborgo di Po su entrambe le sponde del
fiume.
(13)
Il
disegno di Gerolamo Righettino è conservato presso
l'Archivio di Stato di Torino, in piazza Castello.
(14)
La torre comunale di Torino sorgeva all'incrocio della
contrada di Dora Grossa con quello dello Studio (attuali via
Garibaldi e via San Francesco d'Assisi) all'angolo sud occiden–
tale dell'incrocio stesso. Costruzione antichissima, simbolo delle
libertà comunali di Torino, Carlo Emanuele I, alla fine del
XVI secolo ne fece rifare la guglia, che minacciava di cadere, e
riparare l'orologio vecchio di due secoli; ampliata
~d
ingran–
dita dal nipote Carlo Emanuele II nel 1666, in occasione della
nascita del figlio Vittorio Amedeo, popo altre trasformazioni
nel XVIII secolo fu demolita nel periodo dell'occupazione fran–
cese di Torino, l'anno 1800.
(1 5)
Antonio Tempesta:
stampa della fine del XVI secolo raf–
figurante l'astensione della SS. Sindone in piazza Castello,
davanti al Castello stesso (Biblioteca Reale). Tela ad olio che
illustra il torneo svoltosi sulla piazza del Castello il 1° marzo
1620 in onore degli sposi Vittorio Amedeo e Cristina di
Francia, giunti dalla Francia (Galleria Sabauda).
(16)
Giovenale Boetto:
incisione che mostra le fortificazioni di
Torino ad oriente della Cittadella (Collezione Silvio Simeon)
presentata in una monografia di Vittorio Viale apparsa sulla
rassegna mensile municipale
Torino
n. 8, agosto 1941. Stampa
raffigurante il torneo svoltosi sulla piazza del Castello nel
1651 in occasione delle nozze di Adelaide Enrichetta di Savoia,
figlia di Vittorio Amedeo I e di Cristina, con l'Elettore Ferdi–
nando di Baviera (Biblioteca Reale).
(17)
Pietro Olivero:
dipinto esistente al Museo Civico di To–
rino:
Il falò di San Giovanni in piazza Castello nel se–
colo XVIII.
(18)
Storia di Torino,
di Francesco Cognasso, edizione
Ald~
Martello 1959 - Illustrazione n. 23 a pagina 220:
Il Castello dt
Porta Fibellona e ponte d'accesso
(disegno del secolo XVII).
Torino (Biblioteca Reale).
(19)
Gabrio (o Gabriele) Busca:
architetto militare milanese
contemporaneo di Emanuele Filiberto e del figlio Carlo Ema–
nuele I, presso i quali prestò lodevolmente ser:-izio per
~olti
anni; lavorò tra l'altro alla costruzione della Cittadella dI To–
rino e nel rivestire in muro la Cittadella di Borgo in Bressa,
che era stata elevata inizialmente solo
in
terra. Fratello di Fran–
cesco Busca che fin dal 1560 fu creato da Emanuele Filiberto
fonditore delle sue artiglierie, egli scrisse alcune opere di note–
vole pregio tra cui:
Instruttione de' Bombardieri del signor Ga–
briel Busca milanese, contenente un breve trattato delle cose
più utili a sapersi per tale esercitio
.
prima edizione: Carmagnola, per Marco Antolllo Bellone, 1584,
in 4° (Biblioteca delle Scuole di Applicazione d'Arma).
seconda edizione: Torino, appresso Gio. Dominico Tarino, 1598,
in 4°.
(0)
In tale trattato (Capo XXXIV, pagina 50) il Busca ricorda le
esperienze effettuate per provare l'aumento del danno provo–
cato da una palla di cannone in una muraglia,
avvicin.an?oil
pezzo al bersaglio e inoltre
« ...
altro segno anchora
VI
SI ve–
deva della violenza, che quanto più si accostava il pezzo al re–
sistente, tanto più minutamente si frangeva.t;lo le
p~lle?
che
?o~
potevano reggere a tanta violenza. Veggonsl tuttavIa I seglll dI
queste prove nelle mura di Turino infrà la porta di Piazza
Castello
&
il Castello ».
(20)
Luigi Cibrario: «Storia di Torino
»,
Alessandro Fontana,
1846. VoI. II, Libro 3°, Capo 6°:
Nel
1497
si costrusse, appog–
giandola al muro istesso della città, una galleria che dal Ca–
stello desse comunicazione al Palazzo del Vescovo; questa gal–
leria ebbe volgarmente il nome di gabinetti (Conto del Teso–
rier Generale).
(21)
Scrive Gabrio Busca nella sua opera
Dell'Architettura Mili–
tare:
«
Turino era anticamente fabbricato co grosse
&
alte mu–
raglie di figura quadra. Qccupato da Francesi lo fortificaro?o fa–
cendovi ad ogni angolo un belouardo. Col quale anco nsalta–
rono più in fuora per tirare
u~a
corti.naal di
fuo.radella .mura:
glia antica, che fecero per alI hora di terra
c~:m. ~
f?sso manzi
assai profondo. Questi belouardi erano lontalll plU di mIlle pas–
si l'uno dall'altro ne potevansi difendere che con l'artiglieria.
Della quale imperfettione accortisi i successori fecero al mezzo
della cortina un Cavagliere, ò piateforme in un'altra due, Con
tutto ciò rimedio debole
&
imperfetto. Perché quelle che non
risaltavano bene non potevano strisciare la faccia del belouardo,
la difesa del quale era tolta dall'angolo del fianco, che era molto
lontano. Et quelle che molto risaltavano come un péìtone inanzi
al castello,
&
un altro à porta palazzo impedivano la vista dal–
l'un belouardo all'altro
».
(Gabriello Busca milanese:
«Dell'Architettura Militare»
-
Li–
bro I, Capo LXXXV, pagina
264,
appresso Girolamo
B<?rd~:me
e
Pietro Martire Locarni compagni, in Milano, MDCI). BIblioteca
delle Scuole di Applicazione d'Arma.
(22)
La costruzione di tali portici fu realizzata nell'anno 1608 in
occasione delle nozze di due figlie di Carlo Emanuele I, Mar–
gherita ed Isabella, la prima andata sposa il 20 febbraio al
duca Francesco di Mantova, la seconda il mese dopo al duca
Alfonso di Modena.
(23)
Il
Cavaliere De Ville, già rientrato in
~ran~ia
.nel 1627,
pubblica l'anno dopo la sua opera sulle foruficazlOllI. Da tale
epoca egli si pone completaJ?ente .al
s~r:-izio
del suo sovrano
e sale in breve nella reputazIOne di LUIgi XIII, tanto da dive–
nire uno dei suoi principali ingegneri militari, A lui viene affi–
dato il compito del progetto e della costruzione di nUI?erost;
piazze di
g~erra,
alcune di recente acquisto .per
~a ~ra?cla; S~ll
suoi diseglll vengono erette le nuove fortificazlOllI dI CalaIS,
di Montreuil-sur-Mer, e la cittadella di Verduno
Accompagna le armate reali negli assedi di Corbie, di Landre–
cies di Hesdin e scriverà un lungo rapporto in latino sulle ope–
razi~ni
di assedio della prima piazza
(Obsidio Corbeiensis
ab
Antonio De Ville, Parisiis, MDCXXXVII, Biblioteca Reale, Col–
lezione Saluzzo, D 263).
Nel 1639 esce la seconda accurata opera che accrescerà la sua
fama:
De la Charge du Gouverneur des Places.
Uomo coscienzioso ed onesto, a cui la celebrità non crea alcun
complesso, muore, ailcor nel pieno della 'sua attività, nel 1657.
43


















