
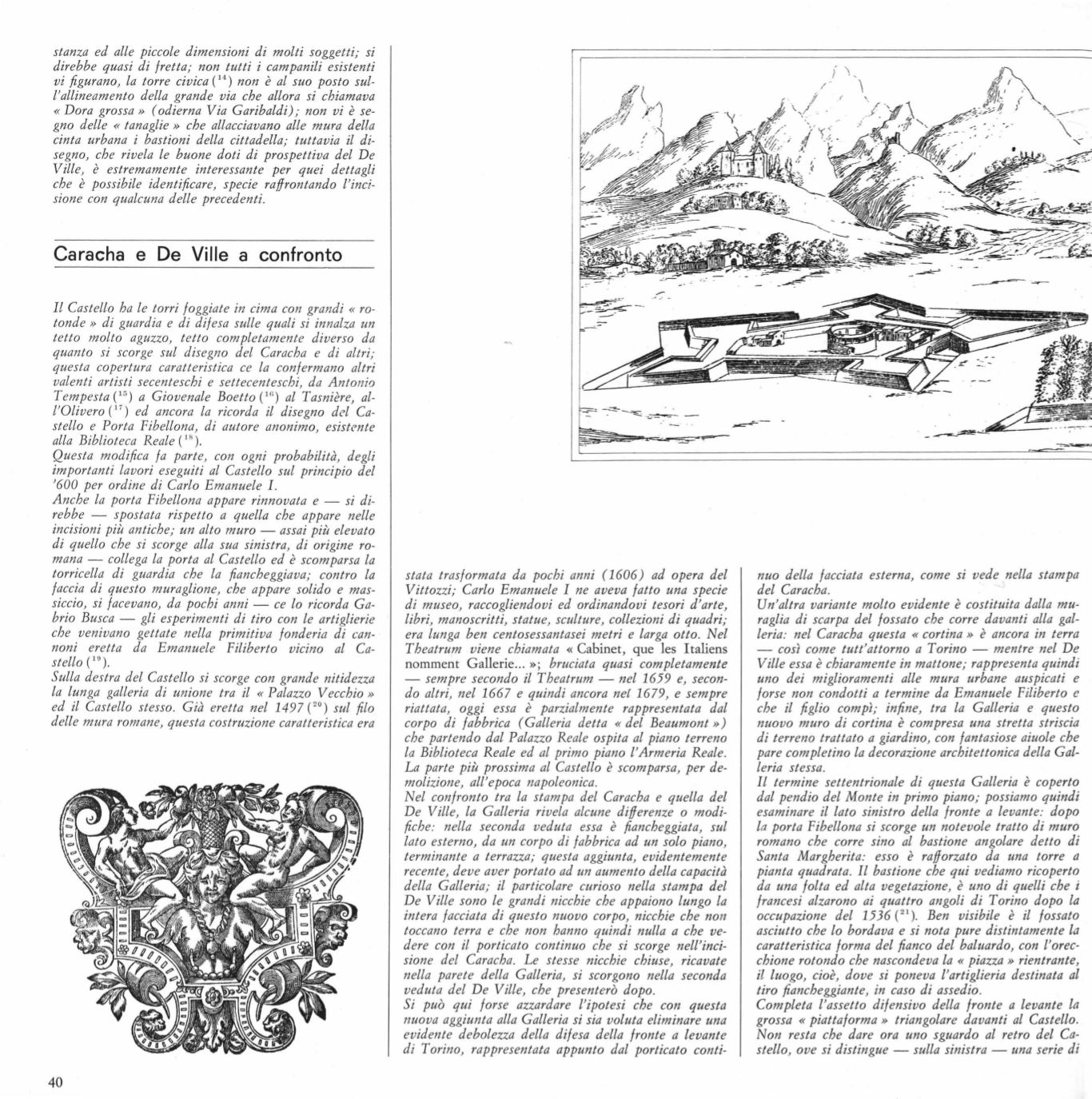
stanza ed alle piccole dimensioni di molti soggetti; si
direbbe quasi di fretta; non tutti i campanili esistenti
vi figurano, la torre civica
(14)
non è al suo posto sul–
l'allineamento della grande via che allora si chiamava
«
Dora grossa» (odierna Via Garibaldi); non vi è se–
gno delle
«
tanaglie
»
che allacciavano alle mura della
cinta urbana i bastioni della cittadella; tuttavia il di–
segno, che rivela le buone doti di prospettiva del De
Ville, è estremamente interessante per quei dettagli
che è possibile identificare, specie raffrontando l'inci–
sione con qualcuna delle precedenti.
Caracha e De Ville a confronto
It
Castello ha le torri foggiate in cima con grandi
«
ro–
tonde» di guardia e di difesa sulle quali si innalza un
tetto molto aguzzo, tetto completamente diverso da
quanto si scorge sul disegno del Caracha e di altri;
questa copertura caratteristica ce la confermano altri
valenti artisti secenteschi e settecenteschi, da Antonio
Tempesta
(15)
a Giovenale Boetto
eD)
al Tasnière, al–
l'Olivero
('7)
ed ancora la ricorda il disegno del Ca–
stello e Porta Fibellona, di autore anonimo, esistente
alla Biblioteca Reale
(
18).
Questa modifica fa parte, con ogni probabilità, degli
importanti lavori eseguiti al Castello sul principio del
'600 per ordine di Carlo Emanuele I.
Anche la porta Fibellona appare rinnovata e
-
si di–
rebbe
-
spostata rispetto a quella che appare nelle
incisioni più antiche; un alto muro
-
assai più elevato
di quello che si scorge alla sua sinistra, di origine ro–
mana
-
collega la porta al Castello ed è scomparsa la
torricella di guardia che la fiancheggiava; contro la
faccia di questo muraglione, che appare solido e mas–
siccio, si facevano, da pochi anni
-
ce lo ricorda Ga–
brio Busca
-
gli esperimenti di tiro con le artiglierie
che venivano gettate nella primitiva fonderia di can–
noni eretta da Emanuele Filiberto vicino al Ca–
stello
('
9).
Sulla destra del Castello si scorge con grande nitidezza
la lunga galleria di unione tra il «Palazzo Vecchio»
ed il Castello stesso. Già eretta nel
1497
eD)
sul filo
delle mura romane, questa costruzione caratteristica era
40
stata trasformata da pochi anni (1606) ad opera del
Vittozzi; Carlo Emanuele I ne aveva fatto una specie
di museo, raccogliendovi ed ordinandovi tesori d'arte,
libri, manoscritti, statue, sculture, collezioni di quadri;
era lunga ben centosessantasei metri e larga otto. Nel
Theatrum viene chiamata
«Cabinet, gue les Italiens
nomment Gallerie...
»;
bruciata quasi completamente
- sempre secondo
il
Theatrum
-
nel
1659
e, secon–
do altri, nel
1667
e quindi ancora nel
1679,
e sempre
riattata, oggi essa è parzialmente rappresentata dal
corpo di fabbrica (Galleria detta «del Beaumont»)
che partendo dal Palazzo Reale ospita al piano terreno
la Biblioteca Reale ed al primo piano l'Armeria Reale.
La parte più prossima al Castello è scomparsa, per de–
molizione, all'epoca napoleonica.
Nel confronto tra la stampa del Caracha e quella del
De Ville, la Galleria rivela alcune differenze o modi–
fiche: nella seconda veduta essa è fiancheggiata, sul
lato esterno, da un corpo di fabbrica ad un solo piano,
terminante a terrazza; questa aggiunta, evidentemente
recente, deve aver portato ad un aumento della capacità
della Galleria; il particolare curioso nella stampa del
De Ville sono le grandi nicchie che appaiono lungo la
intera facciata di questo nuovo corpo, nicchie che non
toccano terra e che non hanno quindi nulla a che ve–
dere con il porticato continuo che si scorge nell'inci–
sione del Caracha. Le stesse nicchie chiuse, ricavate
nella parete della Galleria, si scorgono nella seconda
veduta del De Ville, che presenterò dopo.
Si può qui forse azzardare l'ipotesi che con questa
nuova aggiunta alla Galleria si sia voluta eliminare una
evidente debolezza della difesa della fronte a levante
di Torino, rappresentata appunto dal porticato conti-
f
'\.
\
nuo della facciata esterna, come si vede nella stampa
del Caracha.
Un'altra variante molto evidente è costituita dalla mu–
raglia di scarpa del fossato che corre davanti alla gal–
leria: nel Caracha questa «cortina » è ancora in terra
- così come tutt'attorno a Torino
-
mentre nel De
Ville essa è chiaramente in mattone; rappresenta quindi
uno dei miglioramenti alle mura urbane auspicati e
forse non condotti a termine da Emanuele Filiberto e
che il figlio compì; infine, tra la Galleria e questo
nuovo muro di cortina è compresa una stretta striscia
di terreno trattato a giardino, con fantasiose aiuole che
pare completino la decorazione architettonica della Gal–
leria stessa.
Il termine settentrionale di questa Galleria è coperto
dal pendio del Monte in primo piano; possiamo quindi
esaminare il lato sinistro della fro nte a levante: dopo
la porta Fibellona si scorge un notevole tratto di muro
romano che corre sino al bastione angolare detto di
Santa Margherita: esso è rafforzato da una torre a
pianta quadrata. Il bastione che qui vediamo ricoperto
da una folta ed alta vegetazione, è uno di quelli che
i
francesi alzarono ai quattro angoli di Torino dopo la
occupazione del
1536
e
I).
Ben visibile è il fossato
asciutto che lo bordava e si nota pure distintamente la
caratteristica forma del fianco del baluardo, con l'orec–
chione rotondo che nascondeva la
«
piazza» rientrante,
il luogo, cioè, dove si poneva l'artiglieria destinata al
tiro fiancheggiante, in caso di assedio.
Completa l'assetto difensivo della fronte a levante la
grossa
«
piattaforma» triangolare davanti al Castello.
Non resta che dare ora uno sguardo al retro del Ca–
stello, ave si distingue
-
sulla sinistra
-
una serie di


















