
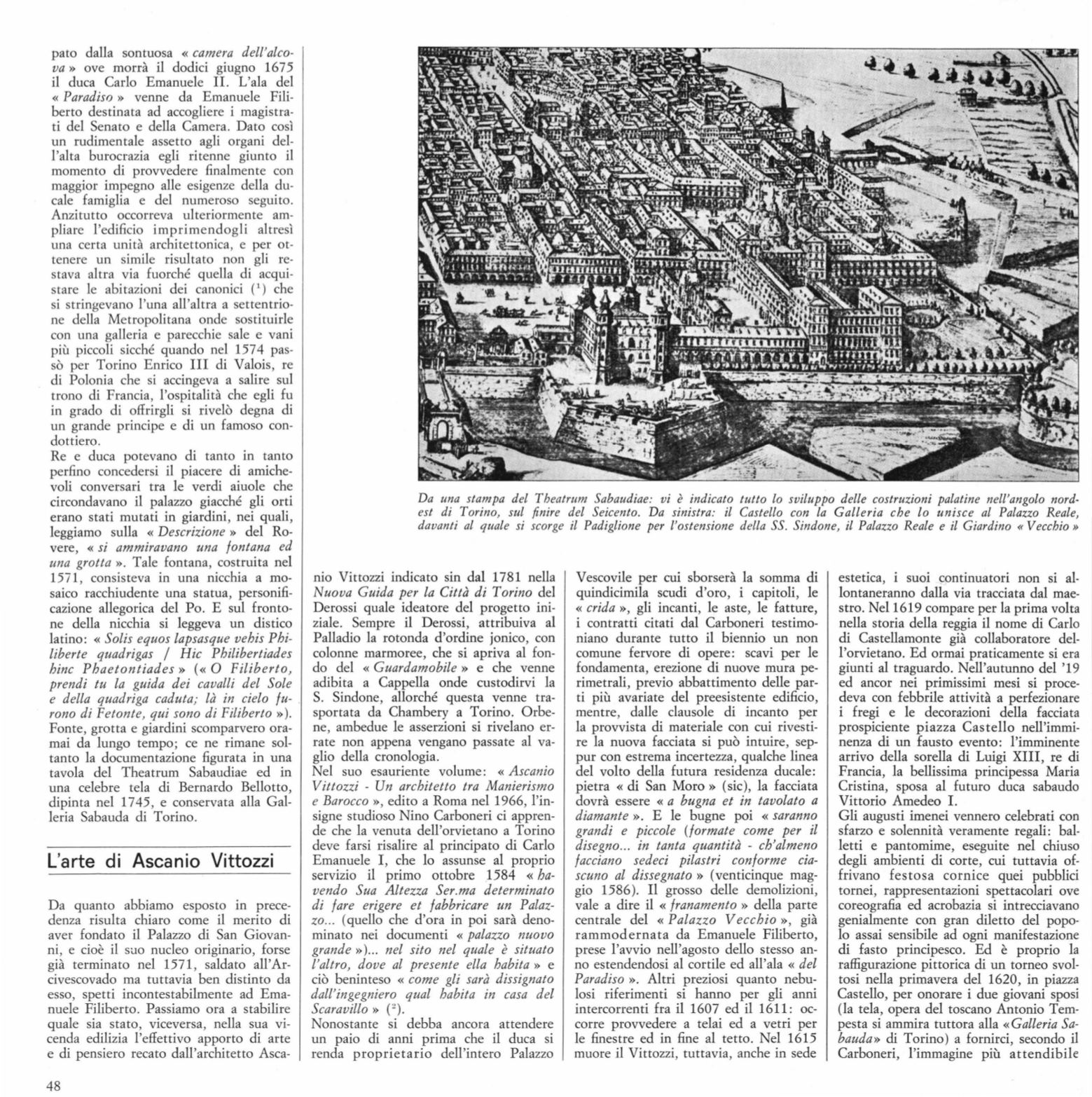
pato dalla sontuosa
«camera dell'alco–
va»
ove morrà
il
dodici giugno 1675
il
duca Carlo Emanuele II. L'ala del
«
Paradiso»
venne da Emanuele Fili–
berto destinata ad accogliere i magistra–
ti del Senato e della Camera . Dato così
un rudimentale assetto agli organi del–
l'alta burocrazia egli ritenne giunto
il
momento di provvedere finalmente con
maggior impegno alle esigenze della du–
cale famiglia e del numeroso seguito.
Anzitutto occorreva ulteriormente am–
pliare l'edificio imprimendogli altresì
una certa unità architettonica, e per ot–
tenere un simile risultato non gli re–
stava altra via fuorché quella di acqui–
stare le abitazioni dei canonici
(1)
che
si stringevano l'una all'altra a settentrio–
ne della Metropolitana onde sostituirle
con una galleria e parecchie sale e vani
più piccoli sicché quando nel 1574 pas–
sò per Torino Enrico
III
di Valois, re
di Polonia che si accingeva a salire sul
trono di Francia, l'ospitalità che egli fu
in grado di offrirgli si rivelò degna di
un grande principe e di un famoso con–
dottiero.
Re e duca potevano di tanto in tanto
perfino concedersi il piacere di amiche–
voli conversari tra le verdi aiuole che
circondavano
il
palazzo giacché gli orti
erano stati mutati in giardini, nei quali,
leggiamo sulla
«Descrizione»
del Ro–
vere,
«si ammiravano una fontana ed
una grotta
». Tale fontana, costruita nel
1571, consisteva in una nicchia a mo–
saico racchiudente una statua, personifi–
cazione allegorica del Po. E sul fronto–
ne della nicchia si leggeva un distico
latino:
«Solis equos lapsasque vehis Phi–
liberte quadrigas
/
Hic Philibertiades
hinc Phaetontiades»
(<<
O
Filiberto ,
prendi tu la guida dei cavalli del Sole
e della quadriga caduta; là in cielo fu–
rono di Fetonte, qui sono di Filiberto»).
Fonte, grotta e giardini scomparvero ora–
mai da lungo tempo; ce ne rimane sol–
tanto la documentazione figurata in una
tavola del Theatrum Sabaudiae ed in
una celebre tela di Bernardo Bellotto ,
dipinta nel 1745, e conservata alla Gal–
leria Sabauda di Torino.
L'arte di Ascanio Vittozzi
Da quanto abbiamo esposto in prece–
denza risulta chiaro come il merito di
aver fondato
il
Palazzo di San Giovan–
ni, e cioè il suo nucleo originario, forse
già terminato nel 1571 , saldato all'Ar–
civescovado ma tuttavia ben distinto da
esso, spetti incontestabilmente ad Ema–
nuele Filiberto. Passiamo ora a stabilire
quale sia stato, viceversa, nella sua vi–
cenda edilizia l'effettivo apporto di arte
e di pensiero recato dall'architetto Asca-
48
Da una stampa del Theatrum Sabaudiae:
VI
e indicato tutto lo sviluppo delle costruzioni palatine nell'angolo nord–
est di Torino, sul finire del Seicento. Da sinistra: il Castello con la Galleria che lo unisce al Palazzo Reale,
davanti al quale si scorge il Padiglione per l'ostensione della SS. Sindone, il Palazzo Reale e il Giardino «Vecchio»
nio Vittozzi indicato sin dal 1781 nella
Nuova Guida per la Città di Torino
del
Derossi quale ideatore del progetto ini–
ziale. Sempre il Derossi, attribuiva al
Palladio la rotonda d'ordine jonico, con
colonne marmoree, che si apriva al fon–
do del
«Guardamobile»
e che venne
adibita a Cappella onde custodirvi la
S. Sindone, allorché questa venne tra–
sportata da Chambery a Torino. Orbe–
ne, ambedue le asserzioni si rivelano er–
rate non appena vengano passate al va–
glio della cronologia.
Nel suo esauriente volume :
«Ascanio
Vittozzi
-
Un architetto tra Manierismo
e Barocco
», edito a Roma nel 1966, l'in–
signe studioso Nino Carboneri ci appren–
de che la venuta dell'orvietano a Torino
deve farsi risalire al principato di Carlo
Emanuele I, che lo assunse al proprio
servizio
il
primo ottobre 1584
«ha–
vendo Sua Altezza
Ser.madeterminato
di fare erigere et fabbricare un Palaz–
zo...
(quello che d'ora in poi sarà deno–
minato nei documenti
«palazzo nuovo
grande»
)...
nel sito nel quale
è
situato
l'altro, dove al presente ella habita
»
e
ciò beninteso
«
come gli sarà dissignato
dall'ingegniero qual habita in casa del
Scaravillo
»
(2).
Nonostante si debba ancora attendere
un paio di anni prima che il duca si
renda proprietario dell'intero Palazzo
Vescovile per cui sborserà la somma di
quindicimila scudi d'oro, i capitoli, le
«
crida
», gli incanti, le aste, le fatture,
i contratti citati dal Carboneri testimo–
niano durante tutto il biennio un non
comune fervore di opere: scavi per le
fondamenta, erezione di nuove mura pe–
rimetrali, previo abbattimento delle par–
ti più avariate del preesistente edificio,
mentre, dalle clausole di incanto per
la provvista di materiale con cui rivesti–
re la nuova facciata si può intuire, sep–
pur con estrema incertezza, qualche linea
del volto della futura residenza ducale:
pietra «di San Moro» (sic), la facciata
dovrà essere «
a bugna et in tavolato a
diamante
». E le bugne poi
«saranno
grandi e piccole (formate come per il
disegno ... in tanta quantità
-
ch'almeno
facciano sedeci pilastri conforme cia–
scuno al dissegnato
» (venticinque mag–
gio 1586). Il grosso delle demolizioni,
vale a dire il
«
franamento»
della parte
centrale del
«Palazzo Vecchio
», già
rammodernata da Emanuele Filiberto,
prese l'avvio nell'agosto dello stesso an–
no estendendosi al cortile ed all'ala
«
del
Paradiso
». Altri preziosi quanto nebu–
losi riferimenti si hanno per gli anni
intercorrenti fra il 1607 ed il 1611: oc–
corre provvedere a telai ed a vetri per
le finestre ed in fine al tetto. Nel 1615
muore il Vittozzi, tuttavia, anche in sede
estetica, i suoi çontinuatori non si al–
lontaneranno dalla via tracciata dal mae–
stro. Nel 1619 compare per la prima volta
nella storia della reggia il nome di Carlo
di Castellamonte già collaboratore del–
l'orvietano. Ed ormai praticamente si era
giunti al traguardo. Nell'autunno del '19
ed ancor nei primissimi mesi si proce–
deva con febbrile attività a perfezionare
i fregi e le decorazioni della faccia ta
prospiciente piazza Castello nell'immi–
nenza di un fausto evento: l'imminente
arrivo della sorella di Luigi XIII, re di
Francia, la bellissima principessa Maria
Cristina, sposa al futuro duca sabaudo
Vittorio Amedeo
I.
Gli augusti imenei vennero celebrati con
sfarzo e solennità veramente regali: bal–
letti e pantomime, eseguite nel chiuso
degli ambienti di corte, cui tuttavia of–
frivano fes tosa cornice quei pubblici
tornei, rappresentazioni spettacolari ove
coreografia ed acrobazia si intrecciavano
genialmente con gran diletto del popo–
lo assai sensibile ad ogni manifestazione
di fasto principesco. Ed
è
proprio la
raffigurazione pittorica di un torneo svol–
tosi nella primavera del 1620, in piazza
Castello, per onorare i due giovani sposi
(la tela, opera del toscano Antonio Tem–
pesta si ammira tuttora alla
«Galleria Sa–
bauda»
di Torino) a fornirci, secondo
il
Carboneri, l'immagine più attendibile


















