
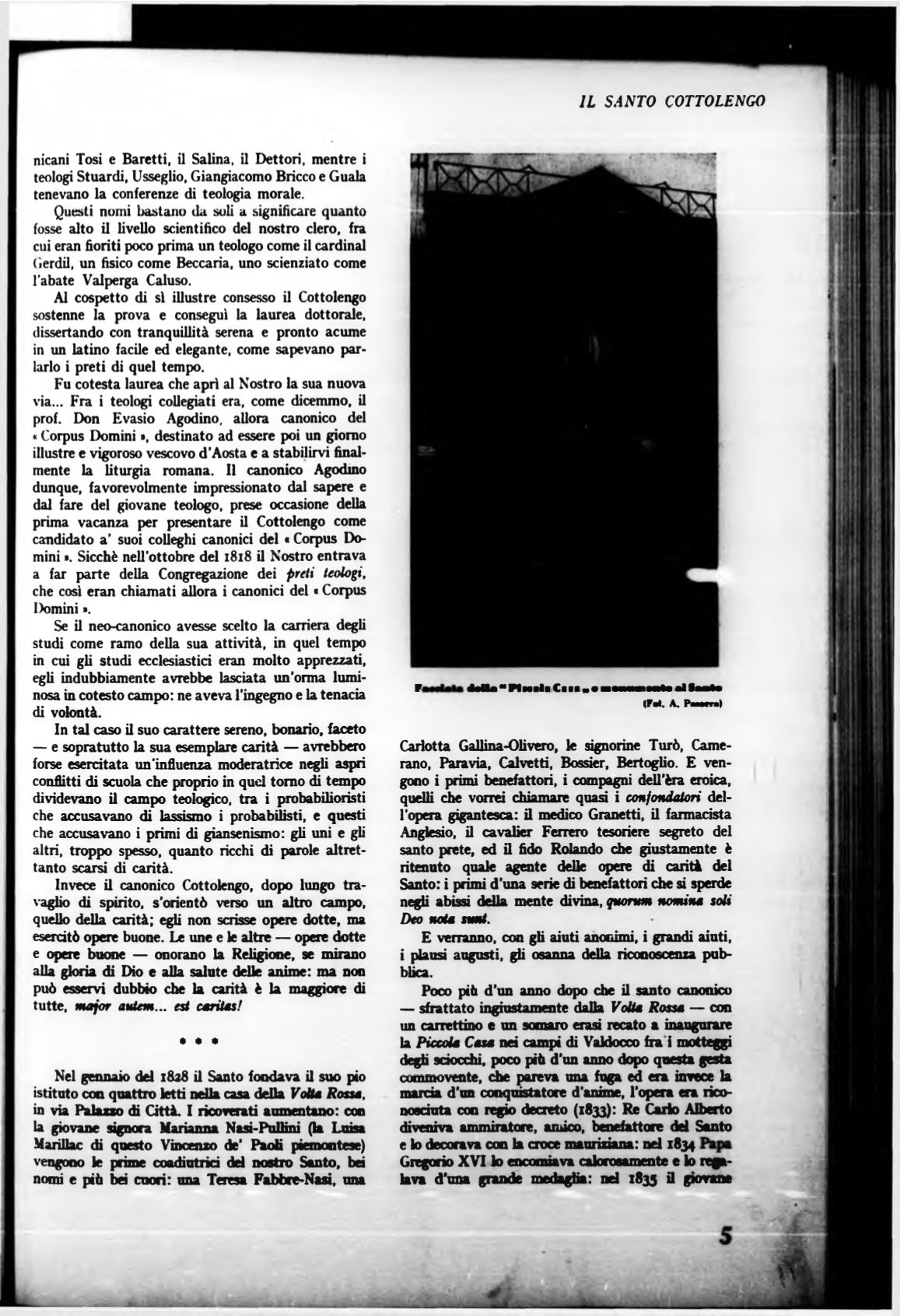
IL SANTO COTTOLENGO
nicani Tosi e Baretti, il Salina, il Dettori, mentre i
teologi Stuardi, Usseglio, Giangiacomo Bricco e Guala
tenevano la conferenze di teologia morale.
Questi nomi bastano da soli a significare quanto
fosse alto il livello scientifico del nostro clero, fra
cui eran fioriti poco prima un teologo come il Cardinal
(ìerdil, un fisico come Beccaria, uno scienziato come
l’abate Valperga Caluso.
Al cospetto di sì illustre consesso il Cottolengo
sostenne la prova e conseguì la laurea dottorale,
dissertando con tranquillità serena e pronto acume
in un latino facile ed elegante, come sapevano par
larlo i preti di quel tempo.
Fu cotesta laurea che aprì al Nostro la sua nuova
via... Fra i teologi collegiati era, come dicemmo, il
prof. Don Evasio Agodino, allora canonico del
«Corpus Domini », destinato ad essere poi un giorno
illustre e vigoroso vescovo d ’Aosta e a stabilirvi final
mente la liturgia romana. Il canonico Agodino
dunque, favorevolmente impressionato dal sapere e
dal fare del giovane teologo, prese occasione della
prima vacanza per presentare il Cottolengo come
candidato a ’ suoi colleghi canonici del «Corpus Do
mini ». Sicché nell’ottobre del 1818 il Nostro entrava
a far parte della Congregazione dei
preti teologi,
che così eran chiamati allora i canonici del «Corpus
Domini ».
Se il neo-canonico avesse scelto la carriera degli
studi come ramo della sua attività, in quel tempo
in cui gli studi ecclesiastici eran molto apprezzati,
egli indubbiamente avrebbe lasciata un’orma lumi
nosa in cotesto campo: ne aveva l’ingegno e la tenacia
di volontà.
In tal caso il suo carattere sereno, bonario, faceto
— e sopratutto la sua esemplare carità — avrebbero
forse esercitata un'influenza moderatrice negli aspri
conflitti di scuola che proprio in quel torno di tempo
dividevano il campo teologico, tra i probabilioristi
che accusavano di lassismo i probabilisti, e questi
che accusavano i primi di giansenismo: gli uni e gli
altri, troppo spesso, quanto ricchi di parole altret
tanto scarsi di carità.
Invece il canonico Cottolengo, dopo lungo tra
vaglio di spirito, s'orientò verso un altro campo,
quello della carità; egli non scrisse opere dotte, ma
esercitò opere buone. Le une e le altre — opere dotte
e opere buone — onorano la Religione, se mirano
alla gloria di Dio e alla salute delle anime: ma non
può esservi dubbio che la carità è la maggiore di
tutte,
major autem... est caritas!
• * *
Nel
gennaio del
1828 il
Santo fondava
il
suo pio
istituto
con quattro letti nella casa della
VotU Rossa,
in
via Palazzo di Città. I ricoverati aumentano: con
la
giovane signora Marianna Nasi-Pullini (la Luisa
Marillac di questo Vincenzo de* Paoli piemontese)
vengono le prime coadiutóri dd nostro Santo, bei
nomi
e più bei cuori: una Teresa
Fabbre-Nasi,
una
r
a r f t o « U n i i » € ■ ■ » , « ■ W i n a l l — H
(F a i. A . P u w ri)
Carlotta Gallina-Olivero, le signorine Turò, Came-
rano, Paravia, Calvetti, Bossier, Bertoglio. E ven
gono i primi benefattori, i compagni dell'èra eroica,
quelli che vorrei chiamare quasi i
confondatori
del
l’opera gigantesca: il medico Granetti, il farmacista
Anglesio, il cavalier Ferrerò tesoriere segreto del
santo prete, ed il fido Rolando che giustamente è
ritenuto quale agente delle opere di carità del
Santo: i primi d’una serie di benefattori che si sperde
negli abissi della mente divina,
quorum nomina soli
Deo nota sunt.
E verranno, con gli aiuti anonimi, i grandi aiuti,
i plausi augusti, gli osanna della riconoscenza pub
blica.
Poco più d’un anno dopo che il santo canonico
— sfrattato ingiustamente dalla
Volta Rossa
—
am
un carrettino e un somaro erasi recato a inaugurare
la
Piccola Casa
nei campi di Valdocco fra i motteggi
degli sciocchi, poco più d’un anno dopo questa gesta
commovente, che pareva una fuga ed era invece la
marcia d’un conquistatore d’anime, l’opera era rico
nosciuta
eoo
regio decreto (1833): Re Cario Alberto
diveniva ammiratore, amico, benefattore
dei
Santo
e lo decorava con la croce mauririana: nel 1834
Gregorio XV I
io
encomiava calorosamente e
lo
rega
lava d’una grande medaglia: nel 1835 il
gravane


















