
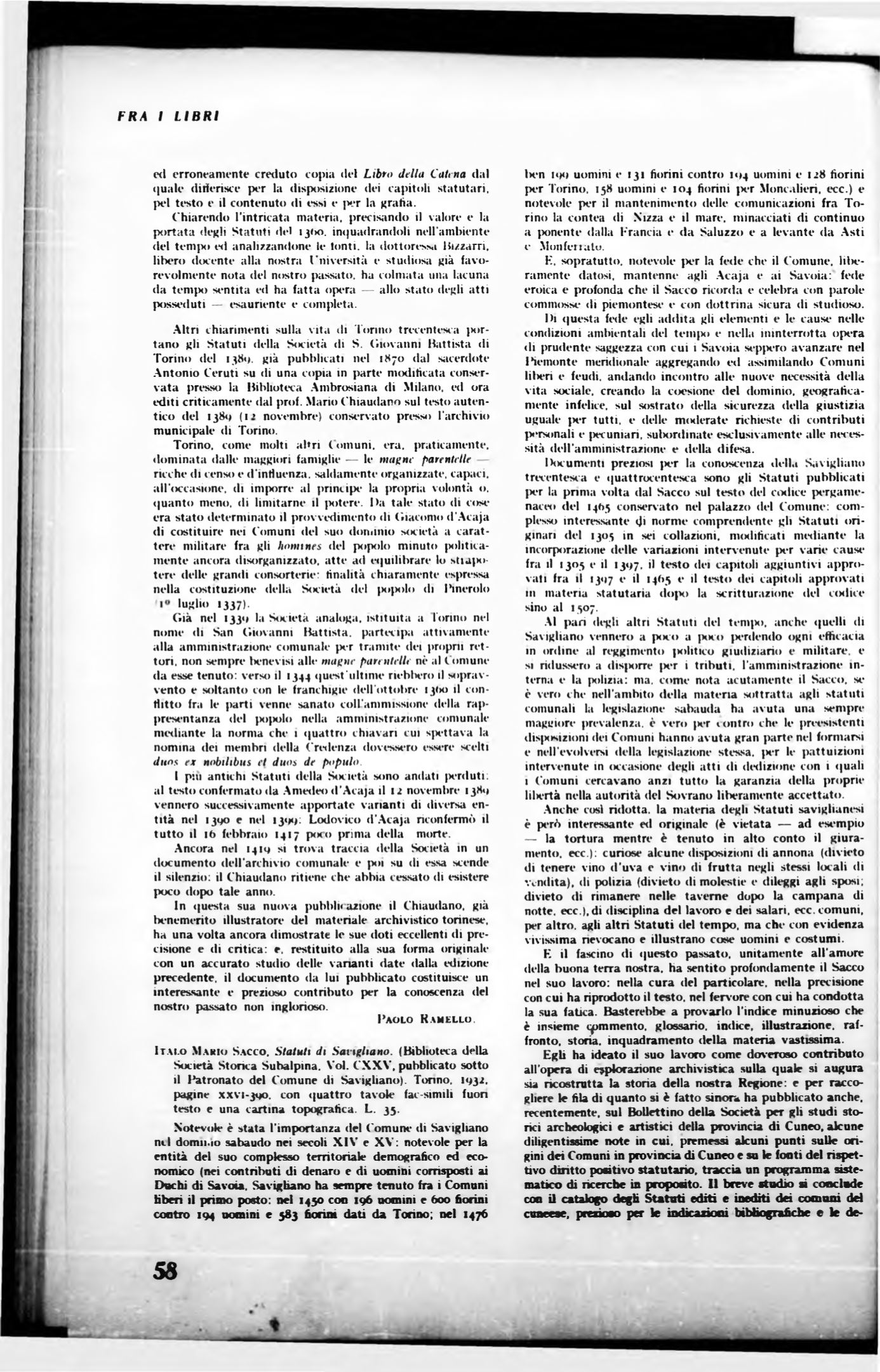
FRA I L I B R I
ed erroneamente creduto copia del
Libro della Calma
dal
quale differisce per la disposizione dei capitoli statutari,
pel testo e il contenuto di essi e per la grafìa.
Chiarendo l'intricata materia, precisando il valore e la
portata degli Statuti del i3<>o. inquadrandoli nell'ambiente
del tempo ed analizzandone le tonti, ia dottorerai Bizzarri,
libero docente alla nostra l'niversità e studiosa già favo
revolmente nota del nostro passato, ha colmata una lacuna
da tempo sentita ed ha fatta opera — allo stato degli atti
posseduti — esauriente e completa.
Altri chiarimenti sulla vita di Torino trecentesca jn>r-
tano gli Statuti della Società di S. Giovanni Battista di
Torino del 1389, già pubblicati nel 1870 dal sacerdote
Antonio Ceruti su di una copia in parte modificata conser
vata presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, ed ora
editi criticamente dal prof. Mario Chiaudano sul testo auten
tico del 138»» (1
>
novembre) conservato presso l'archivio
municipale di Torino.
Torino, come molti altri Comuni, era, praticamente,
dominata dalle maggiori famiglie — le
magne parentelle
ricche di censo e d'influenza, saldamente organizzate, capaci,
aU’occasione, ili imporre al principe la propria volontà o,
quanto meno, di limitarne il potere. Da tale stato di cose-
era stato determinato il provvedimento ili Giacomo d ’Acaja
di costituire nei Comuni del suo dominio società a carat
tere militare fra gli
homtnes
del popolo minuto politica-
mente ancora disorganizzato, atte ad equilibrare lo stia{H>-
tere delle grandi consorterie: finalità chiaramente espressa
nella costituzione della Società ilei popolo di Pinerolo
luglio 1337).
Già nel 1331* la Società analoga, istituita a Torino nel
nome di San Giovanni Battista, partecipa attivamente
alla amministrazione comunale per tramite dei proprii ret
tori, non sempre benevisi alle
magne parentelle
nè al Comune
da esse tenuto: verso il 1344 quest'ultime riebbero il soprav
vento e soltanto con le franchigie dell'ottobre 1360 il con
flitto fra le parti venne sanato coll'ammissione della rap
presentanza del popolo nella amministrazione comunale
mediante la norma che 1 quattro chiavari cui spettava la
nomina dei membri della Credenza dovessero essere scelti
duo* ex nobilibus et duos de populo.
I
pili antichi Statuti della Società sono andati perduti:
al testo confermato da Amedeo d ’Acaja il iz novembre 138(1
vennero successivamente apportate varianti di diversa en
tità nel 1340 e nel 131*9: Lodovico d 'Acaja riconfermò il
tutto il 16 febbraio 1417 p<xo prima della morte.
Ancora nel 14114 si trova traccia della Società in un
documento tlcU'archivio comunale e poi su di essa scende
il silenzio: il Chiaudano ritiene che abbia cessato di esistere
poco dopo tale anno.
In questa sua nuova pubbli* azione il Chiaudano, già
benemerito illustratore del materiale archivistico torinese,
ha una volta ancora dimostrate le sue doti eccellenti di pre
cisione e di critica: r, restituito alla sua forma originale
con un accurato studio delle varianti date dalla edizione
precedente, il documento da lui pubblicato costituisce un
interessante e prezioso contributo per la conoscenza del
nostro passato non inglorioso.
P
a o lo
K
a m e l l o
.
I t a l o M a rio Sacco,
Statuii di Savighano.
(Biblioteca della
Società Storica Subalpina. Voi. CXXV , pubblicato sotto
il Patronato del Comune di Savighano). Tonno, 193Z.
pagine xxvi-390. con quattro tavole fac-simili fuon
testo e una cartina topografica. L. 35.
Notevole è stata l'importanza del Comune di Savighano
nel dormi.10 sabaudo nei seeoli XIV e XV: notevole per la
entità del suo complesso territoriale demografico ed eco
nomico (nei contributi di denaro e di uomini corrisposti ai
Duchi di Savoia, Savighano ha sempre tenuto fra i Comuni
Uberi il primo posto: nel 1450 con 196 uomini e 600 fiorini
contro 194 uomini e 583 fiorini dati da Torino; nel 1476
58
lH‘n 100 uomini e 131 fiorini contro 1114 uomini e iz8 fiorini
per Torino, 158 uomini e 104 fiorini per Moncalieri, ecc.) e
notevole per il mantenimento delle comunicazioni fra T o
rino la contea di Nizza e il mare, minacciati di continuo
a ponente dalla Francia e da Saluzzo e a levante da Asti
e Moliferra tu.
K, sopratutto, notevole per la fede che il Comune, libe-
ramente datosi, mantenne agli Acaja e ai Savoia: fede
eroica e profonda che il Sacco ricorda e celebra con parole
commosse di piemontese e con dottrina sicura di studioso.
Di questa fede egli addita gli elementi e le cause nelle
condizioni ambientali del tempo e nella ininterrotta opera
ili prudente saggezza con cui i Savoia seppero avanzare nel
Ihemonte meridionale aggregando ed assimilando Comuni
liln-ri e feudi, andando incontro alle nuove necessità della
vita sociale, creando la coesione del dominio, geografica
mente infelice, sul sostrato della sicurezza della giustizia
uguale
jk t
tutti, e delle moderate richieste di contributi
personali e pecuniali, subordinate esclusivamente alle neces
sità dcH'amministrazione e della difesa.
Documenti preziosi jier la conoscenza della Savighano
trecentesca e quattrocentesca sono gli Statuti pubblicati
per la prima volta dal Sacco sul testo del codice pergame
naceo del 14(15 conservato nel palazzo del Comune: com
plesso interessante i)i norme comprendente gli Statuti ori
ginari del 1305 in sei collazioni, modificati mediante la
incorporazione delle variazioni intervenute per varie cause
fra il 1305 e il 1397. il testo dei capitoli aggiuntivi appro
vati fra il 13«»7 e il 14(15 e il testo dei capitoli approvati
111 materia statutaria dopo la scritturazione del codice
sino al 1507.
Al pari degli altri Statuti del tempo, anche quelli di
Savigliano vennero a poco a poco perdendo ogni efficacia
in ortiine al reggimento |K>htico giudiziario e militare, e
si ridussero a disporre per i tributi, l’amministrazione in
terna e la polizia: ma. come nota acutamente il Sacco, se
è vero che nell’ambito della materia sottratta agli statuti
comunali la legislazione sabauda ha avuta una sempre
maggiore prevalenza, è vero jier 1mitro che le preesistenti
disposizioni ilei Comuni hanno avuta gran parte nel formarsi
e nell'evolversi della legislazione stessa, per le pattuizioni
intervenute in occasione degli atti ili dedizione con i quali
1 Comuni cercavano anzi tutto la garanzia della proprie
liliertà nella autorità del Sovrano liberamente accettato.
Anche cosi ridotta, la materia degli Statuti saviglianesi
è però interessante ed originale (è vietata — ad esempio
— la tortura mentre è tenuto in alto conto il giura
mento. ecc.): curiose alcune disposizioni di annona (divieto
di tenere vino d ’uva e vino di frutta negli stessi locali di
vendita), di polizia (divieto di molestie e dileggi agli sposi;
divieto di rimanere nelle taverne dopo la campana di
notte, ecc.), di disciplina del lavoro e dei salari, ecc. comuni,
per altro, agli altri Statuti del tempo, ma che con evidenza
vivissima rievocano e illustrano cose uomini e costumi.
K il fascino di questo passato, unitamente all'amore
della buona terra nostra, ha sentito profondamente il Sacco
nel suo lavoro: nella cura del particolare, nella precisione
con cui ha riprodotto il testo, nel fervore con cui ha condotta
la sua fatica. Basterebbe a provarlo l'indice minuzioso che
è insieme commento, glossario, indice, illustrazione, raf
fronto, storia, inquadramento della materia vastissima.
Egli ha ideato il suo lavoro come doveroso contributo
all’opera di esplorazione archivistica sulla quale si augura
sia ricostrutta la storia della nostra Regione: e per racco
gliere le fila di quanto si è fatto sinora ha pubblicato anche,
recentemente, sul Bollettino della Società per gli studi sto
rici archeologici e artistici della provincia di Cuneo, alcune
diligentissime note in cui, premessi akuni punti sulle ori
gini dei Comuni in provincia di Cuneo e su le fonti del rispet
tivo diritto positivo statutario, traccia un programma siste
matico eh ricerche in proposito. II breve studio si conclude
con il catalogo degli Statuti editi e inediti dei comuni del
cuneese, prezioso per le indicazioni bibliografiche e le de


















