
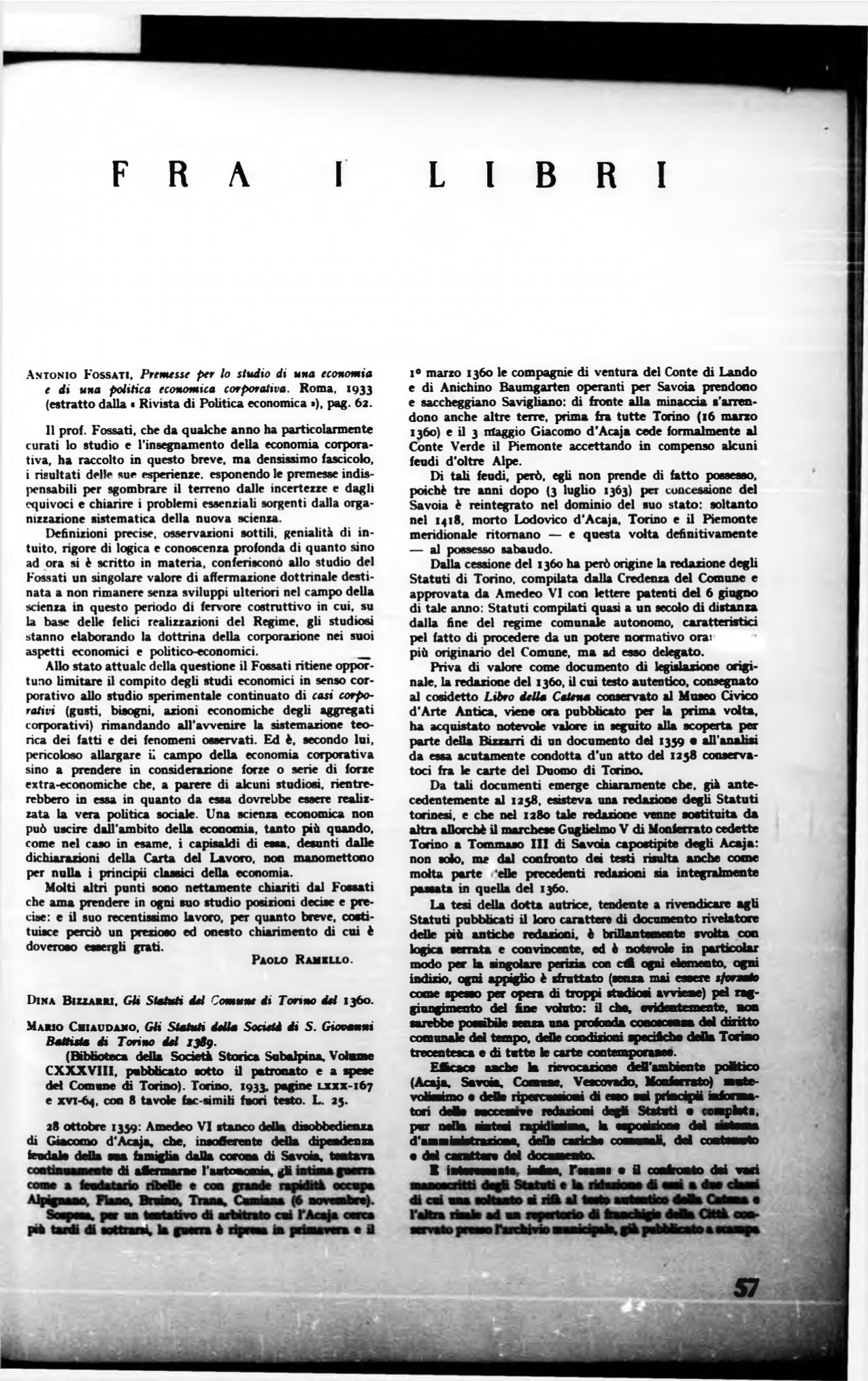
F R A
I
L I B R I
A
n to n io
F
o ssa ti
,
Premesse per lo studio di una economia
e di una politica economica corporativa.
Roma, 1933
(estratto dalla «Rivista di Politica economica »), pag. 62.
11
prof. Fossati, che da qualche anno ha particolarmente
curati lo studio e l'insegnamento della economia corpora
tiva, ha raccolto in questo breve, ma densissimo fascicolo,
i risultati delle sue esperienze, esponendo le premesse indis
pensabili per sgombrare il terreno dalle incertezze e dagli
equivoci e chiarire i problemi essenziali sorgenti dalla orga
nizzazione sistematica della nuova scienza.
Definizioni precise, osservazioni sottili, genialità di in
tuito. rigore di logica e conoscenza profonda di quanto sino
ad ora si è scritto in materia, conferiscono allo studio del
Fossati un singolare valore di affermazione dottrinale desti
nata a non rimanere senza sviluppi ulteriori nel campo della
scienza in questo periodo di fervore costruttivo in cui, su
la base delle felici realizzazioni del Regime, gli studiosi
stanno elaborando la dottrina della corporazione nei suoi
aspetti economici e politico-economici.
_
Allo stato attuale della questione il Fossati ritiene oppor
tuno limitare il compito degli studi economici in senso cor
porativo allo studio sperimentale continuato di
casi corpo
rativi
(gusti, bisogni, azioni economiche degli aggregati
corporativi) rimandando all’avvenire la sistemazione teo
rica dei fatti e dei fenomeni osservati. Ed è, secondo lui,
pericoloso allargare il campo della economia corporativa
sino a prendere in considerazione forze o serie di forze
extra-economiche che, a parere di alcuni studiosi, rientre
rebbero in essa in quanto da essa dovrebbe essere realiz
zata la vera politica sociale. Una scienza economica non
può uscire dall'ambito della economia, tanto più quando,
come nel caso in esame, i capisaldi di essa, desunti dalle
dichiarazioni della Carta del Lavoro, non manomettono
per nulla i prindpii classici della economia.
Molti altri punti sono nettamente chiariti dal Fossati
che ama prendere in ogni suo studio posizioni decise e pre
cise: e il suo recentissimo lavoro, per quanto breve, costi
tuisce perciò un prezioso ed onesto chiarimento di cui è
doveroso essergli grati.
P
aolo
R
a n e l l o
.
D
ina
B
izzarri
,
Gli Statuti dei Comune di Torino del
1360.
M
a r io
C
h ia u d a n o
,
Gli Statuti della Società di S. Giovanni
Battista di Torino del 1389.
(Biblioteca della Società Storica Subalpina, Volarne
CXXXVIII, pubblicato sotto il patronato e a spese
del Comune di Torino). Tarino. 1933, pagine utxx-167
e xvi-64, con 8 tavole fac-simili fuori testo. L. 25.
28 ottobre 1359: Amedeo VI stanco della disobbedienza
di
Giacomo d’Acaja, che, insofferente della dipendenza
fendale della n a famiglia dalla corata di Savoia, tastava
di aBermazne l'autonomia, gli
i° marzo 1360 le compagnie di ventura del Conte di Landò
e di Anichino Baumgarten operanti per Savoia prendono
e saccheggiano Savigliano: di fronte alla minaccia s’arren
dono anche altre terre, prima fra tutte Torino (16 marzo
1360) e il 3 maggio Giacomo d’Acaja cede formalmente al
Conte Verde il Piemonte accettando in compenso alcuni
feudi d’oltre Alpe.
Di tali feudi, però, egli non prende di fatto possesso,
poiché tre anni dopo (3 luglio 1363) per concessione del
Savoia è reintegrato nel dominio del suo stato: soltanto
nel 1418, morto Lodovico d’Acaja, Torino e il Piemonte
meridionale ritornano — e questa volta definitivamente
— al possesso sabaudo.
Dalla cessione del 1360 ha però origine la redazione degli
Statuti di Torino, compilata dalla Credenza del Comune e
approvata da Amedeo VI con lettere patenti d d 6 giugno
di tale anno: Statuti compilati quasi a un secolo di distanza
dalla fine del regime comunale autonomo, caratteristici
pel fatto di procedere da un potere normativo orai
più originario del Comune, ma ad esso delegato.
Priva di valore come documento di legislazione origi
nale, la redazione del 1360, il cui testo autentico, consegnato
al cosidetto
Libro della Catena
conservato al Museo Civico
d’Arte Antica, viene ora pubblicato per la prima volta,
ha acquistato notevole valore in seguito alla scoperta per
parte della Bizzarri di un documento del 1359 e all’analisi
da essa acutamente condotta d’un atto del 1258 conserva
toci fra le carte del Duomo di Torino.
Da tali documenti emerge chiaramente che, già ante
cedentemente al 1258, esisteva una redazione degli Statuti
torinesi, e che nel 1280 tale redazione venne sostituita da
altra allorché il marchese Guglielmo V di Monferrato cedette
Torino a Tommaso
III
di Savoia capostipite degli Acaja:
non solo,
mz
dal confronto dei testi risulta anche come
molta parte JeUe precedenti redazioni sia integralmente
passata in quella del 1360.
La tesi della dotta autrice, tendente a rivendicare agli
Statuti pubblicati il loro carattere di documento rivelatore
delle più antiche redazioni, è brillantemente svolta con
logica serrata e convincente, ed è notevole in particolar
modo per la «ingoiale perizia con c d ogni demento, ogni
indisio, ogni appiglio è sfruttato (senza mai essere
sforzato
come spesso per opera di troppi studiosi avviene) pel rag
giungimento dd fine voluto: il che, evidentemente, non
sarebbe possibile senza una profonda
connarenia dd
diritto
comunale dd tempo, delle condizioni
specifiche ddla
Torino
trecentesca e di tutte le carte contemporanee.
Efficace anche la rievocazione dell’ambiente politico
(Acaja, Savoia, Comune, Vescovado, Monierrato) mnte-
vobssimo e delle ripercussioni di esso sai principii informa
tori dette —ccMMnre redazioni degli Statati e tnmphti,
pur nsBa sintesi rapirò«im a, la esposizione dd «sterna
d'amministrazione, deDe cariche comunali, dd conte— to
e dal carattere dd documento.
B in tw m it» . infine, Pesami e il confronto dd vari
57


















