
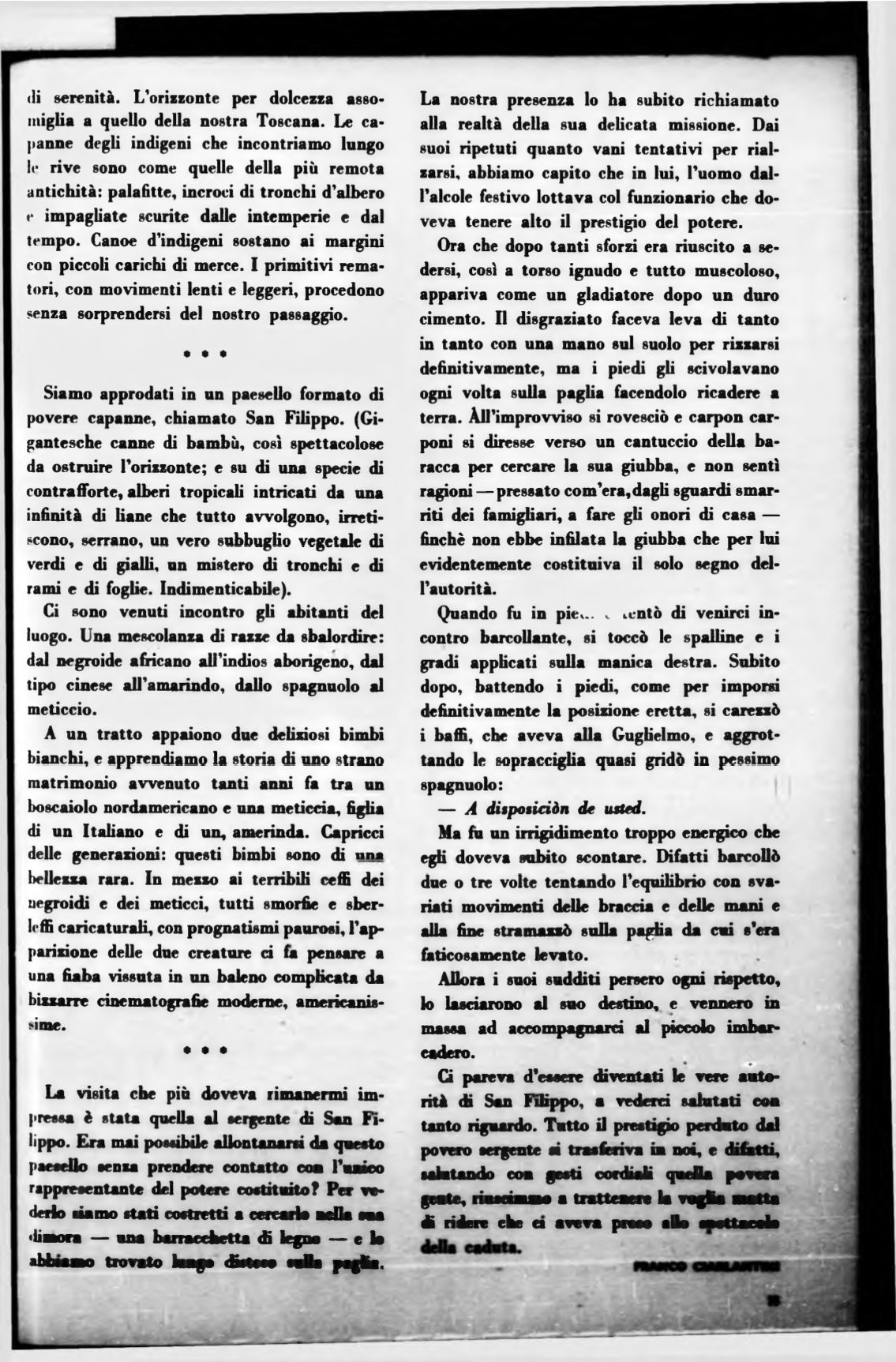
(li serenità. L’orizzonte per dolcezza asso
miglia a quello della nostra Toscana. Le ca-
panne degli indigeni che incontriamo lungo
le rive sono come quelle della più remota
antichità: palafitte, incroci di tronchi d’albero
e impagliate scurite dalle intemperie e dal
tempo. Canoe d’indigeni sostano ai margini
con piccoli carichi di merce. I primitivi rema*
tori, con movimenti lenti e leggeri, procedono
senza sorprendersi del nostro passaggio.
• * •
Siamo approdati in un paesello formato di
povere capanne, chiamato San Filippo. (Gi
gantesche canne di bambù, così spettacolose
da ostruire l’orizzonte; e su di una specie di
contrafforte, alberi tropicali intricati da una
infinità di liane che tutto avvolgono, irreti
scono, serrano, un vero subbuglio vegetale di
verdi e di gialli, un mistero di tronchi e di
rami e di foglie. Indimenticabile).
Ci sono venuti incontro gli abitanti del
luogo. Una mescolanza di razze da sbalordire:
dal negroide africano all’indios aborigeno, dal
tipo cinese all’amarindo, dallo spagnuolo al
meticcio.
A un tratto appaiono due deliziosi bimbi
bianchi, e apprendiamo la storia di uno strano
matrimonio avvenuto tanti anni fa tra un
boscaiolo nordamericano e una meticcia, figlia
di un Italiano e di un, amerinda. Caprìcci
delle generazioni: questi bimbi sono di nna
bellezza rara. In mezzo ai terribili ceffi dei
uegroidi e dei meticci, tutti smorfie e sber
leffi caricaturali, con prognatismi paurosi, l’ap
parizione delle due creature ci fa pensare a
una fiaba vissuta in un baleno complicata da
bizzarre cinematografie moderne, amerìcanis-
!>ime.
» • •
La
visita che
più
doveva rimanermi im
pressa
è stata
quella al sergente di San
Fi
lippo.
Era mai possibile allontanarsi da questo
paesello senza prendere contatto con l’unico
rappresentante del potere costituito? Per ve
derlo siamo stati costretti a cercaria nella sua
«limora — una barracchetta di legno — e lo
i
U
m m
trovato lunga disteso svia paglia.
La nostra presenza lo ha subito richiamato
alla realtà della sua delicata missione. Dai
suoi ripetuti quanto vani tentativi per rial
zarsi, abbiamo capito che in lui, l’uomo dal
l’alcole festivo lottava col funzionario che do
veva tenere alto il prestigio del potere.
Ora che dopo tanti sforzi era riuscito a se
dersi, così a torso ignudo e tutto muscoloso,
appariva come un gladiatore dopo un duro
cimento. Il disgraziato faceva leva di tanto
in tanto con una mano sul suolo per rizzarsi
definitivamente, ma i piedi gli scivolavano
ogni volta sulla paglia facendolo ricadere a
terra. Àll’improwiso si rovesciò e carpon car
poni si diresse verso un cantuccio della ba
racca per cercare la sua giubba, e non sentì
ragioni — pressato com’era, dagli sguardi smar
riti dei famigliali, a fare gli onori di casa —
finché non ebbe infilata la giubba che per lui
evidentemente costituiva il solo segno del
l’autorità.
Quando fu in piev.. v. tentò di venirci in
contro barcollante, si toccò le spalline e i
gradi applicati sulla manica destra. Subito
dopo, battendo i piedi, come per imporsi
definitivamente la posizione eretta, si carezzò
i baffi, che aveva alla Guglielmo, e aggrot
tando le sopracciglia quasi gridò in pessimo
spagnuolo:
—
A disposiciòn de usted.
Ma fu un irrigidimento troppo energico che
egli doveva subito scontare. Difatti barcollò
due o tre volte tentando l’equilibrio con sva
riati movimenti delle braccia e delle mani e
alla fine stramazzò sulla paglia da cui s’era
faticosamente levato.
Allora i suoi sudditi persero ogni rispetto,
lo lasciarono al suo destino, e vennero in
massa ad accompagnarci al piccolo imbar
cadero.
Ci pareva d’essere diventati le vere auto
rità di San Filippo, a vederci salutati con
tanto riguardo. Tutto il prestigio perduto dal
povero sergente si trasferiva in noi, e difatti,
salutando con gesti cordiali
quella povera
gente,
riuscimmo a
trattenere
la voglia natta
di ridere che
et
aveva pieao allo
snettoeolo


















