
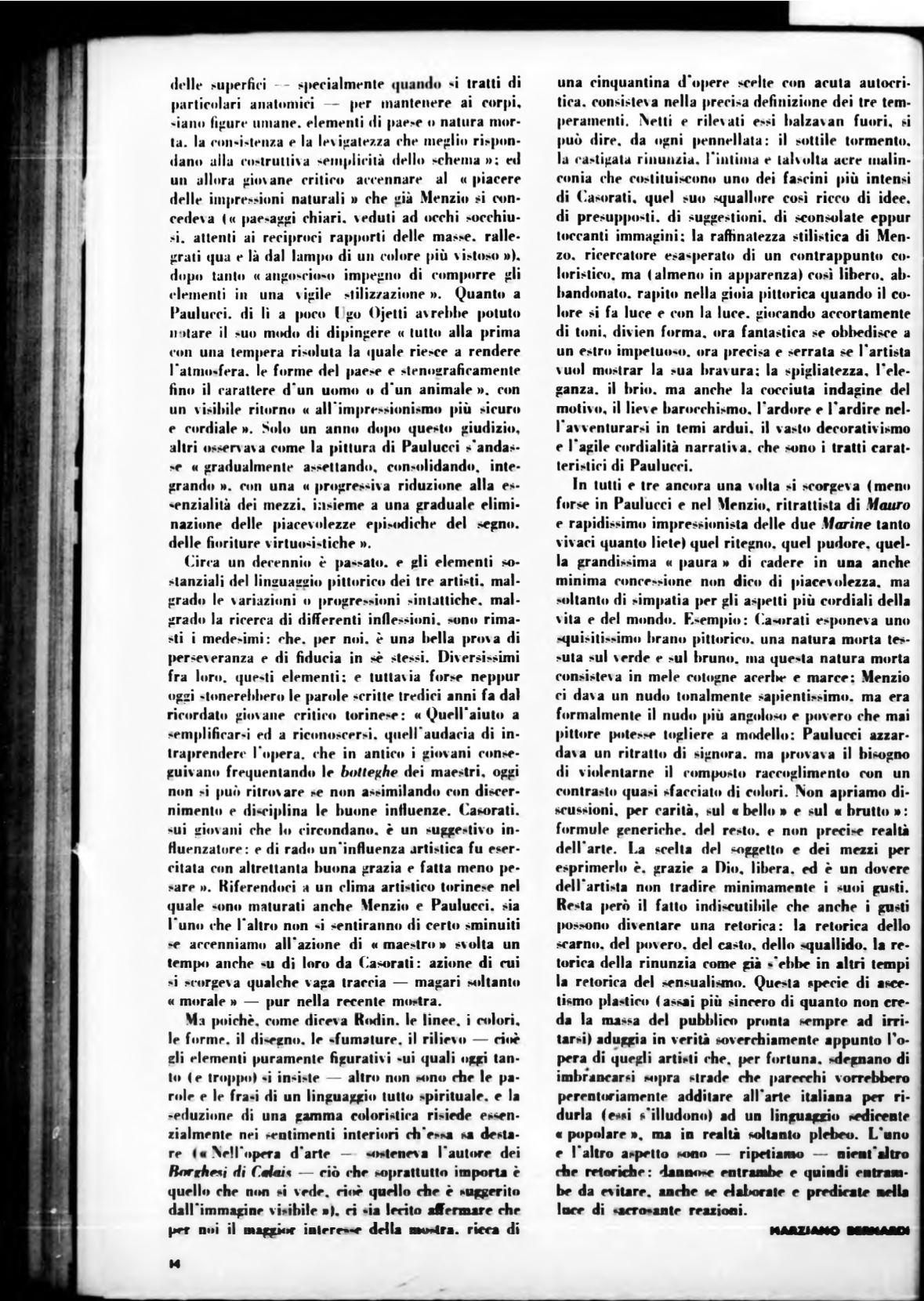
delle superfici — specialmente
si tratti di
particolari anatomici — per mantenere ai corpi,
siano figure umane, elementi ili paese o natura mor
ta. la consistenza e la levigatezza che meglio rispon
dano aiia costruttiva semplicità delio schema »; ed
un allora giovane critico accennare al « piacere
delle impressioni naturali » che "ià Menzio si con
cedeva (« paesani chiari, veduti ad occhi socchiu
si. attenti ai reciproci rapporti delle masse, ralle
grati qua e là dal lampo di un colore più vistoso »).
dopo tanto « angoscioso impegno di comporre gli
clementi in una \ijiile stilizzazione». Quanto a
Paulucci. di lì a poco l go Ojetti avrehhe potuto
nitare il suo modo di dipingere « tutto alla prima
con una tempera risoluta la quale riesce a rendere
l'atmosfera, le forme del paese e stenograficamente
fino il carattere d'un uomo o d'un animale ». con
un visibile ritorno « all'impressionismo più sicuro
e cordiale ». Solo un anno dopo questo giudizio,
altri osservava come la pittura di Paulucci s'andas-
se « gradualmente assettando, consolidando, inte
grando ». con una « progressiva riduzione alla es
senzialità dei mezzi, insieme a una graduale elimi
nazione delle piacevolezze episodiche del segno,
delle fioriture virtuosistiche ».
Circa un decennio è passato, e gli elementi so
stanziali del linguaggio pittorico dei tre artisti, mal
grado le variazioni o progressioni sintattiche, mal
grado la ricerca di differenti inflessioni, sono rima
sti i medesimi: che. per noi. è una hella prova di
perseveranza e di fiducia in sè stessi. Diversissimi
fra loro, questi elementi; e tuttavia forse neppur
oggi stonerebbero le parole scritte tredici anni fa dal
ricordato giovane critico torinese: « (Quell'aiuto a
semplificar*i ed a riconoscersi, queli'audacia di in
traprendere l'opera, che in antico i giovani conse
guivano frequentando le
botteghe
dei maestri, oggi
non si può ritrovare se non assimilando con discer
nimento e disciplina le huone influenze. Casorati,
sui giovani che lo circondano, è un suggestivo in-
Huenzatore: e di rado un'influenza artistica fu eser
citata con altrettanta huona grazia e fatta meno pe
sare ». Riferendoci a un clima artistico torinese nel
quale sono maturati anche Menzio e Paulucci. sia
l'uno che l'altro non «i sentiranno di certo sminuiti
•e accenniamo all'azione di «maestro» svolta un
tempo anche *u di loro da Casorati: azione di cui
si scorgeva qualche vaga traccia — magari soltanto
« morale » — pur nella recente mostra.
Ma poiché, come diceva Rodin. le linee, i colori,
le forme, il disegno, le sfumature, il rilievo — cioè
gli elementi puramente figurativi sui quali oggi tan
to (e troppo) sì insiste — altro non Mino che le pa
role e le fra>i di un linguaggio tutto spirituale, e la
•eduzione di una gamma coloristica risiede essen
zialmente nei sentimenti interiori ch‘rt>M sa desta
re Nell'opera d'arte — «otteneva l'autore dei
Borghesi di Calai
« — ciò che soprattutto importa è
quello che non si vede, cioè quello che è suggerito
dall'immagine visibile a), ri *ia Irrito affermare che
per noi il maggior intrrr»-e della mostra, riera di
una cinquantina d'opere scelte con acuta autocri
tica. consisteva nella precisa definizione dei tre tem
peramenti. Netti e rilevati essi halzavan fuori, si
può dire, da ogni pennellata: il sottile tormento,
la castigata rinunzia, l'intima e talvolta acre malin
conia che costituiscono uno dei fascini più intensi
di Casorati, quel suo squallore così ricco di idee,
di presupposti, di suggestioni, di sconsolate eppur
toccanti immagini; la raffinatezza stilistica di Men-
zo. ricercatore esasperato di un contrappunto co
loristico. ma (almeno in apparenza) così libero, ab
bandonato. rapito nella gioia pittorica quando il co
lore si fa luce e con la luce, giocando accortamente
di toni, divien forma, ora fantastica se obbedisce a
un estro impetuoso, ora precisa e serrata se l'artista
vuol mostrar la sua bravura; la spigliatezza, l'ele
ganza. il brio, ma anche la cocciuta indagine del
motivo, il lieve barocchismo, l'ardore e l'ardire nel-
l'avventurarsi in temi ardui, il vasto decorativismo
e l'agile cordialità narrativa, che sono i tratti carat
teristici di Paulucci.
In tutti e tre ancora una volta si scorgeva (meno
forse in Paulucci e nel Menzio. ritrattista di
Mauro
e rapidissimo impressionista delle due
Marine
tanto
vivaci quanto liete) quel ritegno, quel pudore, quel
la grandissima « paura » di cadere in una anche
minima concessione non dico di piacevolezza, ma
soltanto di simpatia per gli aspetti più cordiali della
vita e del mondo. Esempio: Casorati esponeva uno
squisitissimo brami pittorico, una natura morta tes
suta sul verde e sul bruno, ma questa natura morta
consisteva in mele cotogne aceri»** e marce: Menzio
ci dava un nudo tonalmente sapientissimo, ma era
formalmente il nudo più angolosi! e povero che mai
pittore potesse togliere a modello: Paulucci azzar
dava un ritratto di signora, ma provava il bisogno
di violentarne il composto raccoglimento con un
contrasto quasi sfacciato di colori. Non apriamo di
scussioni. per carità, sul « bello » e sul « brutto »:
formule generiche, del resto, e non precise realtà
dell'arte. La scelta del soggetto e dei mezzi per
esprimerlo è. grazie a Dio, libera, ed è un dovere
dell'artista non tradire minimamente i suoi gusti.
Resta però il fatto indiscutibile che anche i gusti
posano diventare una retorica: la retorica dello
scarno, del povero, del casto, dello squallido, la re
torica della rinunzia come già «'ebbe in altri tempi
la retorica del sensualismo. Questa specie di asce
tismo plastico (assai più sincero di quanto non cre
da la massa del pubblico pronta sempre ad irri
tarsi) aduggìa in verità soverchiamente appunto l'o
pera di quegli articti che. per fortuna, sdegnano di
imbrancarsi sopra strade che parerrhi vorrebbero
perentoriamente additare all'arte italiana per ri
durla (essi s'illudono) ad un linguaggio sedicente
« popolarr ». ma in rraltà soltanto plebeo. L'uno
r l'altro aspetto sono — ripetiamo — nient'altro
chr retoriche: dannose entrambe e quindi entram
be da rvitarr. anche se elaborate e predicate nella
luce di -acro-ante rrazioni.
MARZIANO MftNAJkOt
M


















