
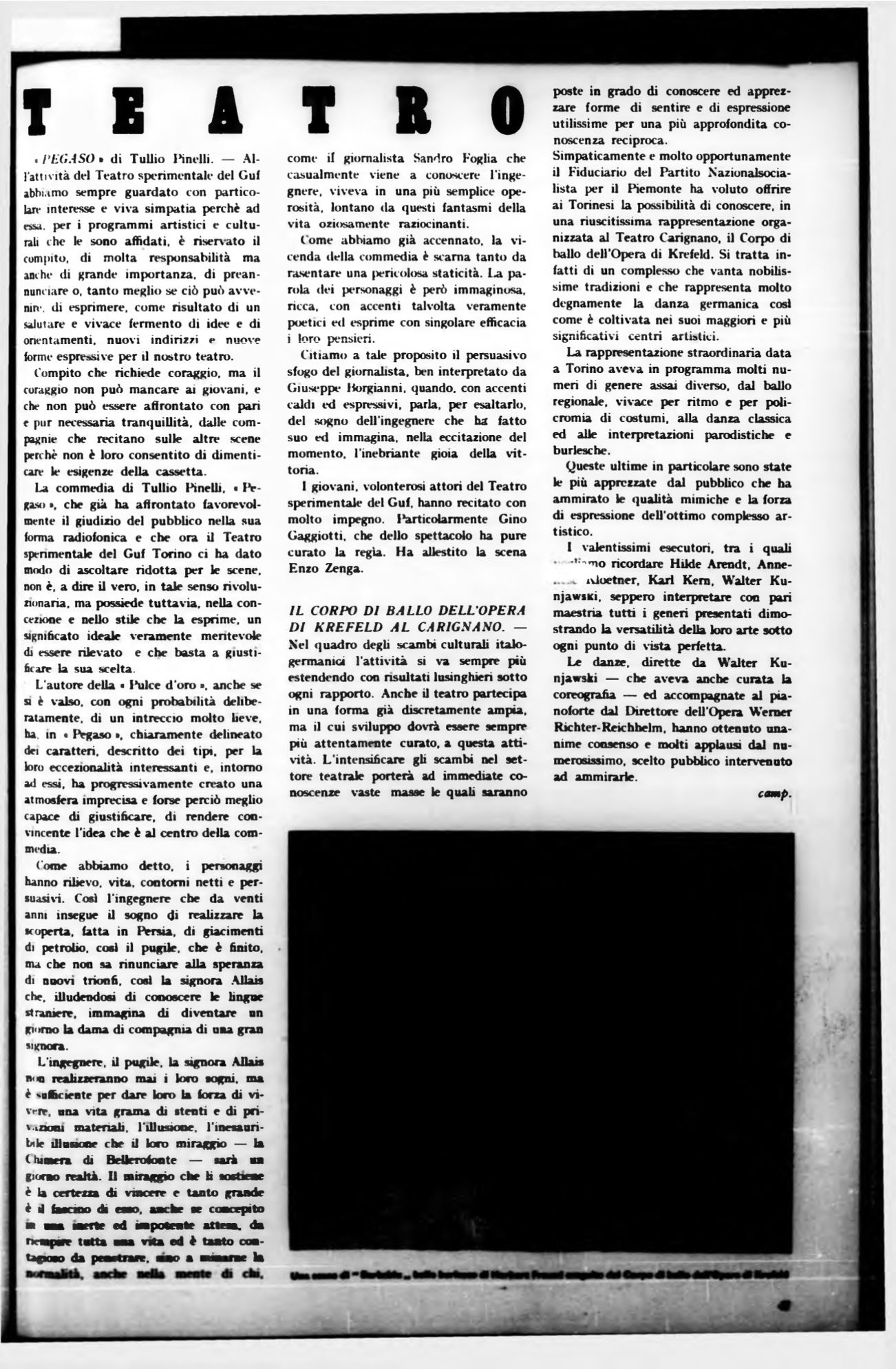
T E A
•
PEGASO
» di Tullio lancili. — Al
l'attività del Teatro sperimentale del Guf
abbuino sempre guardato con partico
lare interesse e viva simpatia perchè ad
essa, per i programmi artistici e cultu
rali che le sono affidati, è riservato il
compito, di molta responsabilità ma
anche di grande importanza, di prean
nunciare o, tanto meglio se ciò può avve-
nin\ di esprimere, come risultato di un
salutare e vivace fermento di idee e di
orientamenti, nuovi indirizzi e nuove
forme espressive per il nostro teatro.
Compito che richiede coraggio, ma il
coraggio non può mancare ai giovani, e
che non può essere affrontato con pari
e pur necessaria tranquillità, dalle com
pagnie che recitano sulle altre scene
perchè non è loro consentito di dimenti
care le esigenze della cassetta.
La commedia di Tullio Pinelli. • Pe
gaso >, che già ha affrontato favorevol
mente il giudizio del pubblico nella sua
forma radiofonica e che ora il Teatro
sperimentale del Guf Torino ci ha dato
modo di ascoltare ridotta per le scene,
non è. a dire il vero, in tale senso rivolu
zionaria. ma possiede tu ttavia, nella con
cezione e nello stile che la esprime, un
significato ideale veramente meritevole
di essere rilevato e che basta a giusti
ficare la sua scelta.
L'autore della « l*ulce d'oro ». anche se
si è valso, con ogni probabilità delibe
ratamente. di un intreccio molto lieve,
ha. in • Pegaso », chiaramente delineato
dei caratteri, descritto dei tipi, per la
loro eccezionalità interessanti e, intorno
ad essi, ha progressivamente creato una
atmosfera imprecisa e forse perciò meglio
capace di giustificare, di rendere con
vincente l'idea che
è
al centro della com
media.
Come abbiamo detto, i personaggi
hanno rilievo, vita, contorni netti e per
suasivi. Cosi l'ingegnere che da venti
anni insegue il sogno di realizzare la
scoperta, fatta in Persia, di giacimenti
di petrolio, cosi il pugile, che
è
finito,
ma che non sa rinunciare alla speranza
di nuovi trionfi, cosi la signora Allais
che, illudendosi di conoscere le lingue
straniere, immagina di diventare un
giorno la dama di compagnia di una gran
signora.
L'ingegnere, il pugile, la signora Allais
non realizzeranno mai i loro sogni, ma
è sufficiente per dare loro la forza di vi*
vt-rr. una vita grama di stenti e di pri-
vtnoni materiali, l'illusione, l ’inesauri-
biie illusone che il loro miraggio — la
Ctu
mera
di
Belkrofoote
— sarà
un
giorno
realtà.
11
miraggio
che li
sostiene
è la certezza di vincere
e
tanto
grande
è
il
faariao di o n . anche ae concepito
m
n i tante ed impotente attesa, da
riempii* tutta una vita ed
è
tanto con
tagioso da penetrare,
mmo
a minarne h
T R 0
come il giornalista Sandro Foglia che
casualmente viene a conoscere l ’inge
gnere, viveva in una più semplice ope
rosità, lontano da questi fantasmi della
vita oziosamente raziocinanti.
Come abbiamo già accennato, la v i
cenda della commedia è scarna tanto da
rasentare una pericolosa staticità. l.a pa
rola dei personaggi è però immaginosa,
ricca, con accenti talvolta veramente
poetici ed esprime con singolare efficacia
i loro pensieri.
Citiamo a tale proposito il persuasivo
sfogo del giornalista, ben interpretato da
Giuseppe liorgianni, quando, con accenti
caldi ed espressivi, parla, per esaltarlo,
del sogno dell'ingegnere che ha fatto
suo ed immagina, nella eccitazione del
momento, l ’inebriante gioia della v it
toria.
I giovani, volonterosi attori del Teatro
sperimentale del Guf. hanno recitato con
molto impegno. l ‘articolarmente Gino
Gaggiotti, che dello spettacolo ha pure
curato la regia. Ha allestito la scena
Enzo Zenga.
IL CORP i) DI BALLO DELL'OPERA
DI KREFELD AL CARIGNANO. —
Nel quadro degli scambi culturali italo-
germanici l'attività si va sempre più
estendendo con risultati lusinghieri so tto
ogni rapporto. Anche il teatro partecipa
in una forma già discretamente ampia,
ma il cui sviluppo dovrà essere sempre
più attentamente curato, a questa a tti
vità. L ’intensificare gli scambi nel se t
tore teatrale porterà ad immediate co
noscenze vaste masse le quali saranno
poste in grado di conoscere ed apprez
zare forme di sentire e di espressione
utilissime per una più approfondita co
noscenza reciproca.
Simpaticamente e molto opportunamente
il Fiduciario del Partito Nazionalsocia
lista per il Piemonte ha voluto offrire
ai Torinesi la possibilità di conoscere, in
una riuscitissima rappresentazione orga
nizzata al Teatro Carignano, il Corpo di
ballo dell’Opera di Krefeld. Si tratta in
fatti di un complesso che vanta nobilis
sime tradizioni e che rappresenta molto
degnamente la danza germanica cosi
come è coltivata nei suoi maggiori e più
significativi centri artistici.
La rappresentazione straordinaria data
a Torino aveva in programma molti nu
meri di genere assai diverso, dal ballo
regionale, vivace per ritmo e per poli
cromia di costumi, alla danza classica
ed alle interpretazioni parodistiche e
burlesche.
Queste ultime in particolare sono state
le più apprezzate dal pubblico che ha
ammirato le qualità mimiche e la forza
di espressione dell’ottimo complesso ar
tistico.
I
valentissimi esecutori, tra i quali
" ' "
t io
ricordare Hilde Arendt, Anne-
xUoetner, Karl Kern, Walter Ku-
njawsKi, seppero interpretare con pari
maestria tu tti i generi presentati dimo
strando la versatilità della loro arte sotto
ogni punto di vista perfetta.
Le danze, dirette da Walter Ku-
njawski — che aveva anche curata la
coreografia — ed accompagnate al pia
noforte dal Direttore dell'Opera Werner
Rkhter-Reichhelm, hanno ottenuto una
nime consenso e molti applausi dal nu
merosissimo, scelto pubblico intervenuto
ad ammirarle.
camp.


















