
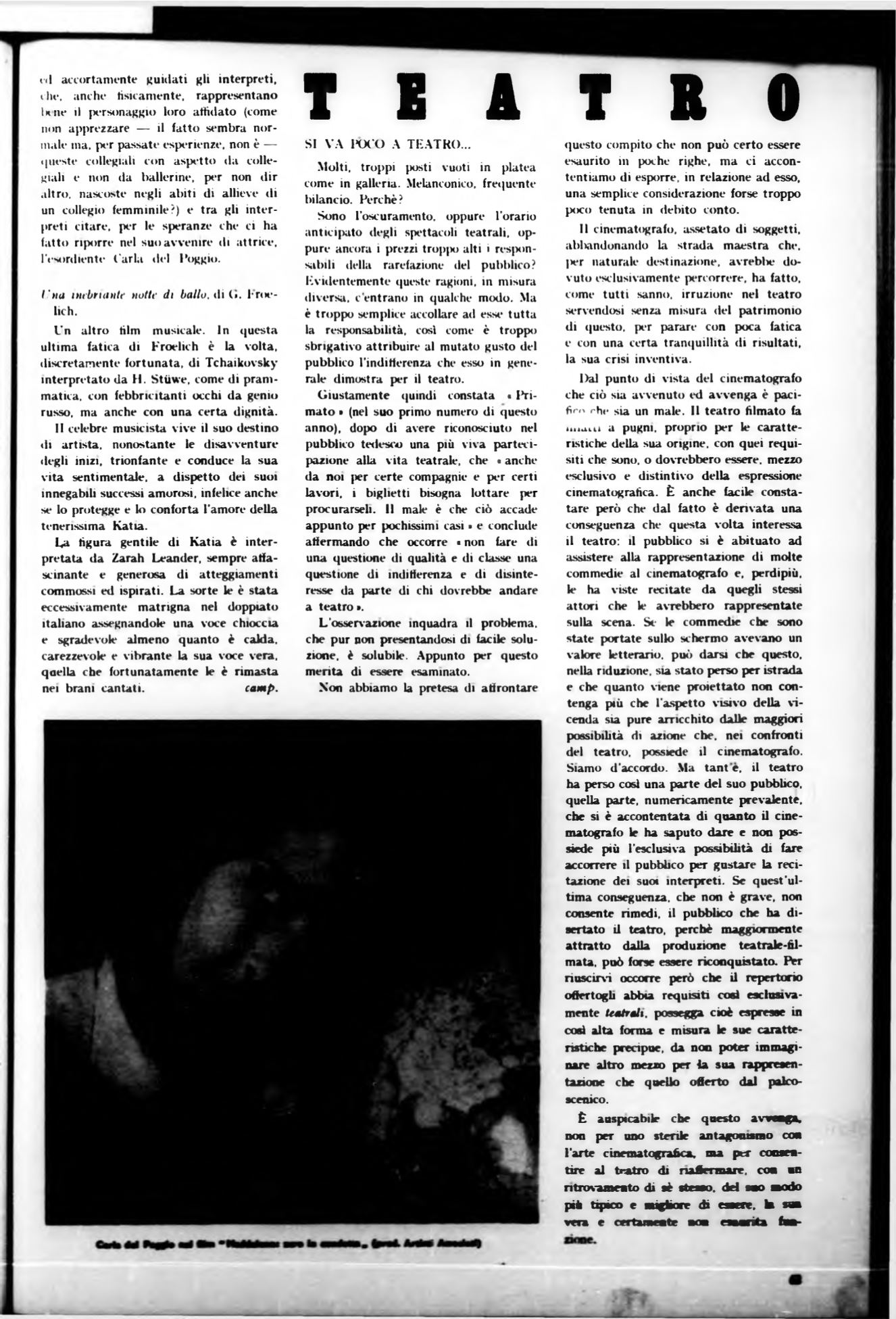
id accortamente guidati gli interpreti,
che, anche tisicamente, rappresentano
Une il personaggio loro affidato (come
non apprezzare — il fatto sembra nor
male ma. per passate esperienze, non è —
queste collegiali con aspetto da colle
giali e non da ballerine, per non dir
.litri), nascoste negli abiti di allieve di
un collegio femminile?) e tra gli inter
preti citare, per le speranze che ci ha
fatto riporre nel suo avvenire di attrice,
l'esordiente Carla del Poggio.
Una inebriante notte di ballo,
di («. 1-roe-
lich.
Un altro film musicale. In questa
ultima fatica di Froelich è la volta,
discretamente fortunata, di Tchaikovsky
interpretato da H. Stùwe, come di pram
matica. con febbricitanti occhi da genio
russo, ma anche con una certa dignità.
II celebre musicista vive il suo destino
di artista, nonostante le disavventure
degli inizi, trionfante e conduce la sua
vita sentimentale, a dispetto dei suoi
innegabili successi amorosi, infelice anche
se lo protegge e lo conforta l’amore della
tenerissima Katia.
La figura gentile di Katia è inter
pretata da Zarah Leander, sempre affa
scinante e generosa di atteggiamenti
commossi ed ispirati. La sorte le è stata
eccessivamente matrigna nel doppiato
italiano assegnandole una voce chioccia
e sgradevole almeno quanto è calda,
carezzevole e vibrante la sua voce vera,
quella che fortunatamente le è rimasta
nei brani cantati.
camp.
T E A
SI VA POCO A TEATRO...
Molti, troppi posti vuoti in platea
come in galleria. Melanconico, frequente
bilancio. Perchè?
Sono l’oscuramento, oppure l’orario
anticipato degli spettacoli teatrali, op
pure ancora i prezzi troppo alti i respon
sabili della rarefazione del pubblico?
Evidentemente queste ragioni, in misura
diversa, c entrano in qualche modo. Ma
è troppo semplice accollare ad esse tutta
la responsabilità, così come è troppo
sbrigativo attribuire al mutato gusto del
pubblico l’indifferenza che esso in gene
rale dimostra per il teatro.
Giustamente quindi constata « Pri
mato > (nel suo primo numero di questo
anno), dopo di avere riconosciuto nel
pubblico tedesco una più viva parteci
pazione alla vita teatrale, che * anche
da noi per certe compagnie e per certi
lavori, i biglietti bisogna lottare per
procurarseli. 11 male è che ciò accade
appunto per pochissimi casi >e conclude
affermando che occorre ■non fare di
una questione di qualità e di classe una
questione di indifferenza e di disinte
resse da parte di chi dovrebbe andare
a teatro ».
L ’osservazione inquadra il problema,
che pur non presentandosi di facile solu
zione, è solubile. Appunto per questo
merita di essere esaminato.
Non abbiamo la pretesa di affrontare
T R 0
questo compito che non può certo essere
esaurito in poche righe, ma ci accon
tentiamo di esporre, in relazione ad esso,
una semplice considerazione forse troppo
poco tenuta in debito conto.
Il cinematografo, assetato di soggetti,
abltandonando Li strada maestra che,
]>er naturale destinazione, avreblx; do
vuto esclusivamente percorrere, ha fatto,
come tutti sanno, irruzione nel teatro
servendosi senza misura del patrimonio
di questo, per parare con poca fatica
e con una certa tranquillità di risultati,
la sua crisi inventiva.
Dal punto di vista del cinematografo
che ciò sia avvenuto ed avvenga è paci-
6™ <-he sia un male. Il teatro filmato fa
liilUlll il pugni, proprio per le caratte
ristiche della sua origine, con quei requi
siti che sono, o dovrebbero essere, mezzo
esclusivo e distintivo della espressione
cinematografica. È anche facile consta
tare però che dal fatto è derivata una
conseguenza che questa volta interessa
il teatro: il pubblico si è abituato ad
assistere alla rappresentazione di molte
commedie al cinematografo e, perdipiù,
le ha viste recitate da quegli stessi
attori che le avrebbero rappresentate
sulla scena. Se le commedie che sono
state portate sullo schermo avevano un
valore letterario, può darsi che questo,
nella riduzione, sia stato perso per istrada
e che quanto viene proiettato non con
tenga più che l'aspetto visivo della vi
cenda sia pure arricchito dalle maggiori
possibilità di azione che. nei confronti
del teatro, possiede il cinematografo.
Siamo d’accordo. Ma tant e, il teatro
ha perso così una parte del suo pubblico,
quella parte, numericamente prevalente,
che si è accontentata di quanto il cine
matografo le ha saputo dare e non pos
siede più l’esclusiva possibilità di fare
accorrere il pubblico per gustare la reci
tazione dei suo» interpreti. Se quest’ul-
tima conseguenza, che non è grave, non
consente rimedi, il pubblico che ha di
sertato il teatro, perchè maggiormente
attratto dalla produzione teatrale-fil-
mata. può forse essere riconquistato. Per
riuscirvi occorre però che il repertorio
offertogli abbia requisiti così esclusiva
mente
teatrali,
possegga cioè espresse in
così alta forma e misura le sue caratte
ristiche precipue, da non poter immagi
nare altro mezzo per la sua rappresen
tazione che quello offerto dal palco-
scenico.
£ auspicabile che questo avvenga,
non per uno sterile antagonismo con
l’arte cinematografica, ma per consen
tire al teatro di naflennare, eoo un
ritrovamento di sè stesso, del sao modo
più tipico e migliare di essere. In san
vera e certamente non enanrit n
imt-


















