
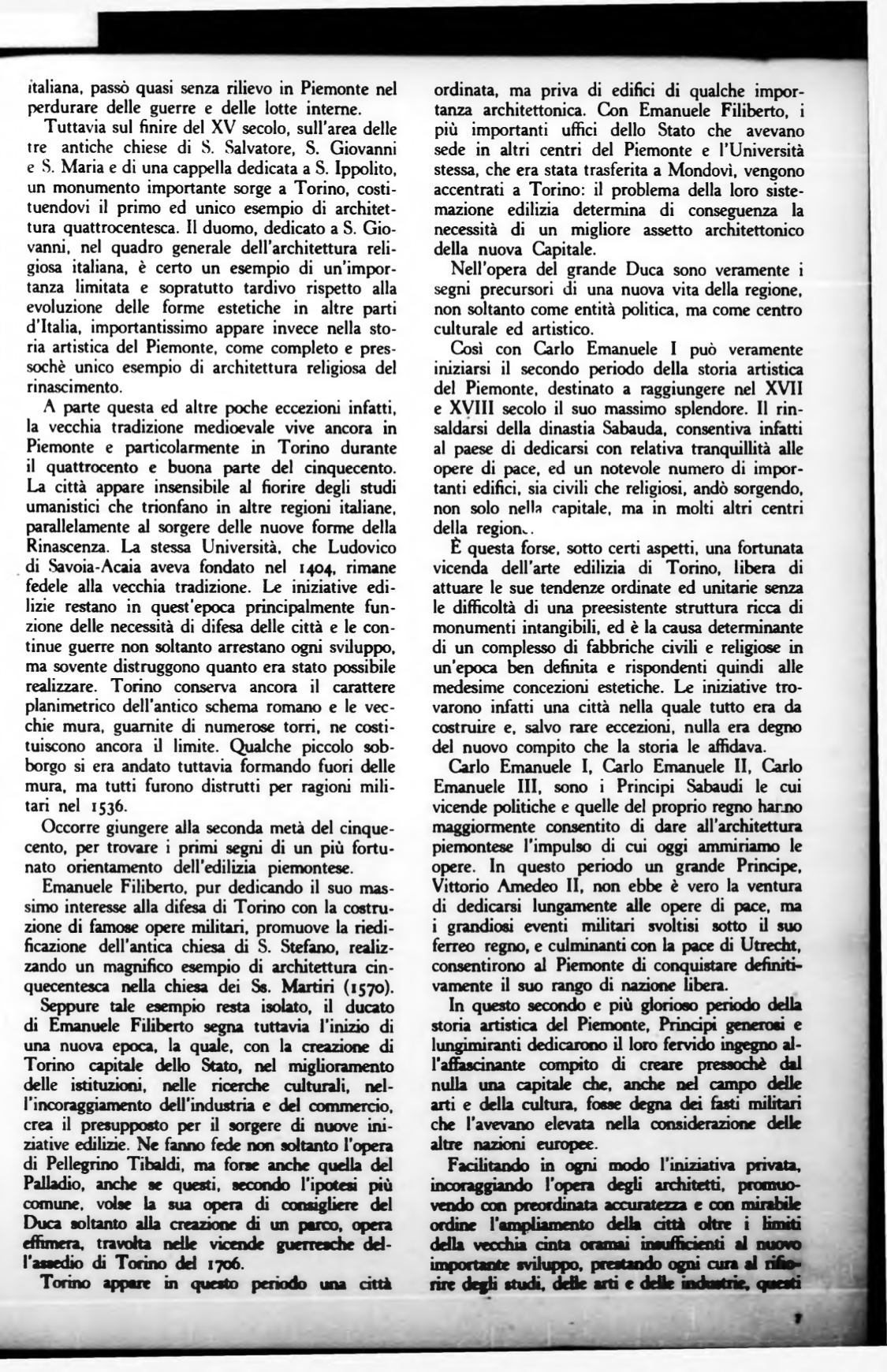
italiana, passò quasi senza rilievo in Piemonte nel
perdurare delle guerre e delle lotte interne.
Tuttavia sul finire del XV secolo, sull'area delle
tre antiche chiese di S. Salvatore, S. Giovanni
e S. Maria e di una cappella dedicata a S. Ippolito,
un monumento importante sorge a Torino, costi
tuendovi il primo ed unico esempio di architet
tura quattrocentesca. Il duomo, dedicato a S. Gio
vanni, nel quadro generale dell’architettura reli
giosa italiana, è certo un esempio di un’impor
tanza limitata e sopratutto tardivo rispetto alla
evoluzione delle forme estetiche in altre parti
d’Italia, importantissimo appare invece nella sto
ria artistica del Piemonte, come completo e pres
soché unico esempio di architettura religiosa del
rinascimento.
A parte questa ed altre poche eccezioni infatti,
la vecchia tradizione medioevale vive ancora in
Piemonte e particolarmente in Torino durante
il quattrocento e buona parte del cinquecento.
La città appare insensibile al fiorire degli studi
umanistici che trionfano in altre regioni italiane,
parallelamente al sorgere delle nuove forme della
Rinascenza. La stessa Università, che Ludovico
di Savoia-Acaia aveva fondato nel 1404, rimane
fedele alla vecchia tradizione. Le iniziative edi
lizie restano in quest’epoca principalmente fun
zione delle necessità di difesa delle città e le con
tinue guerre non soltanto arrestano ogni sviluppo,
ma sovente distruggono quanto era stato possibile
realizzare. Torino conserva ancora il carattere
pianimetrico dell’antico schema romano e le vec
chie mura, guarnite di numerose torri, ne costi
tuiscono ancora il limite. Qualche piccolo sob
borgo si era andato tuttavia formando fuori delle
mura, ma tutti furono distrutti per ragioni mili
tari nel 1536.
Occorre giungere alla seconda metà del cinque
cento, per trovare i primi segni di un più fortu
nato orientamento dell’edilizia piemontese.
Emanuele Filiberto, pur dedicando il suo mas
simo interesse alla difesa di Torino con la costru
zione di famose opere militari, promuove la riedi
ficazione dell’antica chiesa di S. Stefano, realiz
zando un magnifico esempio di architettura cin
quecentesca nella chiesa dei Ss. Martiri (1570).
Seppure tale esempio resta isolato, il ducato
di Emanuele Filiberto segna tuttavia l’inizio di
una nuova epoca, la quale, con la creazione di
Torino capitale dello Stato, nel miglioramento
delle istituzioni, nelle ricerche culturali, nel
l’incoraggiamento deU’industria e del commercio,
crea il presupposto per il sorgere di nuove ini
ziative edilizie. Ne fanno fede non soltanto l'opera
di Pellegrino Tibaldi, ma forse anche quella del
Palladio, anche se questi, secondo l’ipotesi più
comune, volse la sua opera di consigliere del
Duca soltanto alla creazione di un parco, opera
effìmera, travolta nelle vicende
guerresche
del
l'assedio di Torino del 1706.
Torino appare in questo periodo una città
ordinata, ma priva di edifici di qualche impor
tanza architettonica. Con Emanuele Filiberto, i
più importanti uffici dello Stato che avevano
sede in altri centri del Piemonte e l’Università
stessa, che era stata trasferita a Mondovì, vengono
accentrati a Torino: il problema della loro siste
mazione edilizia determina di conseguenza la
necessità di un migliore assetto architettonico
della nuova Capitale.
Nell’opera del grande Duca sono veramente i
segni precursori di una nuova vita della regione,
non soltanto come entità politica, ma come centro
culturale ed artistico.
Così con Carlo Emanuele I può veramente
iniziarsi il secondo periodo della storia artistica
del Piemonte, destinato a raggiungere nel XVII
e XVIII secolo il suo massimo splendore. Il rin
saldarsi della dinastia Sabauda, consentiva infatti
al paese di dedicarsi con relativa tranquillità alle
opere di pace, ed un notevole numero di impor
tanti edifìci, sia civili che religiosi, andò sorgendo,
non solo nella capitale, ma in molti altri centri
della regione.
£ questa forse, sotto certi aspetti, una fortunata
vicenda dell’arte edilizia di Torino, libera di
attuare le sue tendenze ordinate ed unitarie senza
le difficoltà di una preesistente struttura ricca di
monumenti intangibili, ed è la causa determinante
di un complesso di fabbriche civili e religiose in
un’epoca ben definita e rispondenti quindi alle
medesime concezioni estetiche. Le iniziative tro
varono infatti una città nella quale tutto era da
costruire e, salvo rare eccezioni, nulla era degno
del nuovo compito che la storia le affidava.
Carlo Emanuele I, Carlo Emanuele II, Carlo
Emanuele III, sono i Principi Sabaudi le cui
vicende politiche e quelle del proprio regno hanno
maggiormente consentito di dare all’architettura
piemontese l’impulso di cui oggi ammiriamo le
opere. In questo periodo un grande Principe,
Vittorio Amedeo II, non ebbe è vero la ventura
di dedicarsi lungamente alle opere di pace, ma
i grandiosi eventi militari svoltisi sotto il suo
ferreo regno, e culminanti con la pace di Utrecht,
consentirono al Piemonte di conquistare definiti»
vamente il suo rango di nazione Ubera.
In questo secondo e più glorioGo periodo della
storia artistica del Piemonte, Principi generosi e
lungimiranti dedicarono il loro fervido ingegno al
l’affascinante compito di creare pressoché dal
nulla una capitale che, anche nel campo delle
arti e della cultura, fosse degna dei fasti militari
che l’avevano elevata nella considerazione delle
altre nazioni europee.
Facilitando in ogni modo l’iniziativa privata,
incoraggiando l’opera degli architetti, promuo
vendo con preordinata accuratezza e con mirabile
ordine l’ampliamento della città oltre i limiti
della vecchia cinta oramai insufficienti al nuovo
importante sviluppo, prestando ogni cura al rife
rire degli studi, delle arti e delle industrie, questi


















