
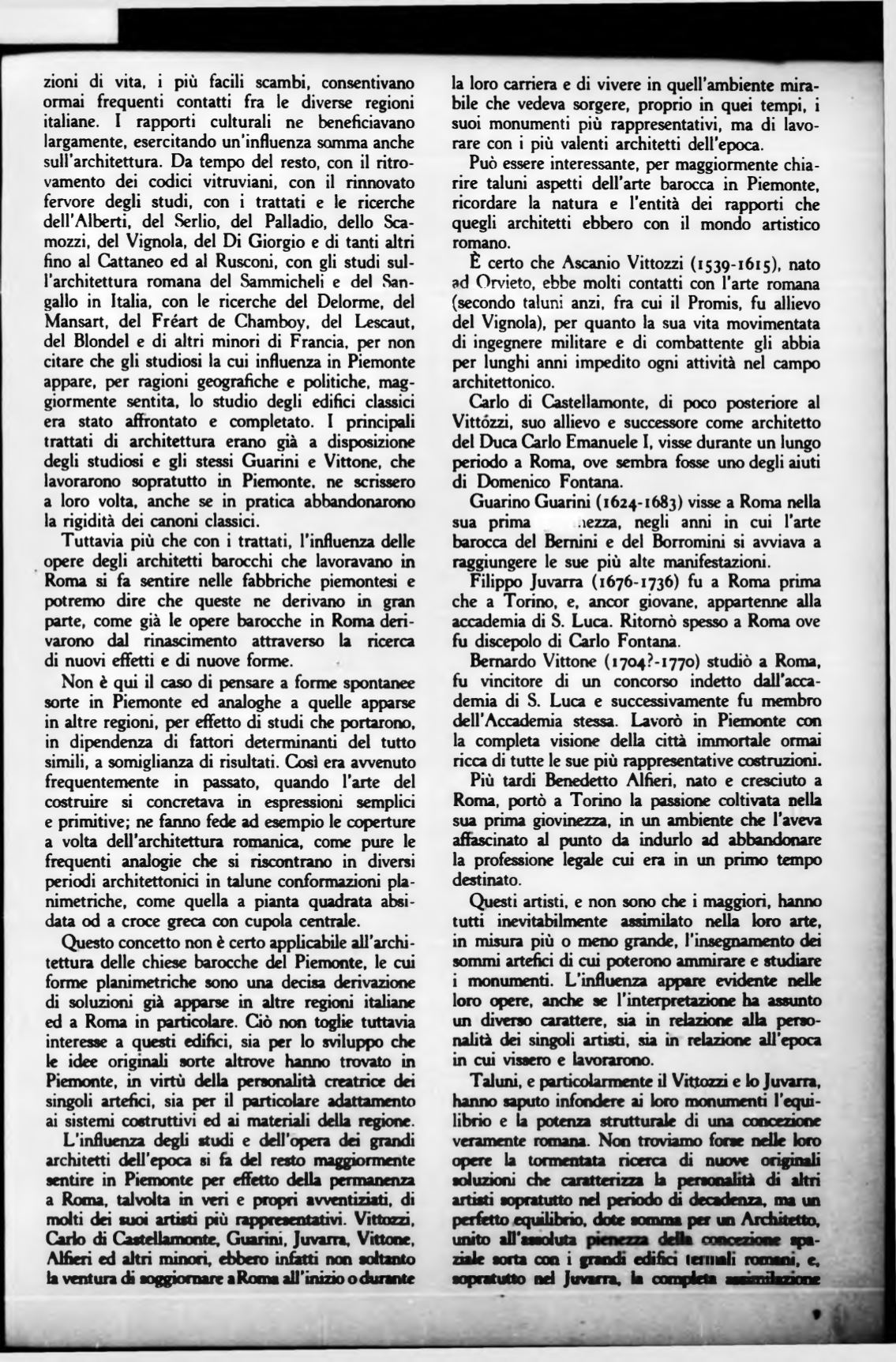
zioni di vita, i più facili scambi, consentivano
ormai frequenti contatti fra le diverse regioni
italiane. I rapporti culturali ne beneficiavano
largamente, esercitando un’influenza somma anche
sull’architettura. Da tempo del resto, con il ritro
vamento dei codici vitruviani, con il rinnovato
fervore degli studi, con i trattati e le ricerche
deH’Alberti, del Serlio, del Palladio, dello Sca-
mozzi, del Vignola, del Di Giorgio e di tanti altri
fino al Cattaneo ed al Rusconi, con gli studi sul
l’architettura romana del Sammicheli e del San-
gallo in Italia, con le ricerche del Delorme, del
Mansart, del Fréart de Chamboy, del Lescaut,
del Blondel e di altri minori di Francia, per non
citare che gli studiosi la cui influenza in Piemonte
appare, per ragioni geografiche e politiche, mag
giormente sentita, lo studio degli edifìci classici
era stato affrontato e completato. I principali
trattati di architettura erano già a disposizione
degli studiosi e gli stessi Guarini e Vittone, che
lavorarono sopratutto in Piemonte, ne scrissero
a loro volta, anche se in pratica abbandonarono
la rigidità dei canoni classici.
Tuttavia più che con i trattati, l'influenza delle
opere degli architetti barocchi che lavoravano in
Roma si fa sentire nelle fabbriche piemontesi e
potremo dire che queste ne derivano in gran
parte, come già le opere barocche in Roma deri
varono dal rinascimento attraverso la ricerca
di nuovi effetti e di nuove forme.
Non è qui il caso di pensare a forme spontanee
sorte in Piemonte ed analoghe a quelle apparse
in altre regioni, per effetto di studi che portarono,
in dipendenza di fattori determinanti del tutto
simili, a somiglianza di risultati. Così era avvenuto
frequentemente in passato, quando l’arte del
costruire si concretava in espressioni semplici
e primitive; ne fanno fede ad esempio le coperture
a volta dell’architettura romanica, come pure le
frequenti analogie che si riscontrano in diversi
periodi architettonici in talune conformazioni pia
nimetriche, come quella a pianta quadrata absi-
data od a croce greca con cupola centrale.
Questo concetto non è certo applicabile all’archi
tettura delle chiese barocche del Piemonte, le cui
forme pianimetriche sono una decisa derivazione
di soluzioni già apparse in altre regioni italiane
ed a Roma in particolare. Ciò non toglie tuttavia
interesse a questi edifìci, sia per lo sviluppo che
le idee originali sorte altrove hanno trovato in
Piemonte, in virtù della personalità creatrice dei
singoli artefici, sia per il particolare adattamento
ai sistemi costruttivi ed ai materiali della regione.
L ’influenza degli studi e dell’opera dei grandi
architetti dell’epoca si fa del resto maggiormente
sentire in Piemonte per effetto della permanenza
a Roma, talvolta in veri e propri avventiziati, di
molti dei suoi artisti più rappresentativi. Vittozzi,
Carlo di Castellamonte, Guarini, Juvarra, Vittone,
Alfieri ed altri minori, ebbero infitti non soltanto
la ventura di soggiornare aRoma all'inizio o durante
la loro carriera e di vivere in quell’ambiente mira
bile che vedeva sorgere, proprio in quei tempi, i
suoi monumenti più rappresentativi, ma di lavo
rare con i più valenti architetti dell’epoca.
Può essere interessante, per maggiormente chia
rire taluni aspetti dell’arte barocca in Piemonte,
ricordare la natura e l’entità dei rapporti che
quegli architetti ebbero con il mondo artistico
romano.
È certo che Ascanio Vittozzi (1539 -16 15), nato
ad Orvieto, ebbe molti contatti con l’arte romana
(secondo taluni anzi, fra cui il Promis, fu allievo
del Vignola), per quanto la sua vita movimentata
di ingegnere militare e di combattente gli abbia
per lunghi anni impedito ogni attività nel campo
architettonico.
Carlo di Castellamonte, di poco posteriore al
Vittozzi, suo allievo e successore come architetto
del Duca Carlo Emanuele I, visse durante un lungo
periodo a Roma, ove sembra fosse uno degli aiuti
di Domenico Fontana.
Guarino Guarini (1624-1683) visse a Roma nella
sua prima
.ìezza, negli anni in cui l’arte
barocca del Bernini e del Borromini si avviava a
raggiungere le sue più alte manifestazioni.
Filippo Juvarra (1676-1736) fu a Roma prima
che a Torino, e, ancor giovane, appartenne alla
accademia di S. Luca. Ritornò spesso a Roma ove
fu discepolo di Carlo Fontana.
Bernardo Vittone (i704?-i770) studiò a Roma,
fu vincitore di un concorso indetto dall'acca
demia di S. Luca e successivamente fu membro
dell’Accademia stessa. Lavorò in Piemonte con
la completa visione della città immortale ormai
ricca di tutte le sue più rappresentative costruzioni.
Più tardi Benedetto Alfieri, nato e cresciuto a
Roma, portò a Torino la passione coltivata nella
sua prima giovinezza, in un ambiente che l’aveva
affascinato al punto da indurlo ad abbandonare
la professione legale cui era in un primo tempo
destinato.
Questi artisti, e non sono che i maggiori, hanno
tutti inevitabilmente assimilato nella loro arte,
in misura più o meno grande, l’insegnamento dei
sommi artefici di cui poterono ammirare e studiare
i monumenti. L ’influenza appare evidente nelle
loro opere, anche se l'interpretazione ha assunto
un diverso carattere, sia in relazione alla perso
nalità dei singoli artisti, sia in relazione all’epoca
in cui vissero e lavorarono.
Taluni, e particolarmente il Vittozzi e lo Juvarra,
hanno saputo infondere ai loro monumenti l’equi
librio e la potenza strutturale di una concezione
veramente romana. Non troviamo forse nelle loro
opere la tormentata ricerca di nuove originali
soluzioni che caratterizza la personalità di altri
artisti sopratutto nel periodo di
decadenza, ma un
perfetto equilibrio,
dote somma per un
Architetto,
unito all’assoluta
rifila mnrrrinn» spa
ziale sorta con
i
grandi edifici
ih
ikbtli romani, e»
sopratutto nel Juvarra, la compieta assimilazione


















