
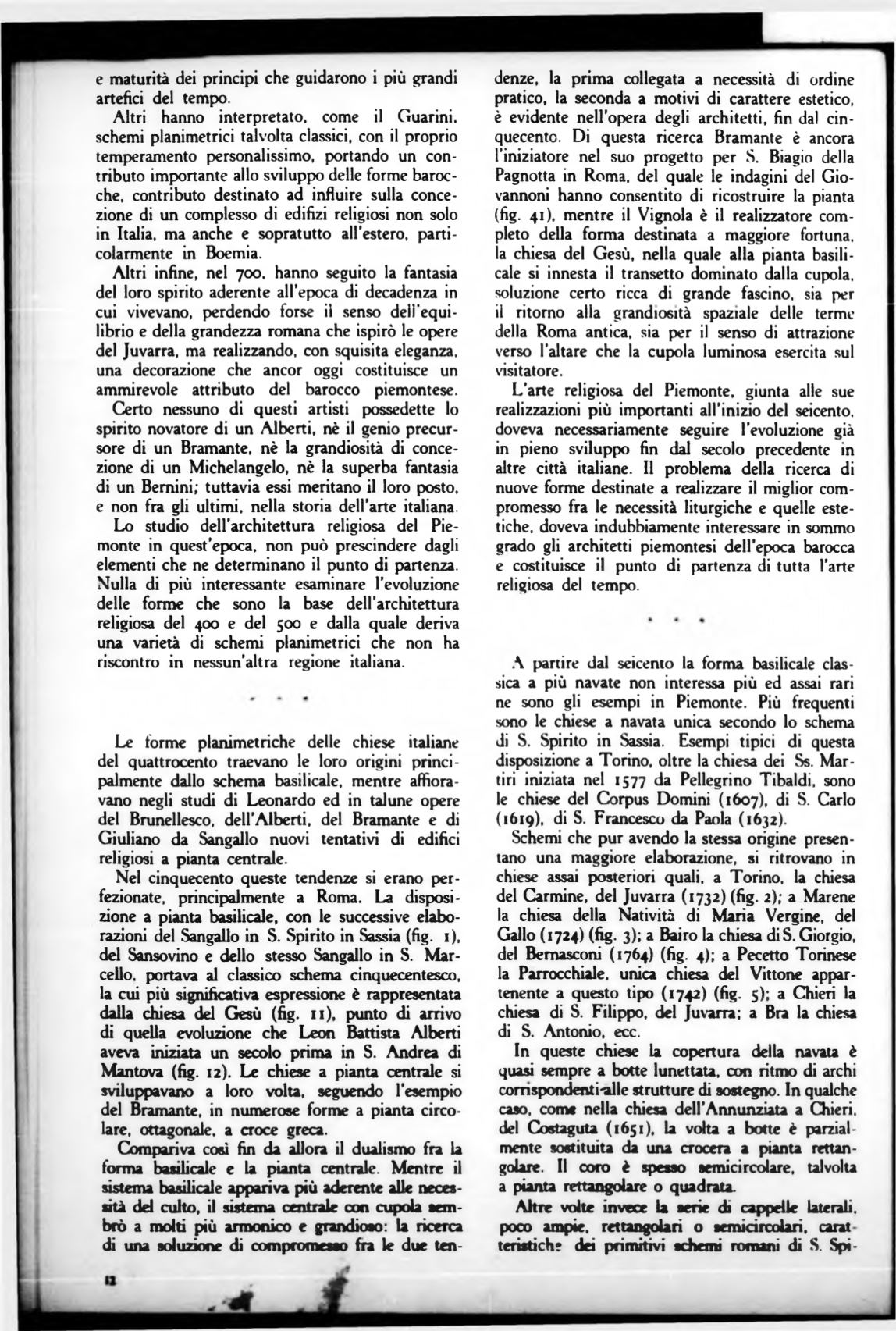
e maturità dei principi che guidarono i più grandi
artefici del tempo.
Altri hanno interpretato, come il Guarini.
schemi pianimetrici talvolta classici, con il proprio
temperamento personalissimo, portando un con
tributo importante allo sviluppo delle forme baroc
che, contributo destinato ad influire sulla conce
zione di un complesso di edifizi religiosi non solo
in Italia, ma anche e sopratutto all’estero, parti
colarmente in Boemia.
Altri infine, nel 700, hanno seguito la fantasia
del loro spirito aderente all’epoca di decadenza in
cui vivevano, perdendo forse il senso deii’equi-
librio e della grandezza romana che ispirò le opere
del Juvarra, ma realizzando, con squisita eleganza,
una decorazione che ancor oggi costituisce un
ammirevole attributo del barocco piemontese.
Certo nessuno di questi artisti possedette lo
spirito novatore di un Alberti, nè il genio precur
sore di un Bramante, nè la grandiosità di conce
zione di un Michelangelo, nè la superba fantasia
di un Bernini; tuttavia essi meritano il loro posto,
e non fra gli ultimi, nella storia dell’arte italiana.
Lo studio dell’architettura religiosa del Pie
monte in quest’epoca, non può prescindere dagli
elementi che ne determinano il punto di partenza.
Nulla di più interessante esaminare l’evoluzione
delle forme che sono la base dell’architettura
religiosa del 400 e del 500 e dalla quale deriva
una varietà di schemi pianimetrici che non ha
riscontro in nessun’altra regione italiana.
Le forme pianimetriche delle chiese italiane
del quattrocento traevano le loro origini princi
palmente dallo schema basilicale, mentre affiora
vano negli studi di Leonardo ed in talune opere
del Brunellesco, dell’Alberti, del Bramante e di
Giuliano da Sangallo nuovi tentativi di edifici
religiosi a pianta centrale.
Nel cinquecento queste tendenze si erano per
fezionate, principalmente a Roma. La disposi
zione a pianta basilicale, con le successive elabo
razioni del Sangallo in S. Spirito in Sassia (fig. 1 ),
del Sansovino e dello stesso Sangallo in S. Mar
cello. portava al classico schema cinquecentesco,
la cui più significativa espressione è rappresentata
dalla chiesa del Gesù (fig. 11), punto di arrivo
di quella evoluzione che Leon Battista Alberti
aveva iniziata un secolo prima in S. Andrea di
Mantova (fig. 12). Le chiese a pianta centrale si
sviluppavano a loro volta, seguendo l’esempio
del Bramante, in numerose forme a pianta circo
lare, ottagonale, a croce greca.
Compariva cosi fin da allora il dualismo fra la
forma basilicale e la pianta centrale. Mentre il
sistema basilicale appariva più aderente alle neces
sità del culto, il sistema centrale con cupola sem
brò a molti più armonico e grandioso: la ricerca
di una soluzione di compromesso fra le due ten
denze, la prima collegata a necessità di ordine
pratico, la seconda a motivi di carattere estetico,
è evidente nell’opera degli architetti, fin dal cin
quecento. Di questa ricerca Bramante è ancora
l’iniziatore nel suo progetto per S. Biagio della
Pagnotta in Roma, del quale le indagini del Gio-
vannoni hanno consentito di ricostruire la pianta
(fig. 41), mentre il Vignola è il realizzatore com
pleto della forma destinata a maggiore fortuna,
la chiesa del Gesù, nella quale alla pianta basili
cale si innesta il transetto dominato dalla cupola,
soluzione certo ricca di grande fascino, sia per
il ritorno alla grandiosità spaziale delle terme
della Roma antica, sia per il senso di attrazione
verso l’altare che la cupola luminosa esercita sul
visitatore.
L ’arte religiosa del Piemonte, giunta alle sue
realizzazioni più importanti all’inizio del seicento,
doveva necessariamente seguire l’evoluzione già
in pieno sviluppo fin dal secolo precedente in
altre città italiane. Il problema della ricerca di
nuove forme destinate a realizzare il miglior com
promesso fra le necessità liturgiche e quelle este
tiche. doveva indubbiamente interessare in sommo
grado gli architetti piemontesi dell’epoca barocca
e costituisce il punto di partenza di tutta l’arte
religiosa del tempo.
A partire dal seicento la forma basilicale clas
sica a più navate non interessa più ed assai rari
ne sono gli esempi in Piemonte. Più frequenti
sono le chiese a navata unica secondo lo schema
di S. Spirito in Sassia. Esempi tipici di questa
disposizione a Torino, oltre la chiesa dei Ss. Mar
tiri iniziata nel 1577 da Pellegrino Tibaldi, sono
le chiese del Corpus Domini (1607), di S. Carlo
(1619), di S. Francesco da Paola (1632).
Schemi che pur avendo la stessa origine presen
tano una maggiore elaborazione, si ritrovano in
chiese assai posteriori quali, a Torino, la chiesa
del Carmine, del Juvarra (1732) (fig. 2); a Marene
la chiesa della Natività di Maria Vergine, del
Gallo (1724) (fig. 3); a Bairo la chiesa diS. Giorgio,
del Bernasconi (1764) (fig. 4); a Pecetto Torinese
la Parrocchiale, unica chiesa del Vittone appar
tenente a questo tip» (1742) (fig. 5); a Chieri la
chiesa di S. Filippo, del Juvarra; a Bra la chiesa
di S. Antonio, ecc.
In queste chiese la copertura della navata è
quasi sempre a botte lunettata, con ritmo di archi
cornspondenti-alle strutture di sostegno. In qualche
caso, come nella chiesa deU’Annunziata a Chieri.
del Costaguta (1651), la volta a botte è parzial
mente sostituita da una crocerà a pianta rettan
golare. Il coro è spesso semicircolare, talvolta
a p>ianta rettangolare o quadrata.
Altre volte invece la serie di cappelle laterali,
poco ampie, rettangolari o semicircolari, carat
teristich? dei primitivi schemi romani di S. Spi-


















