
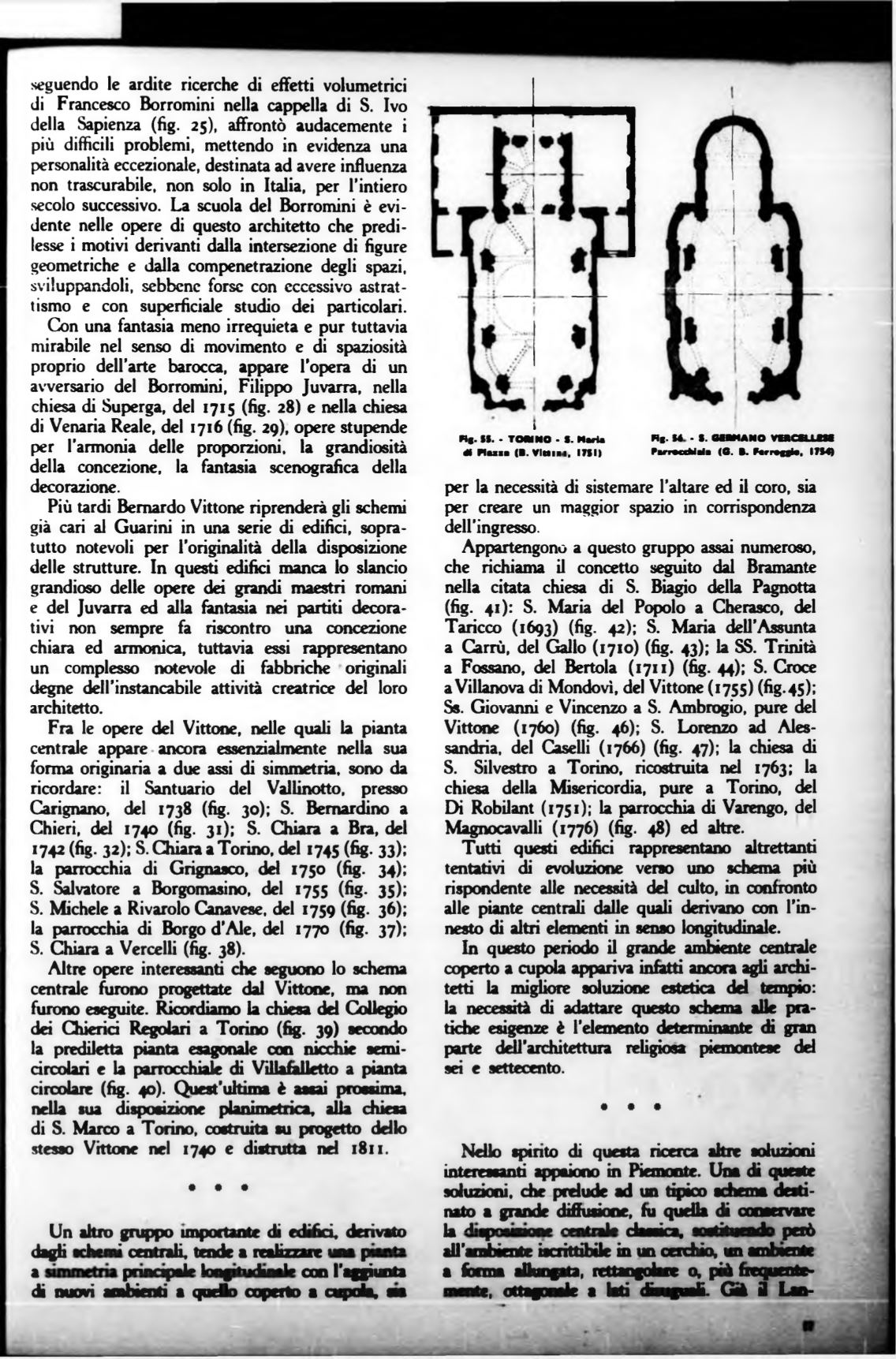
seguendo le ardite ricerche di effetti volumetrici
di Francesco Borromini nella cappella di S. Ivo
della Sapienza (fig. 25), affrontò audacemente i
più difficili problemi, mettendo in evidenza una
personalità eccezionale, destinata ad avere influenza
non trascurabile, non solo in Italia, per l’intiero
secolo successivo. La scuola del Borromini è evi
dente nelle opere di questo architetto che predi
lesse i motivi derivanti dalla intersezione di figure
geometriche e dalla compenetrazione degli spazi,
sviluppandoli, sebbene forse con eccessivo astrat
tismo e con superficiale studio dei particolari.
Con una fantasia meno irrequieta e pur tuttavia
mirabile nel senso di movimento e di spaziosità
proprio dell’arte barocca, appare l’opera di un
avversario del Borromini, Filippo Juvarra, nella
chiesa di Superga, del 17 15 (fig. 28) e nella chiesa
di Venaria Reale, del 17 16 (fig. 29), opere stupende
per l’armonia delle proporzioni. la grandiosità
della concezione, la fantasia scenografica della
decorazione.
Più tardi Bernardo Vittone riprenderà gli schemi
già cari al Guarini in una serie di edifìci, sopra
tutto notevoli per l’originalità della disposizione
delle strutture. In questi edifici manca lo slancio
grandioso delle opere dei grandi maestri romani
e del Juvarra ed alla fantasia nei partiti decora
tivi non sempre fa riscontro una concezione
chiara ed armonica, tuttavia essi rappresentano
un complesso notevole di fabbriche originali
degne dell’instancabile attività creatrice del loro
architetto.
Fra le opere del Vittone, nelle quali la pianta
centrale appare ancora essenzialmente nella sua
forma originaria a due assi di simmetria, sono da
ricordare: il Santuario del Vallinotto, presso
Carignano, del 1738 (fig. 30); S. Bernardino a
Chieri, del 1740 (fig. 3 1) ; S. Chiara a Bra, del
1742 (fig. 32); S. Chiara a Torino, del 1745 (fig. 33);
la parrocchia di Grignasco, del 1750 (fig. 34);
S. Salvatore a Borgomasino, del 1755 (fig. 35);
S. Michele a Rivarolo Canavese, del 1759 (fig. 36);
la parrocchia di Borgo d’Ale, del 1770 (fig. 37);
S. Chiara a Vercelli (fig. 38).
Altre opere interessanti che seguono lo schema
centrale furono progettate dal Vittone, ma non
furono eseguite. Ricordiamo la chiesa del Collegio
dei Chierici Regolari a Torino (fig. 39) secondo
la prediletta pianta esagonale con nicchie semi-
circolari e la parrocchiale di Villafalletto a pianta
circolare (fig. 40). Quest’ultima è assai prossima,
nella sua disposizione planimetrica, alla chiesa
di S. Marco a Torino, costruita su progetto dello
stesso Vittone nel 1740 e distrutta nel 18 1 1 .
• • •
Un
altro gruppo
importante
di
edifici, derivato
dagli
f
K#mi
centrali, tende
a
realizzare >|Mp******
a
pfinfipal> Itnigitutliiillt con l’aggiunta
di nuovi ambienti a quello coperto a cupola* sia
1
Mg. II. •TORINO. ». Maria
««•H - $•GERMANOVKRCSLLMS
ék
Massa (R. Vitti»i. IMI)
ParraccWala (C. I. Mrfggta. ITM)
per la necessità di sistemare l’altare ed il coro, sia
per creare un maggior spazio in corrispondenza
dell’ingresso.
Appartengono a questo gruppo assai numeroso,
che richiama il concetto seguito dal Bramante
nella citata chiesa di S. Biagio della Pagnotta
(fig. 41): S. Maria del Popolo a Cherasco, del
Taricco (1693) (fig. 42); S. Maria dell’Assunta
a Carrù, del Gallo (1710) (fig. 43); la SS. Trinità
a Fossano, del Bertola ( 1 7 1 1 ) (fig. 44); S. Croce
aVillanova di Mondovì, del Vittone (1755) (fig.45);
Ss. Giovanni e Vincenzo a S. Ambrogio, pure del
Vittone (1760) (fig. 46); S. Lorenzo ad Ales
sandria, del Caselli (1766) (fig. 47); la chiesa di
S. Silvestro a Torino, ricostruita nel 1763; la
chiesa della Misericordia, pure a Torino, del
Di Robilant (1751); la parrocchia di Varengo, del
Magnocavalli (1776) (fig. 48) ed altre.
Tutti questi edifìci rappresentano altrettanti
tentativi di evoluzione verso uno schema più
rispondente alle necessità del culto, in confronto
alle piante centrali dalle quali derivano con l’in
nesto di altri elementi in senso longitudinale.
In questo periodo il grande ambiente centrale
coperto a cupola appariva infatti ancora agli archi
tetti la migliore soluzione estetica del tempio:
la necessità di adattare questo schema alle pra
tiche esigenze è l’elemento determinante di gran
parte dell’architettura religiosa piemontese del
sei e settecento.
• • •
Nello
spinto di questa ricerca altre soluzioni
interessanti appaiono in Piemonte.
Una
di
queste
soluzioni, che prelude ad un
tipico schema desti
nato a grande diffusione, fu
quella
di
conservare
la ^»Tp««»nnn» finirai» clanica, RnaÉÌHfpMA* pCIÒ
all’ambiente isaittibile
in un
cerchio, un «nhiCHfcr
a ferma allungala, rrttangohre o, più frequente»
■MiÉf, ottagonale a bd disuguali. Già 3 Lan-


















