
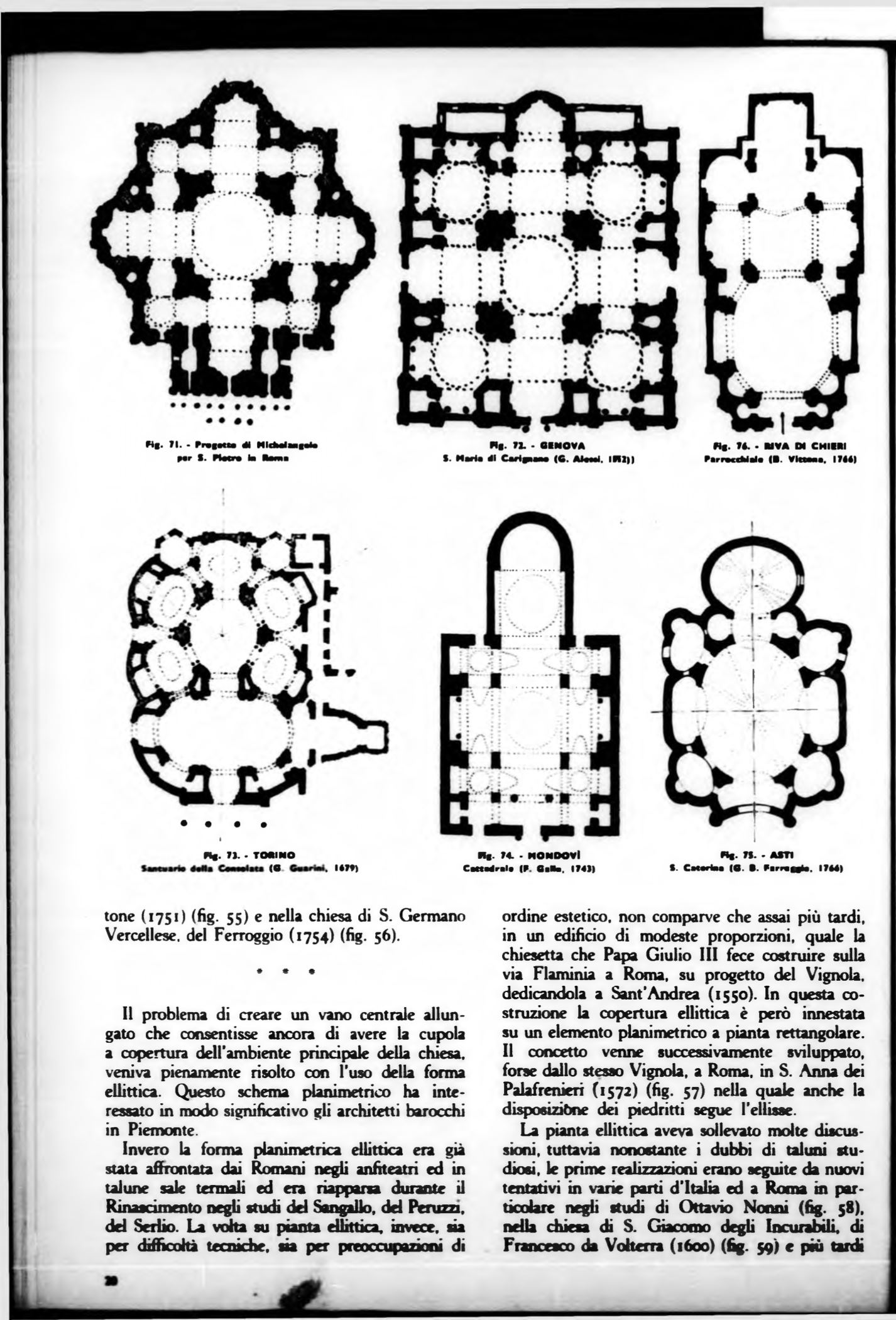
Fig . I I . . Pro g etto
di
M icfcalaagata
pmr
S . PI » o » la Rom a
M g. 72. • C C N O V A
S. M a ria di C a rig a a a * (6 . A M . IM I))
M g. f i - R IV A M C H IfR I
P a rro ccM ala <B. V ltta a a . 1744)
• • • •
I
M g. 71. • T O R IN O
(C
i, 147»)
M g. 74. - H O N O O V l
C a tta d ra l* (F C a lla . 174»)
M g. 7*. . A S T I
t . C a ta ria a (C . B . b arra g gia . 1744)
tone ( 1 7 5 1 ) (fig. 55) e nella chiesa di
S.
Germano
Vercellese, del Ferroggio (1754) (fig. 56).
# t t
Il problema di creare un vano centrale allun
gato che consentisse ancora di avere la cupola
a copertura dell’ambiente principale della chiesa,
veniva pienamente risolto con l’uso della forma
ellittica. Questo schema planimetrico ha inte
ressato in modo significativo gli architetti barocchi
in Piemonte.
Invero la forma pianimetrica ellittica era già
stata affrontata dai Romani negli anfiteatri ed in
talune sale termali ed era riapparsa durante il
Rinascimento negli studi del Sangallo, del Peruzzi,
del Serlio. La volta su pianta ellittica, invece, sia
per difficoltà tecniche, sia per preoccupazioni di
ordine estetico, non comparve che assai più tardi,
in un edificio di modeste proporzioni, quale la
chiesetta che Papa Giulio III fece costruire sulla
via Flaminia a Roma, su progetto del Vignola.
dedicandola a Sant’Andrea (1550). In questa co
struzione la copertura ellittica è però innestata
su un elemento pianimetrico a pianta rettangolare.
Il concetto venne successivamente sviluppato,
forse dallo stesso Vignola, a Roma, in S. Anna dei
Palafrenieri (1572) (fig. 57) nella quale anche la
disposizióne dei piedritti segue l’ellisse.
La pianta ellittica aveva sollevato molte discus
sioni, tuttavia nonostante i dubbi di taluni stu
diosi, le prime realizzazioni erano seguite da nuovi
tentativi in varie parti d’Italia ed a Roma in par
ticolare negli studi di Ottavio Nonni (fig. 58),
nella chiesa di S. Giacomo degli Incurabili, di
Francesco da Volterra (1600)
(fig.
59) e più tardi


















