
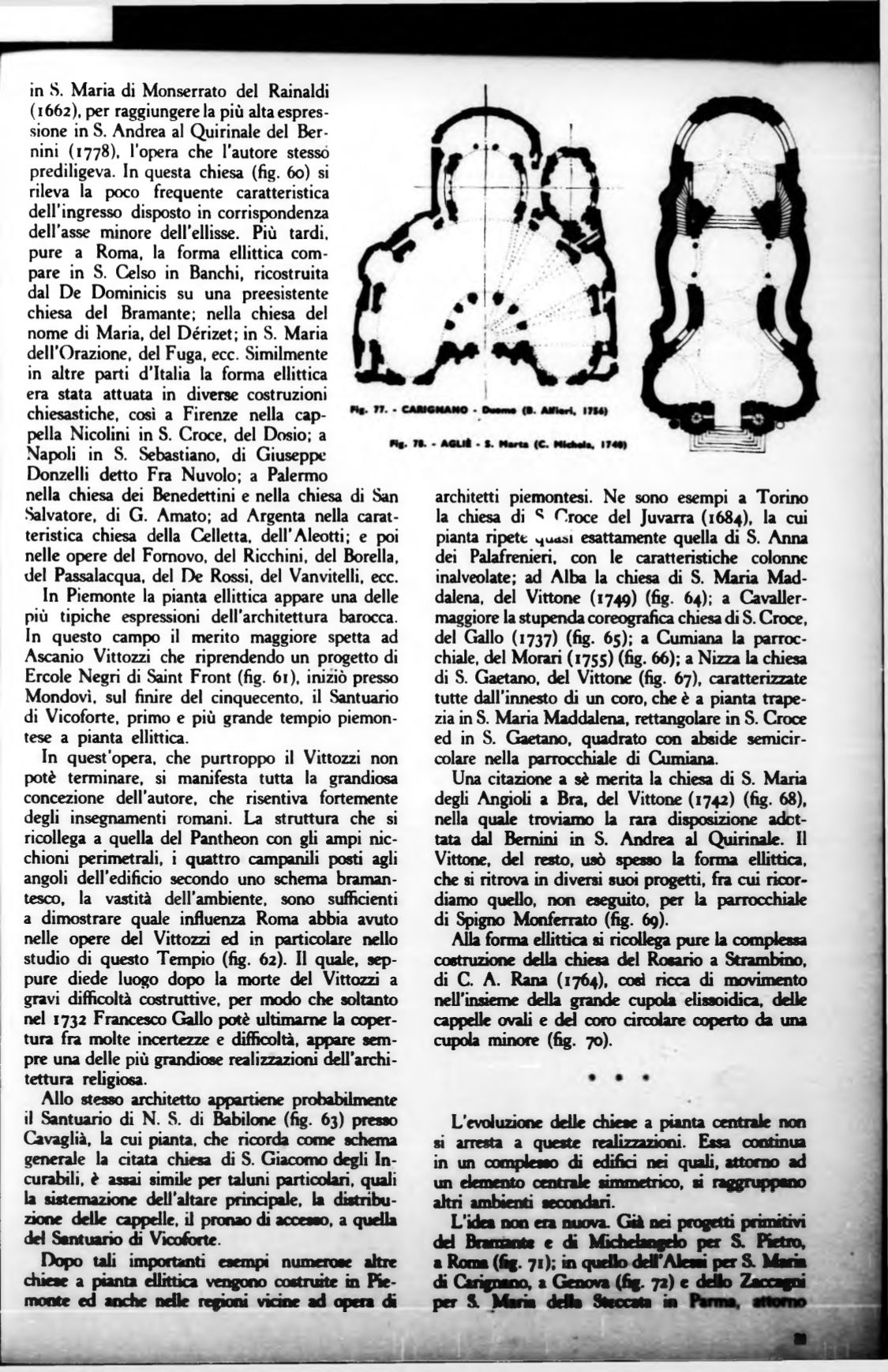
in S. Maria di Monserrato del Rainaldi
(1662), per raggiungere la più alta espres
sione in S. Andrea al Quirinale del Ber
nini (1778), l’opera che l’autore stesso
prediligeva. In questa chiesa (fig. 60) si
rileva la poco frequente caratteristica
dell’ ingresso disposto in corrispondenza
dell’asse minore dell’ellisse. Più tardi,
pure a Roma, la forma ellittica com
pare in S. Celso in Banchi, ricostruita
dal De Dominicis su una preesistente
chiesa del Bramante; nella chiesa del
nome di Maria, del Dérizet; in S. Maria
dell’Orazione, del Fuga, ecc. Similmente
in altre parti d’Italia la forma ellittica
era stata attuata in diverse costruzioni
chiesastiche, così a Firenze nella cap
pella Nicolini in S. Croce, del Dosio; a
Napoli in S. Sebastiano, di Giuseppe
Donzelli detto Fra Nuvolo; a Palermo
nella chiesa dei Benedettini e nella chiesa di San
Salvatore, di G. Amato; ad Argenta nella carat
teristica chiesa della Celletta, dell’ Aleotti; e poi
nelle opere del Fomovo, del Ricchini, del Borella,
del Passalacqua, del De Rossi, del Vanvitelli, ecc.
In Piemonte la pianta ellittica appare una delle
più tipiche espressioni dell’architettura barocca.
In questo campo il merito maggiore spetta ad
Ascanio Vittozzi che riprendendo un progetto di
Ercole Negri di Saint Front (fig. 61), iniziò presso
Mondovì, sul finire del cinquecento, il Santuario
di Vicoforte, primo e più grande tempio piemon
tese a pianta ellittica.
In quest’opera, che purtroppo il Vittozzi non
potè terminare, si manifesta tutta la grandiosa
concezione dell’autore, che risentiva fortemente
degli insegnamenti romani. La struttura che si
ricollega a quella del Pantheon con gli ampi nic-
chioni perimetrali, i quattro campanili posti agli
angoli dell’edificio secondo uno schema braman
tesco, la vastità dell’ambiente, sono sufficienti
a dimostrare quale influenza Roma abbia avuto
nelle opere del Vittozzi ed in particolare nello
studio di questo Tempio (fig. 62). Il quale, sep
pure diede luogo dopo la morte del Vittozzi a
gravi difficoltà costruttive, per modo che soltanto
nel 1732 Francesco Gallo potè ultimarne la coper
tura fra molte incertezze e difficoltà, appare sem
pre una delle più grandiose realizzazioni dell'archi
tettura religiosa.
Allo stesso architetto appartiene probabilmente
il Santuario di N. S. di Babilone (fig. 63) presso
Cavaglià, la cui pianta, che ricorda come schema
generale la citata chiesa di S. Giacomo degli In
curabili, è assai simile per taluni particolari, quali
la sistemazione dell’altare principale, la distribu
zione delle cappelle, il pronao di accesso, a quella
del Santuario di Vicoforte.
Dopo tali importanti esempi numerose altre
chiese a pianta ellittica vengono costruite in Pie
monte ed anche nelle regioni vicine ad open di
architetti piemontesi. Ne sono esempi a Torino
la chiesa di ^ Croce del Juvarra (1684), la cui
pianta ripete 4 u«u>i esattamente quella di S. Anna
dei Palafrenieri, con le caratteristiche colonne
inalveolate; ad Alba la chiesa di S. Maria Mad
dalena, del Vittone (1749) (fig. 64); a Cavaller-
maggiore la stupenda coreografica chiesa di S. Croce,
del Gallo (1737) (fig. 65); a Cumiana la parroc
chiale, del Morali (1755) (fig. 66); a Nizza la chiesa
di S. Gaetano, del Vittone (fig. 67), caratterizzate
tutte dall’innesto di un coro, che è a pianta trape-
zia in S. Maria Maddalena, rettangolare in S. Croce
ed in S. Gaetano, quadrato con abside semicir
colare nella parrocchiale di Cumiana.
Una citazione a sé merita la chiesa di S. Maria
degli Angioli a Bra, del Vittone (1742) (fig. 68),
nella quale troviamo la rara disposizione adet
tata dal Bernini in S. Andrea sii Quirinale. Il
Vittone, del resto, usò spesso la forma ellittica,
che si ritrova in diversi suoi progetti, fra cui ricor
diamo quello, non eseguito, per la parrocchiale
di Spigno Monferrato (fig. 69).
Alla forma ellittica si ricollega pure la complessa
costruzione della chiesa del Rosario a Strambino,
di C. A . Rana (1764), così ricca di movimento
nell’insieme della grande cupola elissoidica, delle
cappelle ovali e del coro circolare coperto da una
cupola minore (fig. 70).
L’evoluzione delle chiese a pianta centrale non
si arresta a queste realizzazioni. Essa continua
in un complesso di edifìci nei quali, attorno ad
un elemento centrale simmetrico, si raggruppano
altri ambienti secondari.
L'idea non era nuova. Già nei progetti primitivi
dei Bramante e di Michelangelo per S. Pietro,
a Roma (fig.
71
); in quello defl'Aleasi per S. Maria
di Carignano, a Genova (fig.
72
) e dello Zanragpi
per Se Maria ddh Stacciti in
»
JS.


















