
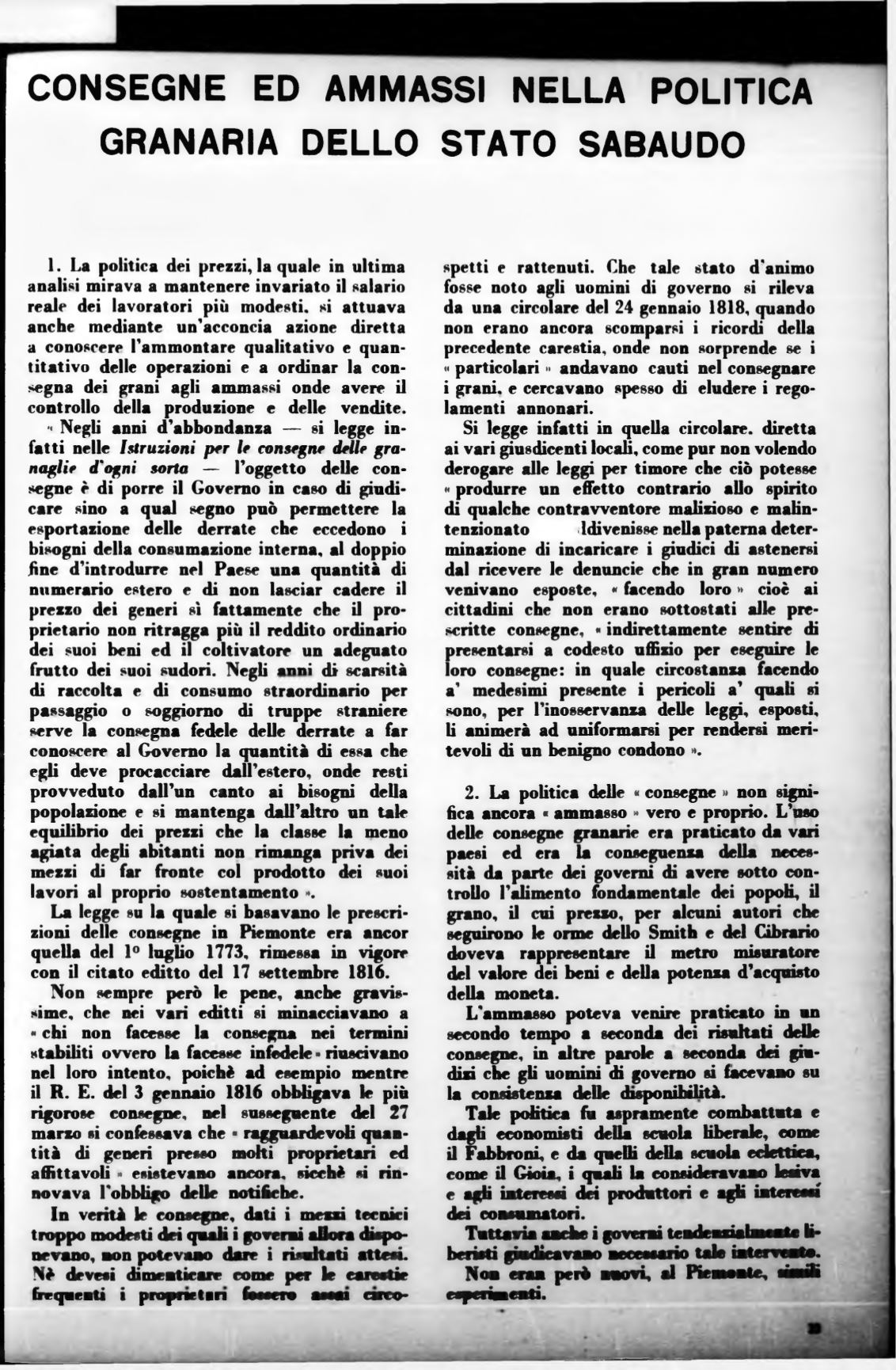
CONSEGNE ED AMMASSI NELLA POLITICA
GRANARIA DELLO STATO SABAUDO
1.
La politica dei prezzi, la quale in ultima
analisi mirava a mantenere invariato il salario
reale dei lavoratori più modesti, si attuava
anche mediante un'acconcia azione diretta
a conoscere l'ammontare qualitativo e quan
titativo delle operazioni e a ordinar la con
segna dei grani agli ammassi onde avere il
controllo della produzione e delle vendite.
•«Negli anni d'abbondanza — si legge in
fatti nelle
Istruzioni
per
le consegne delle gra
naglie d'ogni sorta
— l'oggetto delle con
segne è di porre il Governo in caso di giudi
care sino a qual segno può permettere la
esportazione delle derrate che eccedono i
bisogni della consumazione interna, al doppio
line d'introdurre nel Paese una quantità di
numerario estero e di non lasciar cadere il
prezzo dei generi sì fattamente che il pro
prietario non ritragga più il reddito ordinario
dei suoi beni ed il coltivatore un adeguato
frutto dei suoi sudori. Negli anni di scarsità
di raccolta e di consumo straordinario per
passaggio o soggiorno di truppe straniere
serve la consegna fedele delle derrate a far
conoscere al Governo la quantità di essa che
egli deve procacciare dall'estero, onde resti
provveduto dall'un canto ai bisogni della
popolazione e si mantenga dall'altro un tale
equilibrio dei prezzi che la classe la meno
agiata degli abitanti non rimanga priva dei
mezzi di far fronte col prodotto dei suoi
lavori al proprio sostentamento ».
La legge su la quale si basavano le prescri
zioni delle consegne in Piemonte era ancor
quella del 1° luglio 1773, rimessa in vigore
con il citato editto del 17 settembre 1816.
Non sempre però le pene, anche gravis
sime, che nei vari editti si minacciavano a
•chi non facesse la consegna nei termini
stabiliti ovvero la facesse infedele » riuscivano
nel loro intento, poiché ad esempio mentre
il R. E. del 3 gennaio 1816 obbligava le più
rigorose consegne, nel susseguente del 27
marzo si confessava che - ragguardevoli quan
tità di generi presso molti proprietari ed
aflìttavoli - esistevano ancora, sicché si rin
novava l'obbligo delle notifiche.
In verità le consegne, dati i messi tecnici
troppo modesti dei quali i governi allora dispo
nevano, non potevano dare i risultati attesi.
Nf devesi dimenticare come per le carestie
frequenti i propnffan fossero assai eneo*
spetti e rattenuti. Che tale stato d'animo
fosse noto agli uomini di governo si rileva
da una circolare del 24 gennaio 1818, quando
non erano ancora scomparsi i ricordi della
precedente carestia, onde non sorprende se i
« particolari » andavano cauti nel consegnare
i grani, e cercavano spesso di eludere i rego
lamenti annonari.
Si legge infatti in quella circolare, diretta
ai vari giusdicenti locali, come pur non volendo
derogare alle leggi per timore che ciò potesse
« produrre un effetto contrario allo spirito
di qualche contravventore malizioso e malin
tenzionato
ridivenisse nella paterna deter
minazione di incaricare i giudici di astenersi
dal ricevere le denuncie che in gran numero
venivano esposte, « facendo loro » cioè ai
cittadini che non erano sottostati alle pre
scritte consegne, « indirettamente sentire di
presentarsi a codesto uffizio per eseguire le
loro consegne: in quale circostanza facendo
a' medesimi presente i pericoli a' quali si
sono, per l'inosservanza delle leggi, esposti,
li animerà ad uniformarsi per rendersi meri
tevoli di un benigno condono ».
2.
La politica delle « consegne » non signi
fica ancora « ammasso » vero e proprio. L'uso
delle consegne granarie era praticato da vari
paesi ed era la conseguenza della neces
sità da parte dei governi di avere sotto con
trollo l'alimento fondamentale dei popoli, il
grano, il cui presso, per alcuni autori che
seguirono le orme dello Smith e del Cibrario
doveva rappresentare il metro misuratore
del valore dei beni e della potenza d'acquisto
della moneta.
L'ammasso poteva venire praticato in un
secondo tempo a seconda dei risultati delle
consegne, in altre parole a seconda dei giu
dizi che gli uomini di governo si facevano su
la consistenza delle disponibilità.
Tale politica fu aspramente combattuta e
dagli economisti della scuola liberale, come
il Fabbroni, e da quelli della scuola eclettica,
come il Gioia, i quali la consideravano lesiva
e agli interessi dei produttori e agli interessi
dei consumatori.
Tuttavia anche i governi tendenzialmente li
beristi giudicavano necessario tale intervento.
Non eran peri nuovi, al Piemonte, rimili
esperimenti.


















