
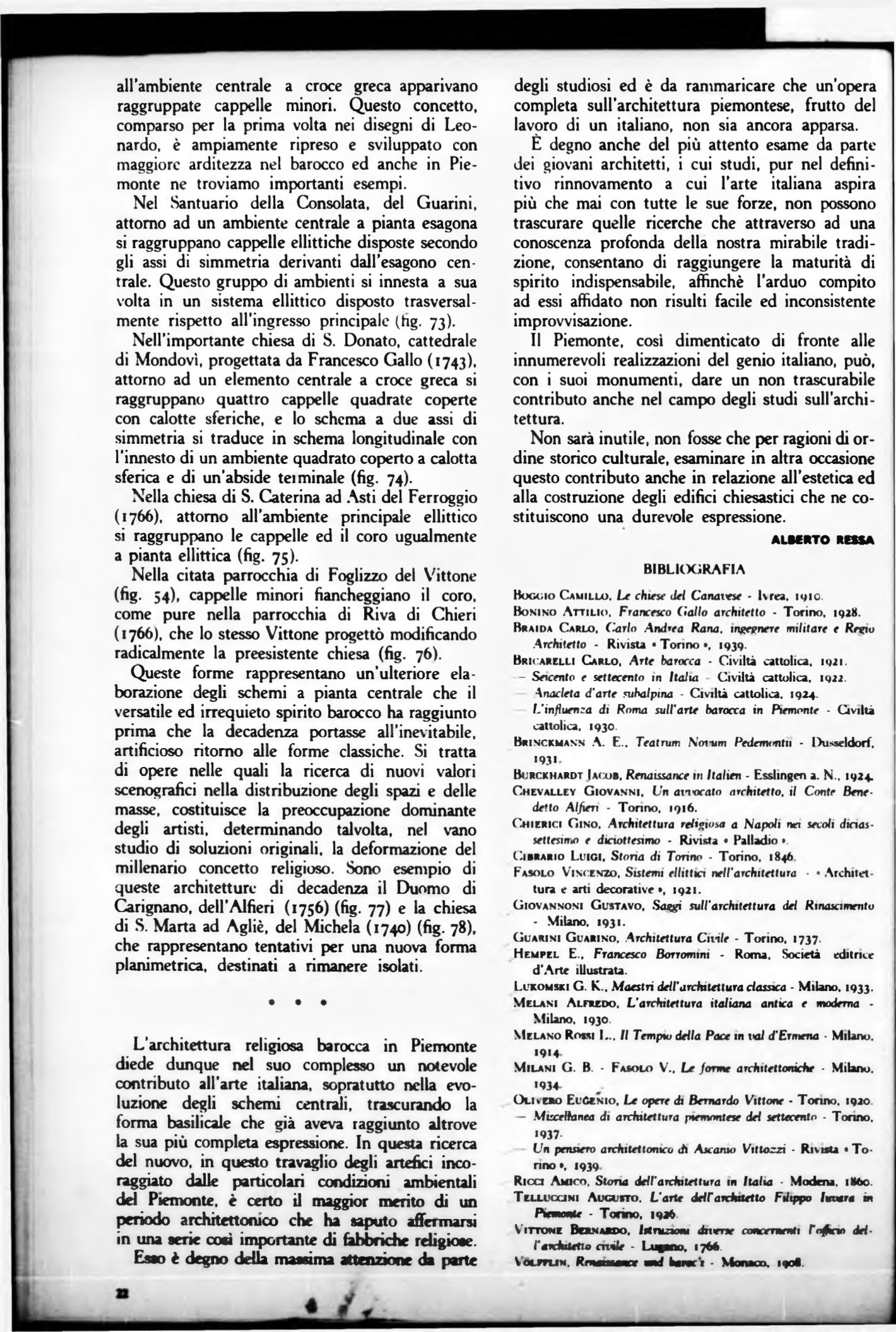
all’ambiente centrale a croce greca apparivano
raggruppate cappelle minori. Questo concetto,
comparso per la prima volta nei disegni di Leo
nardo, è ampiamente ripreso e sviluppato con
maggiore arditezza nel barocco ed anche in Pie
monte ne troviamo importanti esempi.
Nel Santuario della Consolata, del Guarini,
attorno ad un ambiente centrale a pianta esagona
si raggruppano cappelle ellittiche disposte secondo
gli assi di simmetria derivanti dall’esagono cen
trale. Questo gruppo di ambienti si innesta a sua
volta in un sistema ellittico disposto trasversal
mente rispetto all’ingresso principale (hg. 73).
Nell’importante chiesa di S. Donato, cattedrale
di Mondovì, progettata da Francesco Gallo (1743),
attorno ad un elemento centrale a croce greca si
raggruppano quattro cappelle quadrate coperte
con calotte sferiche, e lo schema a due assi di
simmetria si traduce in schema longitudinale con
l’innesto di un ambiente quadrato coperto a calotta
sferica e di un’abside tei minale (fig. 74).
Nella chiesa di S. Caterina ad Asti del Ferroggio
(1766), attorno all’ambiente principale ellittico
si raggruppano le cappelle ed il coro ugualmente
a pianta ellittica (fig. 75).
Nella citata parrocchia di Foglizzo del Vittone
(fig. 54), cappelle minori fiancheggiano il coro,
come pure nella parrocchia di Riva di Chieri
(1766), che lo stesso Vittone progettò modificando
radicalmente la preesistente chiesa (fig. 76).
Queste forme rappresentano un’ulteriore ela
borazione degli schemi a pianta centrale che il
versatile ed irrequieto spirito barocco ha raggiunto
prima che la decadenza portasse all’inevitabile,
artificioso ritorno alle forme classiche. Si tratta
di opere nelle quali la ricerca di nuovi valori
scenografici nella distribuzione degli spazi e delle
masse, costituisce la preoccupazione dominante
degli artisti, determinando talvolta, nel vano
studio di soluzioni originali, la deformazione del
millenario concetto religioso. Sono esempio di
queste architetture di decadenza il Duomo di
Carignano, dell’Alfieri (1756) (fig. 77) e la chiesa
di S. Marta ad Agliè, del Michela (1740) (fig. 78),
che rappresentano tentativi per una nuova forma
pianimetrica, destinati a rimanere isolati.
* * *
L’architettura religiosa barocca in Piemonte
diede dunque nel suo complesso un notevole
contributo all’arte italiana, sopratutto nella evo
luzione degli schemi centrali, trascurando la
forma basilicale che già aveva raggiunto altrove
la sua più completa espressione. In questa ricerca
del nuovo, in questo travaglio degli artefici inco
raggiato dalle particolari condizioni ambientali
del Piemonte, è certo il maggior merito di un
periodo architettonico che ha saputo affermarsi
in una serie cosi importante di fabbriche religiose.
Esso è degno della massima attenzione da parte
degli studiosi ed è da rammaricare che un’opera
completa sull’architettura piemontese, frutto del
lavoro di un italiano, non sia ancora apparsa.
È degno anche del più attento esame da parte
dei giovani architetti, i cui studi, pur nel defini
tivo rinnovamento a cui l’arte italiana aspira
più che mai con tutte le sue forze, non possono
trascurare quelle ricerche che attraverso ad una
conoscenza profonda della nostra mirabile tradi
zione, consentano di raggiungere la maturità di
spirito indispensabile, affinchè l’arduo compito
ad essi affidato non risulti facile ed inconsistente
improvvisazione.
Il Piemonte, così dimenticato di fronte alle
innumerevoli realizzazioni del genio italiano, può,
con i suoi monumenti, dare un non trascurabile
contributo anche nel campo degli studi sull’archi
tettura.
Non sarà inutile, non fosse che per ragioni di or
dine storico culturale, esaminare in altra occasione
questo contributo anche in relazione all’estetica ed
alla costruzione degli edifìci chiesastici che ne co
stituiscono una durevole espressione.
ALBERTO RESSA
B IB L IO G R A F IA
B o c c io C am illo .
Le chiese del Canaiese -
Ivrea.
1 9 1 0
.
B on in o A t t i l i o .
Francesco dallo architetto
-
T orino,
19 2 8
.
Braida C a r lo ,
Carlo Andrea Rana, ingegnere militare e Regio
Architetto -
Rivista
•
T o n n o
♦,
1 9 3 9
.
B r ic a r e lli C a r lo ,
Arte barocca
- C iviltà cattolica, 1921.
- Sferrilo
e settecento
in
Italia
Civiltà cattolica, 1922.
Anacleta d'arte subalpina -
C iviltà cattolica,
1 9 2 4
.
L’influenza di Roma sull’arte barocca in Piemonte
- Civiltà
cattolica,
1 9 3 0
.
Brinckmann A . E..
Teatrum
Novwn
Pedemimtu -
Dusseldorf.
1931
Bu rckhard t
Iaoob,
Renaissance ni Italien
- Esslingen
a.
N ., 1924.
C h e v a lle y G iov an n i,
Un anvento architetto, il Conte Bene
detto Alfieri -
Tonno ,
1 9 1 6
.
C h ie r ic i G in o ,
Architettura religiosa a Napoli
nei
secoli dicias
settesimo e diciottesimo -
Rivista
«
Palladio
*.
C j
e ra rio Luigi,
Storia
di Torino
-
Torino, 1846
F a s o lo V in cenzo,
Sistemi ellittici nell'architettura ■ •
Architet
tura e arti decorative », 19 2 1.
G iovann on i G u sta vo, So^gi
sull'architettura del Rinascimento
- Milano.
1 9 3 1
.
G u a rin i Gua rin o,
Architettura Citile
-
Torino,
1 7 3 7
.
Hempel E.,
Francesco Borromini -
Roma, Società editrice
d ’Arte illustrata.
Lukomski G . K., Maestri
dell’architettura classica
-
Milano,
1 9 3 3
.
M e la s i A lfr e d o ,
L’architettura italiana antica e moderna -
Milano.
1 9 3 0
.
M e la n o Rossi
L ..
Il Tempio della Pace
in t
<al d'Ermena -
Milano.
1 9 1 4
M ila n i
G . B.
- F a s o lo
V..
Le forme architettoniche
- Milano.
t
<)34
O l i* e r o Eugen io,
Le opere di Bernardo Vittone
-
T onn o .
1 9 2 0
.
—
.Miscellanea di architettura piemontese del settecento -
T onn o.
*Q37-
Un pensiero architettonico dì Ascarno Vittozzi -
Rivista
«
T o
nno »,
1 9 3 9
R ic a Am ico, Stono
dell'architettura
in
Italia -
Modena.
18 6 0
.
T ELLUcciNi A ugu sto.
L'arte deirarchitetto Filippo lavara
in
Piemonte
- T orin o,
1 9 2 6
.
V it t o n e B o n o d o ,
Istruzioni diverse concernenti
T
ofjtcw del
l'architetto civile
- L u g a n o . 1 7 6 6
.
V o L n u s ,
Renaissance vnd barac
i
-
M onaco.
190
I.


















