
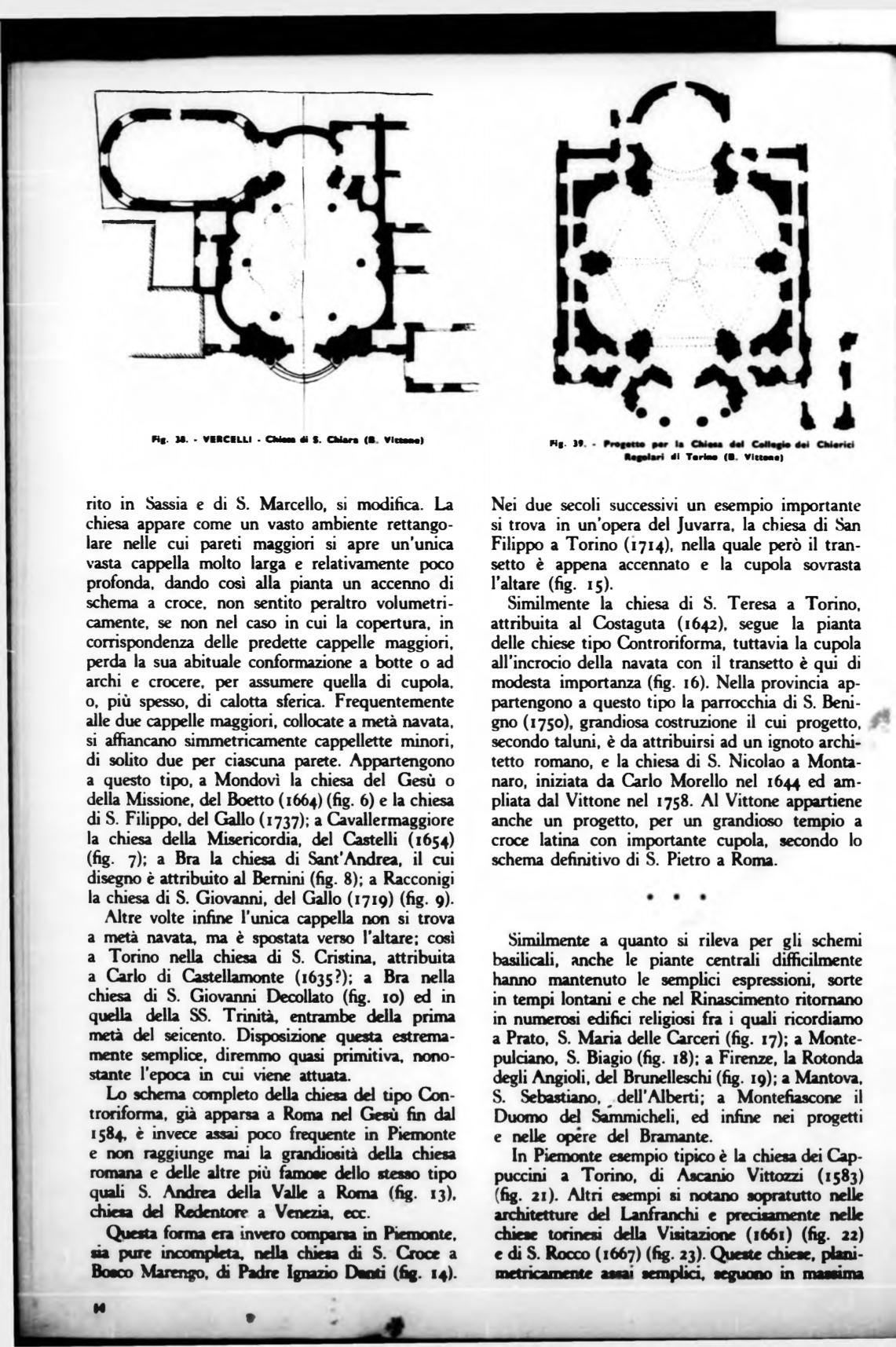
Fig. M. - VERCCLLI ■CMm
éi
*. Chiara (B Vitto»)
Fig. ) f
di Tarino (• Vitto*»»)
rito in Sassia e di S. Marcello, si modifica. La
chiesa appare come un vasto ambiente rettango
lare nelle cui pareti maggiori si apre un’unica
vasta cappella molto larga e relativamente poco
profonda, dando così alla pianta un accenno di
schema a croce, non sentito peraltro volumetri
camente, se non nel caso in cui la copertura, in
corrispondenza delle predette cappelle maggiori,
perda la sua abituale conformazione a botte o ad
archi e crocere, per assumere quella di cupola,
o, più spesso, di calotta sferica. Frequentemente
alle due cappelle maggiori, collocate a metà navata,
si affiancano simmetricamente cappellette minori,
di solito due per ciascuna parete. Appartengono
a questo tipo, a Mondovì la chiesa del Gesù o
della Missione, del Boetto (1664) (fig. 6) e la chiesa
di S. Filippo, del Gallo (1737); a Cavallermaggiore
la chiesa della Misericordia, del Castelli (1654)
(fig. 7); a Bra la chiesa di Sant'Andrea, il cui
disegno è attribuito al Bernini (fig. 8); a Racconigi
la chiesa di S. Giovanni, del Gallo (17 19 ) (fig. 9).
Altre volte infine l’unica cappella non si trova
a metà navata, ma è spostata verso l’altare; così
a Torino nella chiesa di S. Cristina, attribuita
a Carlo di Castellamonte (1635?); a Bra nella
chiesa di S. Giovanni Decollato (fig. 10) ed in
quella della SS. Trinità, entrambe della prima
metà del seicento. Disposizione questa estrema
mente semplice, diremmo quasi primitiva, nono
stante l’epoca in cui viene attuata.
Lo schema completo della chiesa del tipo Con
troriforma, già apparsa a Roma nel Gesù fin dal
1584, è invece assai poco frequente in Piemonte
e non raggiunge mai la grandiosità della chiesa
romana e delle altre più famose dello stesso tipo
quali S. Andrea della Valle a Roma (fig. 13).
chiesa del Redentore a Venezia, ecc.
Questa forma era invero comparsa in Piemonte,
sia pure incompleta, nella chiesa di S. Croce a
Bosco Marengo, di Padre Ignazio Danti (fig. «
4
>-
Nei due secoli successivi un esempio importante
si trova in un’opera del Juvarra, la chiesa di San
Filippo a Torino (1714), nella quale però il tran
setto è appena accennato e la cupola sovrasta
l’altare (fig. 15).
Similmente la chiesa di S. Teresa a Torino,
attribuita al Costaguta (1642), segue la pianta
delle chiese tipo Controriforma, tuttavia la cupola
all’incrocio della navata con il transetto è qui di
modesta importanza (fig. 16). Nella provincia ap
partengono a questo tipo la parrocchia di S. Beni
gno (1750), grandiosa costruzione il cui progetto,
secondo taluni, è da attribuirsi ad un ignoto archi
tetto romano, e la chiesa di S. Nicolao a Monta
naro, iniziata da Carlo Morello nel 1644 ed am
pliata dal Vittone nel 1758. Al Vittone appartiene
anche un progetto, per un grandioso tempio a
croce latina con importante cupola, secondo lo
schema definitivo di S. Pietro a Roma.
Similmente a quanto si rileva per gli schemi
basilicali, anche le piante centrali difficilmente
hanno mantenuto le semplici espressioni, sorte
in tempi lontani e che nel Rinascimento ritornano
in numerosi edifici religiosi fra i quali ricordiamo
a Prato, S. Maria delle Carceri (fig. 17); a Monte
pulciano, S. Biagio (fig. 18); a Firenze, la Rotonda
degli Angioli, del Brunelleschi (fig. 19); a Mantova,
S. Sebastiano, _ dell’Alberti; a Montefiascone il
Duomo del Sammicheli, ed infine nei progetti
e nelle opere del Bramante.
In Piemonte esempio tipico è la chiesa dei Cap
puccini a Torino, di Ascanio Vittozzi (1583)
(fig. 21). Altri esempi si notano sopratutto nelle
architetture del Lanfranchi e precisamente nelle
chiese torinesi della Visitazione (1661) (fig. 22)
e di S. Rocco (1667) (fig. 23). Queste chiese, plani
metricamente a*-«a« semplici, seguono in massima
M
9


















