
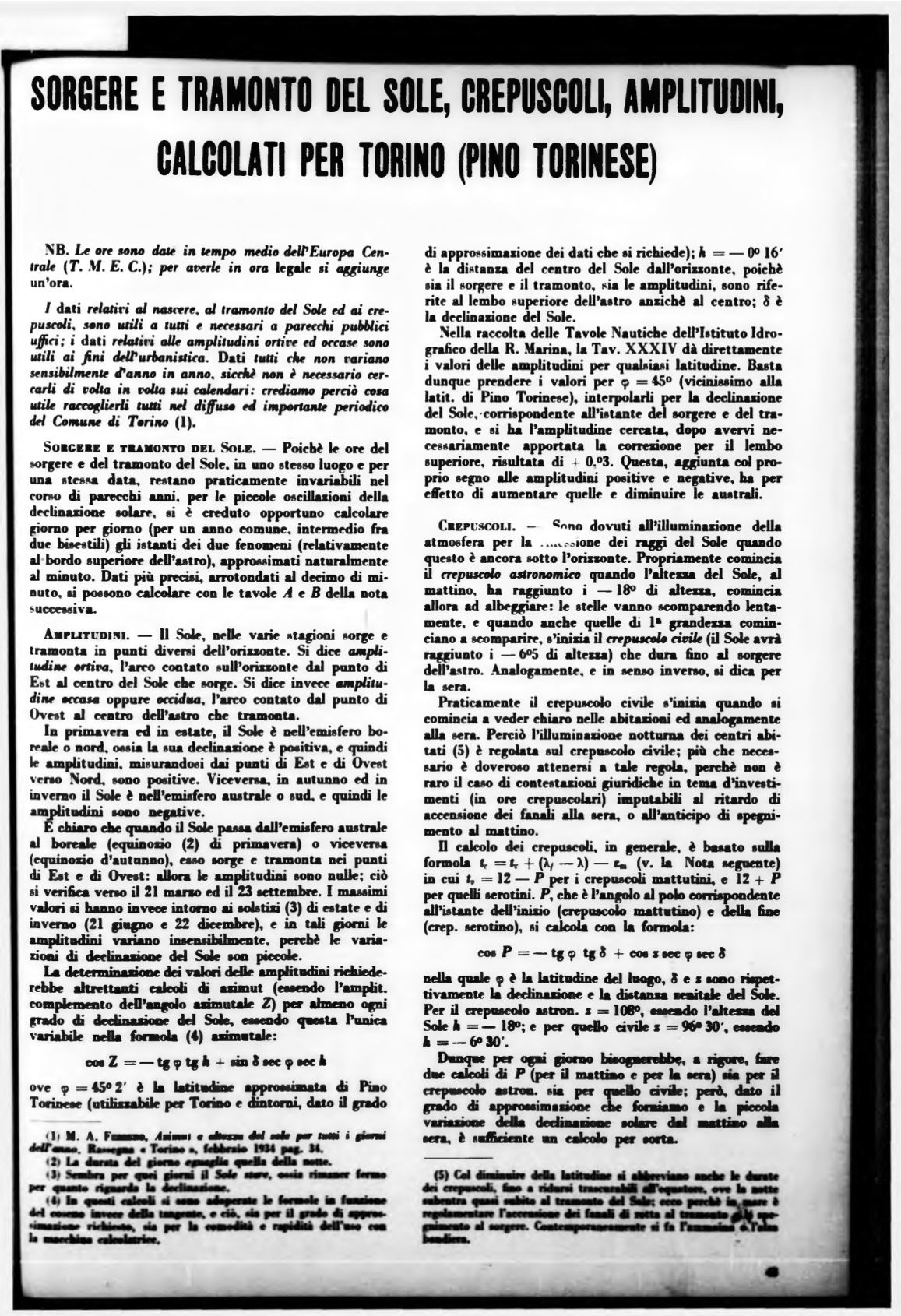
SORGERE E T R A M O N T O RE L SO LE , CREPUSCO L I, AM P L IT U D IN I ,
C A LC O LA T I PER TOR INO (P INO TO R IN E S E )
NB.
Le ore sono date in tempo medio deWEuropa Cen
trale
(
T
.
M. E . C. ); per averle in ora
legale
si aggiunge
un’ora.
/ dati
relativi al nascere, al tramonto del Sole ed ai cre
puscoli, sono utili a tutti e necessari a parecchi pubblici
uffici; i
dati
relativi alle amplitudini ortive ed occase sono
utili ai fin i dell'urbanistica.
Dati
tutti che non variano
sensibilmente d'anno in anno, sicché non è necessario cer
carli di volta in volta sui calendari: crediamo perciò cosa
utile raccoglierli tutti nel diffuso ed importante periodico
del Comune di Torino
(1).
S o r g e r e
e
t r am o n t o d e l
S
ole
. — Poiché le ore del
sorgere e del tramonto del Sole, in uno stesso luogo e per
una stessa data, restano praticamente invariabili nel
corso di parecchi anni, per le piccole oscillazioni della
declinazione solare, si è creduto opportuno calcolare
giorno per giorno (per un anno comune, intermedio fra
due bisestili) gli istanti dei due fenomeni (relativamente
al bordo superiore dell’astro), approssimati naturalmente
al minuto. Dati più precisi, arrotondati al decimo di mi
nuto, si possono calcolare con le tavole
A
e
B
della nota
successiva.
A
m p l it u d in i
. —
Il Sole, nelle varie stagioni sorge e
tramonta in punti diversi dell’orizzonte. Si dice
ampli
tudine orliva,
l’arco contato sull'orizzonte dal punto di
Est al centro del Sole che sorge. Si dice invece
amplitu
dine occaso
oppure
occidua,
l’arco contato dal punto di
Ovest al centro dell’astro che tramonta.
In primavera ed in estate, il Sole
è
nell’emisfero bo
reale o nord, ossia la sua declinazione
è
positiva, e quindi
le amplitudini, misurandosi dai punti di Est e di
Ovest
verso Nord, sono positive. Viceversa, in autunno ed in
inverno il Sole è nell’emisfero australe o sud, e quindi le
amplitudini sono negative.
E chiaro che quando il Sole passa dall'emisfero australe
al boreale (equinozio (
2
) di primavera) o viceversa
(equinozio d’autunno), esso sorge e tramonta nei punti
di Est e di Ovest: allora le amplitudini sono nulle; ciò
si verifica verso il 21 mano ed il 23 settembre. I massimi
valori si hanno invece intorno ai solstizi (3) di estate e di
inverno
(21
giugno e
22
dicembre), e in tali giorni le
amplitudini variano insensibilmente, perchè le varia*
rioni di declinazione del Sole son piccole.
La determinazione dei valori delle amplitudini richiede*
rebbe altrettanti calcoli di azimut (essendo l'amplit.
complemento dell’angolo azimutale Z) per almeno ogni
grado di dedina«ione del Sole, essendo questa l’unica
variabile nella formola (4) azimutale:
cosZ = — tg
9
tgfc + sin&sec<pseeà
ove
9
=45® 2' è la latitudine approssimata di Pino
Torinese (utilizzabile per Torino e dintorni, dato il grado
«li M. A. Fauna.
Arimttl
« «brasa
éd mie per ami i pmmi
di approssimazione dei dati che si richiede);
h
= —
0
° 16'
è
la distanza del centro del Sole dall’orizzonte, poiché
sia il sorgere e il tramonto, sia le amplitudini, sono rife
rite al lembo superiore dell’astro anziché al centro;
8
è
la declinazione del Sole.
Nella raccolta delle Tavole Nautiche dell’istituto Idro
grafico della R. Marina, la Tav. XXXIV dà direttamente
i valori delle amplitudini per qualsiasi latitudine. Basta
dunque prendere i valori per
9
=45° (vicinissimo alla
latit. di Pino Torinese), interpolarli per la declinazione
del Sole,-corrispondente all’istante del sorgere e del tra
monto, e si ha l’amplitudine cercata, dopo avervi ne
cessariamente apportata la correzione per il lembo
superiore, risultata di + 0.°3. Questa, aggiunta col pro
prio segno alle amplitudini positive e negative, ha per
effetto di aumentare quelle e diminuire le australi.
C repu s c o li.
— s<in« dovuti all’illuminazione della
atmosfera per la •«»ti.^3ione dei raggi del Sole quando
questo
è
ancora sotto l’orizzonte. Propriamente comincia
il
crepuscolo astronomico
quando l’altezza del Sole, al
mattino, ha raggiunto i — 18° di altezza, comincia
allora ad albeggiare: le stelle vanno scomparendo lenta
mente, e quando anche quelle di
1
* grandezza comin
ciano a scomparire, s’inizia il
crepuscolo civile
(il Sole avrà
raggiunto i — 6°5 di altezza) che dura fino al sorgere
dell’astro. Analogamente, e in senso inverso, si dica per
la sera.
Praticamente il crepuscolo civile s’inizia quando si
comincia a veder chiaro nelle abitazioni ed analogamente
alla sera. Perciò l’illuminazione notturna dei centri abi
tati (5)
è
regolata sul crepuscolo civile; più che neces
sario
è
doveroso attenersi a tale regola, perchè non è
raro il caso di contestazioni giuridiche in tema d’investi
menti (in ore crepuscolari) imputabili al ritardo di
accensione dei fanali alla sera, o all’anticipo di spegni
mento al mattino.
Il calcolo dei crepuscoli, in generale, è basato sulla
formola L = Ir + (X/ — X) — c. (v. la Nota seguente)
in cui
U =
12—
P
per i crepuscoli mattutini, e 12
+ P
per quelli serotini. P, che è l’angolo al polo corrispondente
all’istante dell’inizio (crepuscolo mattutino) e della fine
(crep. serotino), si calcola con la formola:
cos
P =
— tg
9
tg
8
+ cos
x
sec
9
sec &
nella quale
9
è la latitudine del luogo, S e * sono rispet
tivamente la declinazione e la distanza zenitale del Sole.
Per il crepuscolo astron.
x =
108°, essendo l’altezza del
Sole
h =
— 18°; e per quello civile z = 96° 30', essendo
k
= —
6
° 30'.
Dunque per ogni giorno bisognerebbe, a rigore, fare
due calcoli di P (per il mattino e per la sera) sta per il
crepuscolo astron. sia per quello civile; peri, dato il
grado di approssimazione che foniamo e In piccola
variazione della dedina«ione solare dal Ruttino alla
sera, è sufficiente un calcolo per sorta.


















