
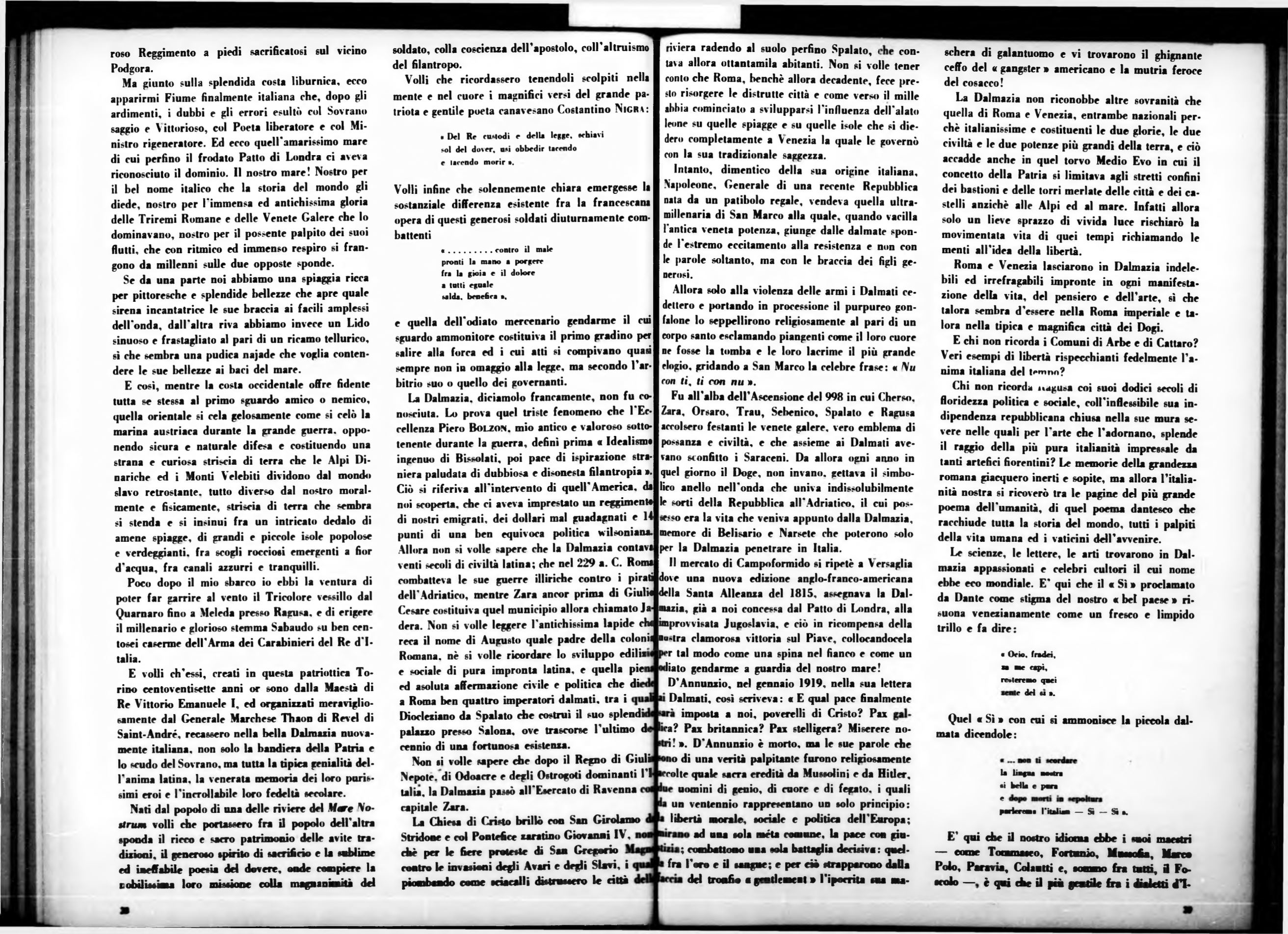
I
il
j
roso Reggimento a piedi sacrificatosi sul vicino
Podgora.
Ma giunto sulla splendida costa liburnica, ecco
apparirmi Fiume finalmente italiana che, dopo gli
ardimenti, i dubbi e gli errori esultò col Sovrano
saggio e Vittorioso, col Poeta liberatore e col Mi
nistro rigeneratore. Ed ecco queU'amarissimo mare
di cui perfino il frodato Patto di Londra ci aveva
riconosciuto il dominio. Il nostro mare! Nostro per
il bel nome italico che la storia del mondo gli
diede, nostro per l'immensa ed antichissima gloria
delle Triremi Romane e delle Venete Galere che lo
dominavano, nostro per il possente palpito dei suoi
flutti, che con ritmico ed immenso respiro si fran
gono da millenni sulle due opposte sponde.
Se da una parte noi abbiamo una spiaggia ricca
per pittoresche e splendide bellezze che apre quale
sirena incantatrice le sue braccia ai facili amplessi
dell'onda, dall'altra riva abbiamo invece un Lido
sinuoso e frastagliato al pari di un ricamo tellurico,
sì che sembra una pudica najade che voglia conten
dere le sue bellezze ai baci del mare.
E così, mentre la costa occidentale offre fidente
tutta se stessa al primo sguardo amico o nemico,
quella orientale si cela gelosamente come si celò la
marina austriaca durante la grande guerra, oppo
nendo sicura e naturale difesa e costituendo una
strana e curiosa striscia di terra che le Alpi Di-
nariche ed i Monti Velebiti dividono dal mondo
slavo retrostante, tutto diverso dal nostro moral
mente e fisicamente, striscia di terra che sembra
si stenda e si insinui fra un intricato dedalo di
amene spiagge, di grandi e piccole isole popolose
e verdeggianti, fra scogli rocciosi emergenti a fior
d'acqua, fra canali azzurri e tranquilli.
Poco dopo il mio sbarco io ebbi la ventura di
poter far garrire al vento il Tricolore vessillo dal
Quarnaro fino a Meleda presso Ragusa. e di erigere
il millenario e glorioso stemma Sabaudo su ben cen
tosei caserme dell'Arma dei Carabinieri del Re d'I
talia.
E volli ch'essi, creali in questa patriottica To
rino centoventisette anni or sono dalla Maestà di
Re Vittorio Emanuele I, ed organizzati meraviglio
samente dal Generale Marchese Thaon di Revel di
Saint-André, recassero nella bella Dalmazia nuova
mente italiana, non solo la bandiera della Patria e
lo scudo del Sovrano, ma tutta la tìpica genialità del
l'anima latina, la venerata memoria dei loro puris
simi eroi e l'incrollabile loro fedeltà secolare.
Nati dal popolo di una delle riviere del
Mme
\o-
strum
volli che portassero fra il popolo deU'altra
sponda il ricco e sacro patrimonio delle avite tra
dizioni, il generoso spirito di sacrificio e la sublime
ed ineffabile poesia del dovere, onde compiere la
cobilistima loro aaissione colla magnanimità del
consoldato, colla coscienza dell’apostolo, coll’ altruismo
del filantropo.
Volli che ricordassero tenendoli scolpiti nella
mente e nel cuore i magnifici versi del grande pa
triota e gentile poeta canavesano Costantino N
igra
:
« Del Re custodi e della legge, «chiavi
sol del dover, tisi obbedir tacendo
e tacendo morir ».
Volli infine che solennemente chiara emergesse la
sostanziale differenza esistente fra la francescana
opera di questi generosi soldati diuturnamente com
battenti
• .................. contro il male
pronti la mano a porgere
fra la gioia e il dolore
a tutti eguale
salda, benefica i,
e quella dell'odiato mercenario gendarme il cui
sguardo ammonitore costituiva il primo gradino per
salire alla forca ed i cui atti si compivano quasi
sempre non in omaggio alla legge, ma secondo l'ar
bitrio suo o quello dei governanti.
La Dalmazia, diciamolo francamente, non fu co
nosciuta. Lo prova quel triste fenomeno che l’Ec-
cellenza Piero
B
o l z o n
.
mio antico e valoroso sotto-
tenente durante la guerra, definì prima « Idealismi
ingenuo di Bissolati, poi pace di ispirazione stra
niera paludata di dubbiosa e disonesta filantropia ».
Ciò si riferiva all'intervento di queU'America, da
noi scoperta, che ci aveva imprestato un reggimento
di nostri emigrati, dei dollari mal guadagnati e 14
punti di una ben equivoca politica wilsoniana.
Allora non si volle sapere che la Dalmazia contava
venti secoli di civiltà latina; che nel 229 a. C. Roma
combatteva le sue guerre illiriche contro i pirati
deU'Adriatico, mentre Zara ancor prima di Giuli«|della Santa Alleanza del 1815, assegnava la Dal-
Cesare costituiva quel municipio allora chiamato Ja-
Romana, nè si volle ricordare lo sviluppo edilizi
e sociale di pura impronta latina, e quella piei
ed asoluta affermazione civile e politica che dii
a Roma ben quattro imperatori dalmati, tra i
Diocleziano da Spalato die costruì il suo splendi
palazzo presso Salona, ove trascorse l'ultimo di
cennio di una fortunosa esistenza.
Non si volle sapere che dopo il Regno di Giuli
Nepote. di Odoacre e degli Ostrogoti dominanti IT
talia, la Dalmazia passò all*Escreato di Ravenna
capitale Zara.
La Chiesa di Cristo brillò con San Girolamo
Stridone e col Pontefice zaratino Giovanni IV,
chè per le fiere proteste di San Gregorio
contro le invasioni degli Avari e degli Slavi, i
piombando come sciacalli distrassero le città
iviera radendo al suolo perfino Spalato, <
tava allora ottantamila abitanti. Non si volle tener
conto che Roma, benché allora decadente, fece pre
sto risorgere le distrutte città e come verso il mille
abbia cominciato a svilupparsi l'influenza dell'alato
leone su quelle spiagge e su quelle isole che si die
dero completamente a Venezia la quale le governò
con la sua tradizionale saggezza.
Intanto, dimentico della sua origine italiana.
Napoleone, Generale di una recente Repubblica
nata da un patibolo regale, vendeva quella ultra
millenaria di San Marco alla quale, quando vacilla
l'antica veneta potenza, giunge dalle dalmate spon
de l'estremo eccitamento alla resistenza e non con
le parole soltanto, ma con le braccia dei figli ge
nerosi.
Allora solo alla violenza delle armi i Dalmati ce
dettero e portando in processione il purpureo gon
falone lo seppellirono religiosamente al pari di un
corpo santo esclamando piangenti come il loro cuore
ne fosse la tomba e le loro lacrime il più grande
elogio, gridando a San Marco la celebre frase: « Vii
con ti
, fi
con nu
».
Fu all'alba dell’Ascensione del 998 in cui Cherso.
Zara, Orsaro, Trau, Sebenico, Spalato e Ragusa
accolsero festanti le venete galere, vero emblema di
possanza e civiltà, e che assieme ai Dalmati ave
vano sconfitto i Saraceni. Da allora ogni anno in
quel giorno il Doge, non invano, pettata il simbo
lico anello nell'onda che univa indissolubilmente
le sorti della Repubblica all'Adriatiro. il cui pos
sesso era la vita che veniva appunto dalla Dalmazia,
memore di Belisario e Narsete che poterono solo
per la Dalmazia penetrare in Italia.
Il mercato di Campoformido si ripetè a Versaglia
dove una nuova edizione anglo-franco-americana
pazia, già a noi concessa dal Patto di Londra, alla
dera. Non si volle leggere l'antichissima lapide dwlimprovvisata Jugoslavia, e ciò in ricompensa della
reca il nome di Augusto quale padre della colonii|nu*tra clamorosa vittoria sul Piave, collocandocela
?r tal modo come una spina nel fianco e come un
liato gendarme a guardia del nostro mare!
D’Annunzio, nel gennaio 1919, nella sua lettera
Dalmati, così scriveva : « E qual pace finalmente
imposta a noi, poverelli di Cristo? Pax
ra? Pax britannica? Pax stelligera? Miserere no-
i ! ». D'Annunzio
è
morto, ma le sue parole che
io di una verità palpitante furono religiosamente
rcolte quale sacra eredità da Mussolini e da Hitler,
uomini di genio, di cuore e di fegato, i quali
un ventennio rappresentano un solo principio:
libertà morale, sociale e politica dell'Europa;
ad una sola méta comune, la pace con gin-
i; combattono una «ola battaglia decisiva :
q-el-
fra Poro e il sangue; e per ciò strapparono dalla
del tronfio a g«—tlcmcnt » l'ipocrita sna ma
schera di galantuomo e vi trovarono il ghignante
ceffo del « gangster » americano e la mutria feroce
del cosacco!
La Dalmazia non riconobbe altre sovranità che
quella di Roma e Venezia, entrambe nazionali per
chè italianissime e costituenti le due glorie, le due
civiltà e le due potenze più grandi della terra, e ciò
accadde anche in quel torvo Medio Evo in cui il
concetto della Patria si limitava agli stretti confini
dei bastioni e delle torri merlate delle città e dei ca
stelli anziché alle Alpi ed al mare. Infatti allora
solo un lieve sprazzo di vivida luce rischiarò la
movimentata vita di quei tempi richiamando le
menti all'idea della libertà.
Roma e Venezia lasciarono in Dalmazia indele
bili ed irrefragabili impronte in ogni manifesta
zione della vita, del pensiero e dell’arte, sì che
talora sembra d’essere nella Roma imperiale e ta
lora nella tipica e magnifica città dei Dogi.
E chi non ricorda i Comuni di Arbe e di Cattaro?
Veri esempi di libertà rispecchianti fedelmente l'a
nima italiana del t#»mno?
Chi non ricorda ita^usa coi suoi dodici secoli di
floridezza politica e sociale, coll'inflessibile sua in
dipendenza repubblicana chiusa nella sue mura se
vere nelle quali per l'arte che l'adornano, splende
il raggio della più pura italianità impressale da
tanti artefici fiorentini? Le memorie della grandezza
romana giacquero inerti e sopite, ma allora l’ italia
nità nostra si ricoverò tra le pagine del più grande
poema dell'umanità, di quel poema dantesco che
racchiude tutta la storia del mondo, tutti i palpiti
della vita umana ed i vaticini dell’ avvenire.
Le scienze, le lettere, le arti trovarono in Dal
mazia appassionati e celebri cultori il cui nome
ebbe eco mondiale. E* qui che il « Sì » proclamato
da Dante come stigma del nostro « bel paese » ri
suona venezianamente come un fresco e limpido
trillo e fa dire:
• Orio, fradei,
sa me rapi,
resteremo quei
te del u ».
Quel « Sì » con cui si ammonisce la piccola dal
mata dicendole:
la tiagua nostra
*i
bella e para
e
parle r e i» l'italian — S — S a.
E’ qui che il nostro idioma ebbe i «noi maestri
— come Tommaseo, Fortnnio, Muasofia, Mare*
Polo, Paravia, Colautti e, sommo fra tutti, il Fo>
scolo — è qui che U più gentile fra i dialetti d i -
k
__


















