
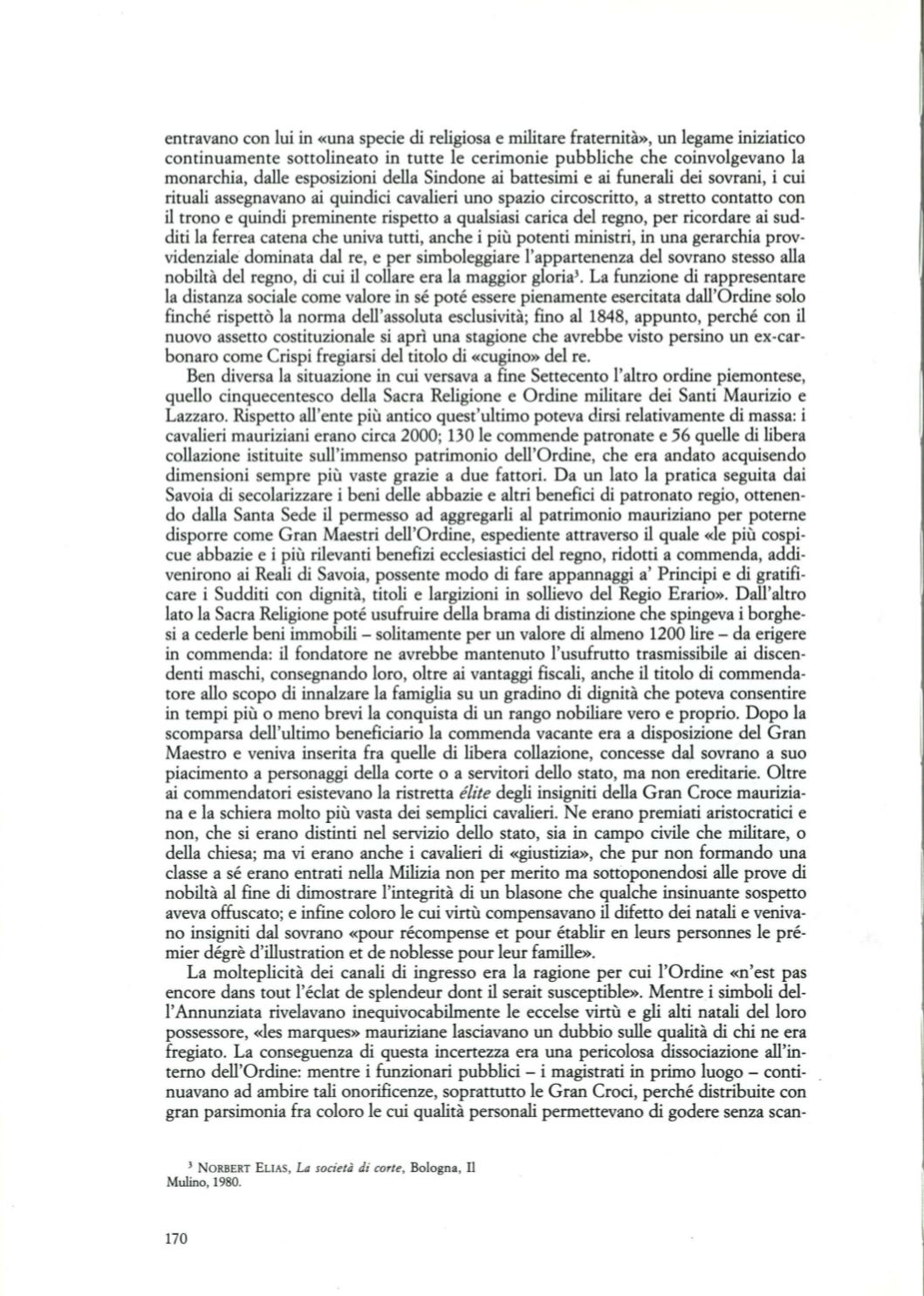
entravano con lui in «una specie di religiosa e militare fraternità», un legame iniziatico
continuamente sottolineato in tutte le cerimonie pubbliche che coinvolgevano la
monarchia, dalle esposizioni della Sindone ai battesimi e ai funerali dei sovrani, i cui
rituali assegnavano ai quindici cavalieri uno spazio circoscritto, a stretto contatto con
il trono e quindi preminente rispetto a qualsiasi carica del regno, per ricordare ai sud–
diti la ferrea catena che univa tutti, anche i più potenti ministri, in una gerarchia prov–
videnziale dominata dal re, e per simboleggiare l'appartenenza del sovrano stesso alla
nobiltà del regno, di cui il collare era la maggior gloria
3 •
La funzione di rappresentare
la distanza sociale come valore in sé poté essere pienamente esercitata dall'Ordine solo
finché rispettò la norma dell'assoluta esclusività; fino al
1848,
appunto, perché con il
nuovo assetto costituzionale si aprì una stagione che avrebbe visto persino un ex-car–
bonaro come Crispi fregiarsi del titolo di «cugino» del re.
Ben diversa la situazione in cui versava a fine Settecento l'altro ordine piemontese,
quello cinquecentesco della Sacra Religione e Ordine militare dei Santi Maurizio e
Lazzaro. Rispetto all'ente più antico quest'ultimo poteva dirsi relativamente di massa: i
cavalieri mauriziani erano circa 2000; 130 le commende patronate e 56 quelle di libera
collazione istituite sull'immenso patrimonio dell'Ordine, che era andato acquisendo
dimensioni sempre più vaste grazie a due fattori. Da un lato la pratica seguita dai
Savoia di secolarizzare i beni delle abbazie e altri benefici di patronato regio, ottenen–
do dalla Santa Sede il permesso ad aggregarli al patrimonio mauriziano per poterne
disporre come Gran Maestri dell'Ordine, espediente attraverso il quale «le più cospi–
cue abbazie e i più rilevanti benefizi ecclesiastici del regno, ridotti a commenda, addi–
venirono ai Reali di Savoia, possente modo di fare appannaggi a' Principi e di gratifi–
care i Sudditi con dignità, titoli e largizioni in sollievo del Regio Erario». Dall'altro
lato la Sacra Religione poté usufruire della brama di distinzione che spingeva i borghe–
si a cederle beni immobili - solitamente per un valore di almeno 1200 lire - da erigere
in commenda: il fondatore ne avrebbe mantenuto l'usufrutto trasmissibile ai discen–
denti maschi, consegnando loro, oltre ai vantaggi fiscali , anche il titolo di commenda–
tore allo scopo di innalzare la famiglia su un gradino di dignità che poteva consentire
in tempi più o meno brevi la conquista di un rango nobiliare vero e proprio. Dopo la
scomparsa dell'ultimo beneficiario la commenda vacante era a disposizione del Gran
Maestro e veniva inserita fra quelle di libera collazione, concesse dal sovrano a suo
piacimento a personaggi della corte o a servitori dello stato, ma non ereditarie. Oltre
ai commendatori esistevano la ristretta
élite
degli insigniti della Gran Croce maurizia–
na e la schiera molto più vasta dei semplici cavalieri. Ne erano premiati aristocratici e
non, che si erano distinti nel servizio dello stato, sia in campo civile che militare, o
della chiesa; ma vi erano anche i cavalieri di «giustizia», che pur non formando una
classe a sé erano entrati nella Milizia non per merito ma sottoponendosi alle prove di
nobiltà al fine di dimostrare l'integrità di un blasone che qualche insinuante sospetto
aveva offuscato; e infine coloro le cui virtù compensavano il difetto dei natali e veniva–
no insigniti dal sovrano «pour récompense et pour établir en leurs personnes le pré–
mier dégrè d'illustration et de noblesse pour leur famille».
La molteplicità dei canali di ingresso era la ragione per cui l'Ordine «n'est pas
encore dans tout l'éclat de splendeur dont il serait susceptible». Mentrei simboli del–
l'Annunziata rivelavano inequivocabilmente le eccelse virtù e gli alti natali del loro
possessore, «les marques» mauriziane lasciavano un dubbio sulle qualità di chi ne era
fregiato . La conseguenza di questa incertezza era una pericolosa dissociazione all'in–
terno dell'Ordine: mentre i funzionari pubblici - i magistrati in primo luogo - conti–
nuavano ad ambire tali onorificenze, soprattutto le Gran Croci, perché distribuite con
gran parsimonia fra coloro le cui qualità personali permettevano di godere senza scan-
3 N ORBERT ELIAS ,
La società di corte,
Bologna, Il
Mulino, 1980.
170


















