
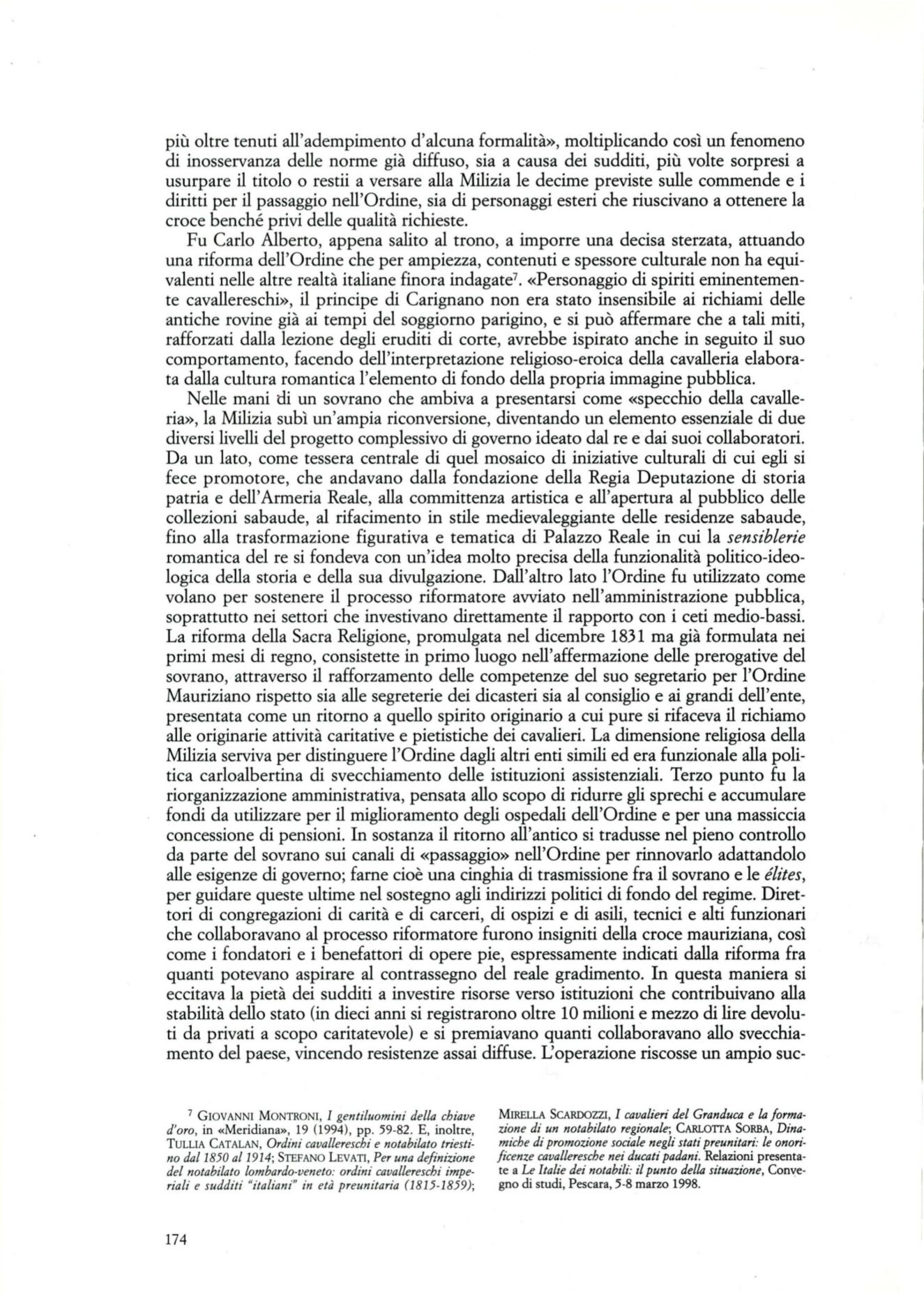
più oltre tenuti all'adempimento d'alcuna formalità», moltiplicando così un fenomeno
di inosservanza delle norme già diffuso, sia a causa dei sudditi, più volte sorpresi a
usurpare il titolo o restii a versare alla Milizia le decime previste sulle commende e i
diritti per il passaggio nell'Ordine, sia di personaggi esteri che riuscivano a ottenere la
croce benché privi delle qualità richieste.
Fu Carlo Alberto, appena salito al trono, a imporre una decisa sterzata, attuando
una riforma dell'Ordine che per ampiezza, contenuti e spessore culturale non ha equi–
valenti nelle altre realtà italiane finora indagate
7 •
«Personaggio di spiriti eminentemen–
te cavallereschi», il principe di Carignano non era stato insensibile ai richiami delle
antiche rovine già ai tempi del soggiorno parigino, e si può affermare che a tali miti,
rafforzati dalla lezione degli eruditi di corte, avrebbe ispirato anche in seguito il suo
comportamento, facendo dell'interpretazione religioso-eroica della cavalleria elabora–
ta dalla cultura romantica l'elemento di fondo della propria immagine pubblica.
Nelle mani di un sovrano che ambiva a presentarsi come «specchio della cavalle–
ria», la Milizia subì un' ampia riconversione, diventando un elemento essenziale di due
diversi livelli del progetto complessivo di governo ideato dal re e dai suoi collaboratori.
Da un lato, come tessera centrale di quel mosaico di iniziative culturali di cui egli si
fece promotore, che andavano dalla fondazione della Regia Deputazione di storia
patria e dell'Armeria Reale, alla committenza artistica e all' apertura al pubblico delle
collezioni sabaude, al rifacimento in stile medievaleggiante delle residenze sabaude,
fino alla trasformazione figurativa e tematica di Palazzo Reale in cui la
sensiblerie
romantica del re si fondeva con un'idea molto precisa della funzionalità politico-ideo–
logica della storia e della sua divulgazione. Dall'altro lato l'Ordine fu utilizzato come
volano per sostenere il processo riformatore avviato nell' amministrazione pubblica,
soprattutto nei settori che investivano direttamente il rapporto con i ceti medio-bassi.
La riforma della Sacra Religione, promulgata nel dicembre 1831 ma già formulata nei
primi mesi di regno, consistette in primo luogo nell'affermazione delle prerogative del
sovrano, attraverso il rafforzamento delle competenze del suo segretario per l'Ordine
Mauriziano rispetto sia alle segreterie dei dicasteri sia al consiglio e ai grandi dell'ente,
presentata come un ritorno a quello spirito originario a cui pure si rifaceva il richiamo
alle originarie attività caritative e pietistiche dei cavalieri. La dimensione religiosa della
Milizia serviva per distinguere l'Ordine dagli altri enti simili ed era funzionale alla poli–
tica carloalbertina di svecchiamento delle istituzioni assistenziali. Terzo punto fu la
riorganizzazione amministrativa, pensata allo scopo di ridurre gli sprechi e accumulare
fondi da utilizzare per il miglioramento degli ospedali dell'Ordine e per una massiccia
concessione di pensioni. In sostanza il ritorno all'antico si tradusse nel pieno controllo
da parte del sovrano sui canali di «passaggio» nell'Ordine per rinnovarlo adattandolo
alle esigenze di governo; farne cioè una cinghia di trasmissione fra il sovrano e le
élites,
per guidare queste ultime nel sostegno agli indirizzi politici di fondo del regime. Diret–
tori di congregazioni di carità e di carceri, di ospizi e di asili, tecnici e alti funzionari
che collaboravano al processo riformatore furono insigniti della croce mauriziana, così
come i fondatori e i benefattori di opere pie, espressamente indicati dalla riforma fra
quanti potevano aspirare al contrassegno del reale gradimento. In questa maniera si
eccitava la pietà dei sudditi a investire risorse verso istituzioni che contribuivano alla
stabilità dello stato (in dieci anni si registrarono oltre 10 milioni e mezzo di lire devolu–
ti da privati a scopo caritatevole) e si premiavano quanti collaboravano allo svecchia–
mento del paese, vincendo resistenze assai diffuse. L'operazione riscosse un ampio suc-
7 G IOVANNI M ONTRONI,
I gentiluomini della chiave
d'oro,
in «Meridiana», 19 (1 994), pp. 59-82. E, inoltre,
T ULLIA CATALAN,
Ordini cavallereschi e notabilato triesti–
no dal 1850 al
1914; STEFANO L EVATI,
Per una definizione
del notabilato lombardo-veneto: ordini cavallereschi impe–
riali e sudditi "italiani" in età preunitaria (1815-1 859);
174
M IRELLA SCARDOZZI,
I cavalieri del Granduca e la forma·
zione di un notabilato regionale;
CARLOTTA SORBA,
Dina·
miche di promozione sociale negli stati preunitari: le onori·
ficenze cavalleresche nei ducati padani.
Relazioni presenta–
te a
Le Italie dei notabili: il punto della situazione,
Conve–
gno di studi, Pescara, 5-8 marzo 1998.


















