
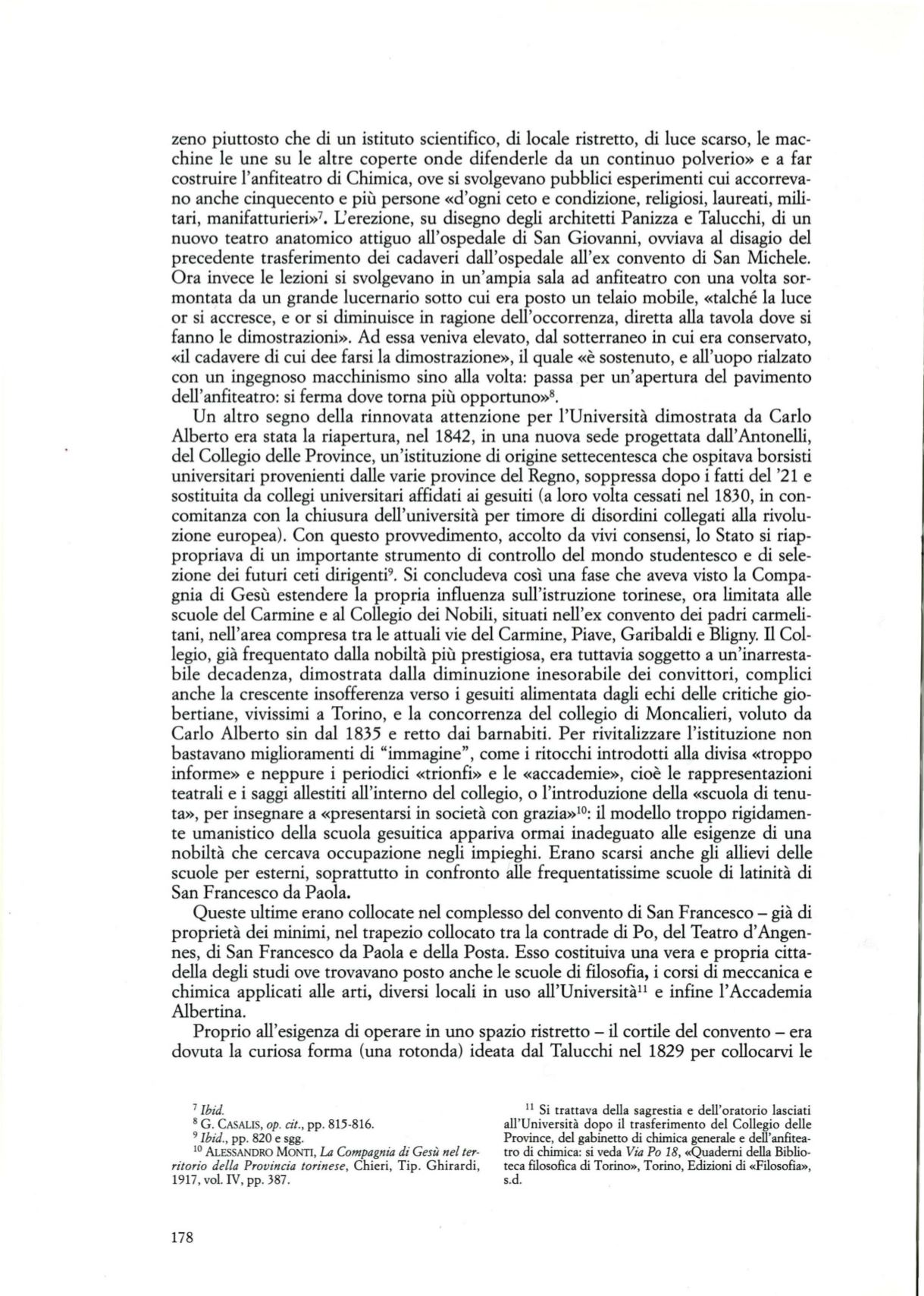
zeno piuttosto che di un istituto scientifico, di locale ristretto, di luce scarso, le mac–
chine le une su le altre coperte onde difenderle da un continuo polverio» e a far
costruire l'anfiteatro di Chimica, ove si svolgevano pubblici esperimenti cui accorreva–
no anche cinquecento e più persone «d'ogni ceto e condizione, religiosi, laureati, mili–
tari, manifatturieri»7. L'erezione, su disegno degli architetti Panizza e Talucchi, di un
nuovo teatro anatomico attiguo all' ospedale di San Giovanni, ovviava al disagio del
precedente trasferimento dei cadaveri dall'ospedale all'ex convento di San Michele.
Ora invece le lezioni si svolgevano in un' ampia sala ad anfiteatro con una volta sor–
montata da un grande lucernario sotto cui era posto un telaio mobile, «talché la luce
or si accresce, e or si diminuisce in ragione dell' occorrenza, diretta alla tavola dove si
fanno le dimostrazioni». Ad essa veniva elevato, dal sotterraneo in cui era conservato,
«il cadavere di cui dee farsi la dimostrazione», il quale «è sostenuto, e all'uopo rialzato
con un ingegnoso macchinismo sino alla volta: passa per un' apertura del pavimento
dell'anfiteatro: si ferma dove torna più opportuno»8.
Un altro segno della rinnovata attenzione per l'Università dimostrata da Carlo
Alberto era stata la riapertura, nel 1842, in una nuova sede progettata dall'Antonelli,
del Collegio delle Province, un'istituzione di origine settecentesca che ospitava borsisti
universitari provenienti dalle varie province del Regno, soppressa dopo i fatti del '21 e
sostituita da collegi universitari affidati ai gesuiti (a loro volta cessati nel 1830, in con–
comitanza con la chiusura dell'università per timore di disordini collegati alla rivolu–
zione europea). Con questo provvedimento, accolto da vivi consensi, lo Stato si riap–
propriava di un importante strumento di controllo del mondo studentesco e di sele–
zione dei futuri ceti dirigenti
9 •
Si concludeva cosÌ una fase che aveva visto la Compa–
gnia di Gesù estendere la propria influenza sull'istruzione torinese, ora limitata alle
scuole del Carmine e al Collegio dei Nobili, situati nell'ex convento dei padri carmeli–
tani, nell'area compresa tra le attuali vie del Carmine, Piave, Garibaldi e Bligny. Il Col–
legio, già frequentato dalla nobiltà più prestigiosa, era tuttavia soggetto a un'inarresta–
bile decadenza, dimostrata dalla diminuzione inesorabile dei convittori, complici
anche la crescente insofferenza verso i gesuiti alimentata dagli echi delle critiche gio–
bertiane, vivissimi a Torino, e la concorrenza del collegio di Moncalieri, voluto da
Carlo Alberto sin dal 1835 e retto dai barnabiti. Per rivitalizzare l'istituzione non
bastavano miglioramenti di "immagine", come i ritocchi introdotti alla divisa «troppo
informe» e neppure i periodici «trionfi» e le «accademie», cioè le rappresentazioni
teatrali e i saggi allestiti all'interno del collegio, o l'introduzione della «scuola di tenu–
ta», per insegnare a «presentarsi in società con grazia»lO: il modello troppo rigidamen–
te umanistico della scuola gesuitica appariva ormai inadeguato alle esigenze di una
nobiltà che cercava occupazione negli impieghi. Erano scarsi anche gli allievi delle
scuole per esterni, soprattutto in confronto alle frequentatissime scuole di latinità di
San Francesco da Paola.
Queste ultime erano collocate nel complesso del convento di San Francesco - già di
proprietà dei minimi, nel trapezio collocato tra la contrade di Po, del Teatro d'Angen–
nes, di San Francesco da Paola e della Posta. Esso costituiva una vera e propria citta–
della degli studi ove trovavano posto anche le scuole di filosofia, i corsi di meccanica e
chimica applicati alle arti, diversi locali in uso all'Università
ll
e infine l'Accademia
Albertina.
Proprio all'esigenza di operare in uno spazio ristretto - il cortile del convento - era
dovuta la curiosa forma (una rotonda) ideata dal Talucchi nel 1829 per collocarvi le
7
Ibid.
8
G .
CASALIS,
Op.
cit. ,
pp. 815-816.
9
Ibid.,
pp. 820 e sgg.
lO ALESSANDRO M ONTI,
La
Compagnia di Gesù nel ter–
ritorio della Provincia torinese,
Chieri, Tip. Ghirardi,
1917, voI. IV, pp. 387.
178
11
Si trattava della sagrestia e dell'oratorio lasciati
all'Università dopo il trasferimento del Collegio delle
Province, del gabinetto di chimica generale e dell'anfitea–
tro di chimica: si veda
Via Po
18, «Quaderni della Biblio–
teca filosofica di Torino», Torino, Edizioni di «Filosofia»,
s.d.


















