
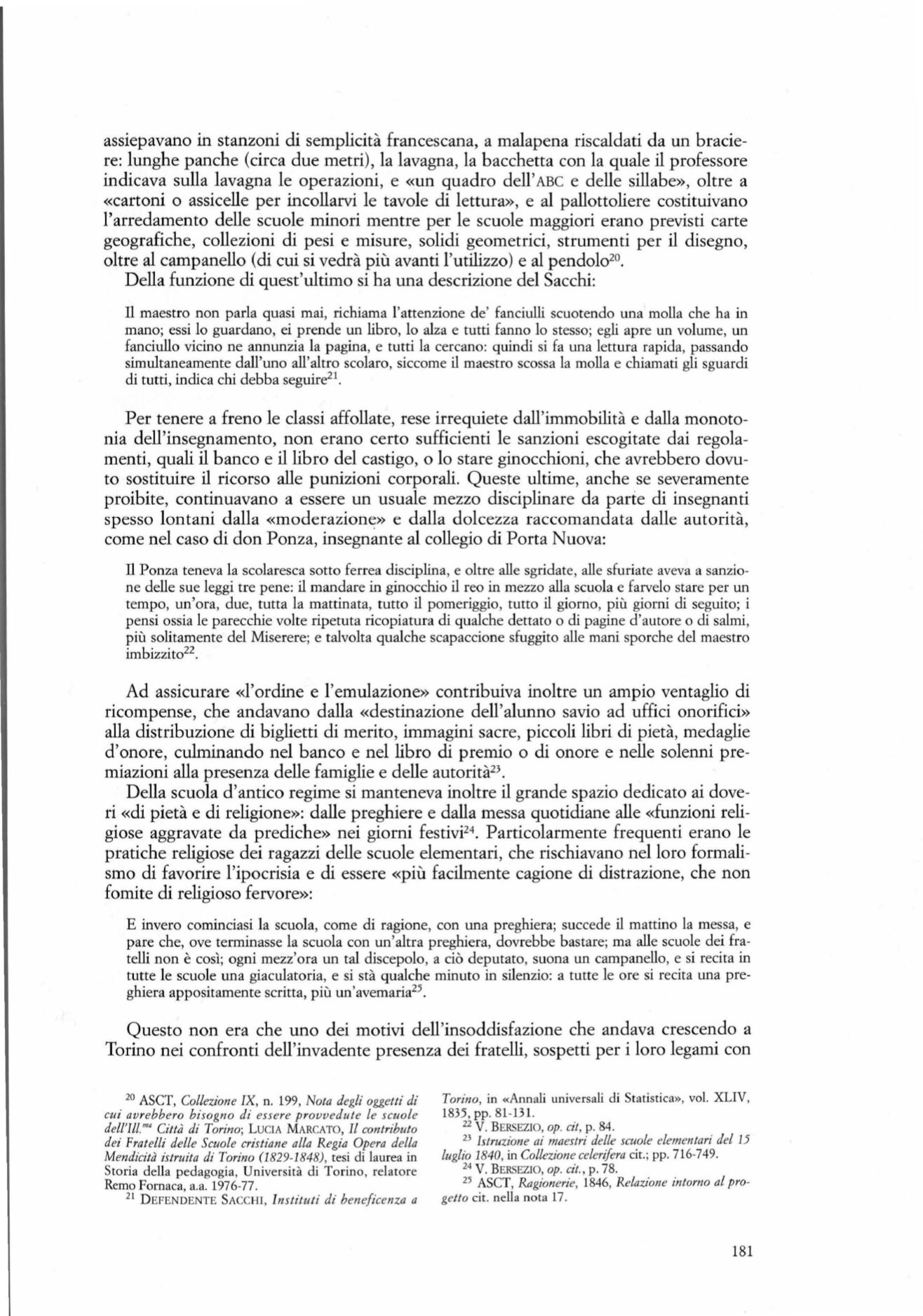
assiepavano in stanzoni di semplicità francescana, a malapena riscaldati da un bracie–
re: lunghe panche (circa due metri), la lavagna, la bacchetta con la quale il professore
indicava sulla lavagna le operazioni, e «un quadro dell'
ABC
e delle sillabe», oltre a
«cartoni o assicelle per incollarvi le tavole di lettura», e al pallottoliere costituivano
l'arredamento delle scuole minori mentre per le scuole maggiori erano previsti carte
geografiche, collezioni di pesi e misure, solidi geometrici, strumenti per il disegno,
oltre al campanello (di cui si vedrà più avanti l'utilizzo) e al pendol0
20 .
Della funzione di quest'ultimo si ha una descrizione del Sacchi:
li
maestro non parla quasi mai, richiama l'attenzione de' fanciulli scuotendo una molla che ha in
mano; essi lo guardano, ei prende un libro, lo alza e tutti fanno lo stesso; egli apre un volume, un
fanciullo vicino ne annunzia la pagina, e tutti la cercano: quindi si fa una lettura rapida, passando
simultaneamente dall'uno all'altro scolaro, siccome il maestro scossa la molla e chiamati gli sguardi
di tutti, indica chi debba seguire
21 .
Per tenere a freno le classi affollate, rese irrequiete dall'immobilità e dalla monoto–
nia dell'insegnamento, non erano certo sufficienti le sanzioni escogitate dai regola–
menti, quali il banco e il libro del castigo, o lo stare ginocchioni, che avrebbero dovu–
to sostituire il ricorso alle punizioni corporali. Queste ultime, anche se severamente
proibite, continuavano a essere un usuale mezzo disciplinare da parte di insegnanti
spesso lontani dalla «moderazione» e dalla dolcezza raccomandata dalle autorità,
come nel caso di don Ponza, insegnànte al collegio di Porta Nuova:
li
Ponza teneva la scolaresca sotto ferrea disciplina, e oltre alle sgridate, alle sfuriate aveva a sanzio–
ne delle sue leggi tre pene: il mandare in ginocchio il reo in mezzo alla scuola e farvelo stare per un
tempo, un'ora, due, tutta la mattinata, tutto il pomeriggio, tutto il giorno, più giorni di seguito; i
pensi ossia le parecchie volte ripetuta ricopiatura di qualche dettato o di pagine d'autore o di salmi,
più solitamente del Miserere; e talvolta qualche scapaccione sfuggito alle mani sporche del maestro
imbizzit0
22 .
Ad assicurare «l'ordine e l'emulazione» contribuiva inoltre un ampio ventaglio di
ricompense, che andavano dalla «destinazione dell' alunno savio ad uffici onorifici»
alla distribuzione di biglietti di merito, immagini sacre, piccoli libri di pietà, medaglie
d'onore, culminando nel banco e nel libro di premio o di onore e nelle solenni pre–
miazioni alla presenza delle famiglie e delle autorità
23 •
Della scuola d'antico regime si manteneva inoltre il grande spazio dedicato ai dove–
ri «di pietà e di religione»: dalle preghiere e dalla messa quotidiane alle «funzioni reli–
giose aggravate da prediche» nei giorni festivi
24 •
Particolarmente frequenti erano le
pratiche religiose dei ragazzi delle scuole elementari, che rischiavano nel loro formali–
smo di favorire l'ipocrisia e di essere «più facilmente cagione di distrazione, che non
fomite di religioso fervore»:
E invero cominciasi la scuola, come di ragione, con una preghiera; succede il mattino la messa, e
pare che, ove terminasse la scuola con un'altra preghiera, dovrebbe bastare; ma alle scuole dei fra–
telli non è così; ogni mezz'ora un tal discepolo, a ciò deputato, suona un campanello, e si recita in
tutte le scuole una giaculatoria, e si stà qualche minuto in silenzio: a tutte le ore si recita una pre–
ghiera appositamente scritta, più un'avemaria
25 .
Questo non era che uno dei motivi dell'insoddisfazione che andava crescendo a
Torino nei confronti dell'invadente presenza dei fratelli, sospetti per i loro legami con
20
ASCT,
Collezione IX,
n. 199,
Nota degli oggetti di
cui avrebbero bisogno di essere provvedute le scuole
dell'Ill. ma Città di Torino;
LUCIA MARCATO,
Il contributo
dei Fratelli delle Scuole cristiane alla Regia Opera della
Mendicità istruita di Torino
(1829-1848), tesi di laurea in
Storia della pedagogia, Università di Torino, relatore
Remo Fornaca, a.a. 1976-77.
21 DEFENDENTE SACCHI,
Instituti di beneficenza a
Torino,
in «Annali universali di Statistica», voI. XLIV,
1835, pp. 81-131.
22
V.
BERSEZIO,
op. cit,
p.
84.
23
Istruzione ai maestri delle scuole elementari del
15
luglio
1840,
in
Collezione celeri/era
cit.; pp. 716-749.
24
V.
BERSEZIO,
op. cit.,
p.
78.
25
ASCT,
Ragionerie,
1846,
Relazione intorno al pro–
getto
cit. nella nota 17.
181


















