
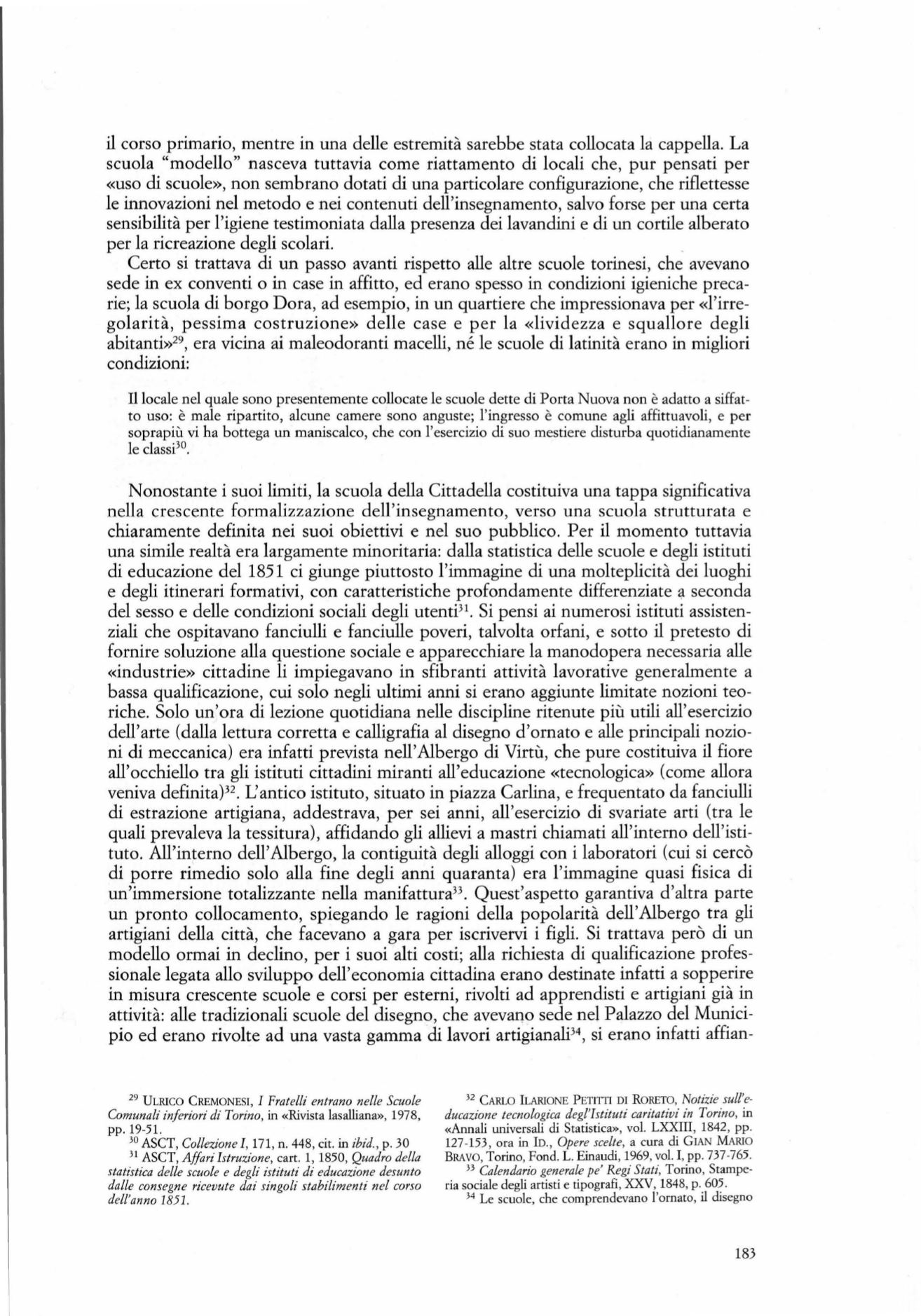
il corso primario, mentre in una delle estremità sarebbe stata collocata la cappella. La
scuola "modello" nasceva tuttavia come riattamento di locali che, pur pensati per
«uso di scuole», non sembrano dotati di una particolare configurazione, che riflettesse
le innovazioni nel metodo e nei contenuti dell'insegnamento, salvo forse per una certa
sensibilità per l'igiene testimoniata dalla presenza dei lavandini e di un cortile alberato
per la ricreazione degli scolari.
.
Certo si trattava di un passo avanti rispetto alle altre scuole torinesi, che avevano
sede in ex conventi o in case in affitto, ed erano spesso in condizioni igieniche preca–
rie; la scuola di borgo Dora, ad esempio, in un quartiere che impressionava per «l'irre–
golarità, pessima costruzione» delle case e per la «lividezza e squallore degli
abitanti»29, era vicina ai maleodoranti macelli, né le scuole di latinità erano in migliori
condizioni:
Il locale nel quale sono presentemente collocate le scuole dette di Porta Nuova non
è
adatto a siffat–
to uso: è male ripartito, alcune camere sono anguste; l'ingresso è comune agli affittuavoli, e per
soprapiù vi ha bottega un maniscalco, che con l'esercizio di suo mestiere disturba quotidianamente
le classi
3o .
Nonostante i suoi limiti, la scuola della Cittadella costituiva una tappa significativa
nella crescente formalizzazione dell'insegnamento, verso una scuola strutturata e
chiaramente definita nei suoi obiettivi e nel suo pubblico. Per il momento tuttavia
una simile realtà era largamente minoritaria: dalla statistica delle scuole e degli istituti
di educazione del 1851 ci giunge piuttosto l'immagine di una molteplicità dei luoghi
e degli itinerari formativi, con caratteristiche profondamente differenziate
l;l
seconda
del sesso e delle condizioni sociali degli utenti3
1 .
Si pensi ai numerosi istituti assisten–
ziali che ospitavano fanciulli e fanciulle poveri, talvolta orfani, e sotto il pretesto di
fornire soluzione alla questione sociale e apparecchiare la manodopera necessaria alle
«industrie» cittadine li impiegavano in sfibranti attività lavorative generalmente a
bassa qualificazione, cui solo negli ultimi anni si erano aggiunte limitate nozioni teo–
riche. Solo un' ora di lezione quotidiana nelle discipline ritenute più utili all' esercizio
dell' arte (dalla lettura corretta e calligrafia al disegno d'ornato e alle principali nozio–
ni di meccanica) era infatti prevista nell'Albergo di Virtù, che pure costituiva il fiore
all' occhiello tra gli istituti cittadini miranti all'educazione «tecnologica» (come allora
veniva definita)32. L'antico istituto, situato in piazza Carlina, e frequentato da fanciulli
di estrazione artigiana, addestrava, per sei anni, all'esercizio di svariate arti (tra le
quali prevaleva la tessitura), affidando gli allievi a mastri chiamati all'interno dell'isti–
tuto. All'interno dell'Albergo, la contiguità degli alloggi con i laboratori (cui si cercò
di porre rimedio solo alla fine degli anni quaranta) era l'immagine quasi fisica di
un'immersione totalizzante nella manifattura
33 •
Quest'aspetto garantiva d'altra parte
un pronto collocamento, spiegando le ragioni della popolarità dell'Albergo tra gli
artigiani della città, che facevano a gara per iscrivervi i figli. Si trattava però di un
modello ormai in declino, per i suoi alti costi; alla richiesta di qualificazione profes–
sionale legata allo sviluppo dell'economia cittadina erano destinate infatti a sopperire
in misura crescente scuole e corsi per esterni, rivolti ad apprendisti e artigiani già in
attività: alle tradizionali scuole del disegno, che aveva110 sede nel Palazzo del Munici–
pio ed erano rivolte ad una vasta gamma di lavori artigianaliJ4, si erano infatti affian-
29
ULRICO CREMONESI,
I Fratelli entrano nelle Scuole
Comunali inf eriori di Torino,
in «Rivista lasalliana»,
1978,
pp.
19-5l.
30
ASCT,
Collezione I,
171,
n.
448,
cito in
ibid.,
p.
30
31
ASCT,
Affari Istruzione,
cart.
1, 1850,
Quadro della
statistica delle scuole e degli istituti di educazione desunto
dalle consegne ricevute dai singoli stabilimenti nel corso
dell'anno 185 1.
32
CARLO ILARIONE PETlm DI RORETO,
Notizie sull'e–
ducazione tecnologica degl'Istituti caritativi in Torino,
in
«Annali universali di Statistica», voI. LXXIII,
1842,
pp.
127-153,
ora in ID.,
Opere scelte,
a cura di GIAN MARIO
BRAVO, Torino, Fond.
L.
Einaudi,
1969,
voI. I, pp.
737-765.
33
Calendario generale pe' Regi Stati,
Torino, Stampe–
ria sociale degli artisti e tipografi, XXV,
1848,
p.
605.
34
Le scuole, che comprendevano l'ornato,
il
disegno
183


















