
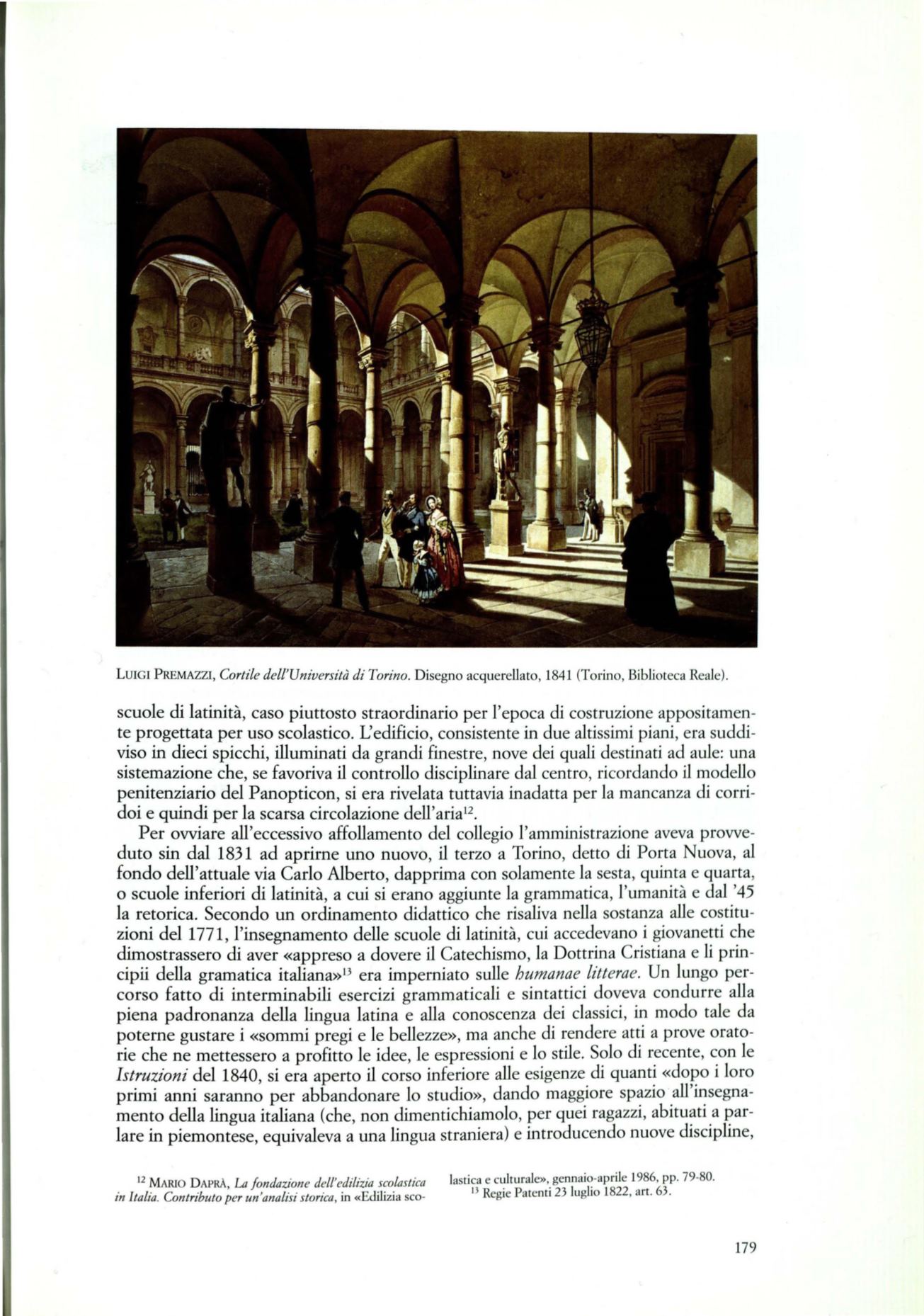
LUIGI PREMAZZI,
Cortile dell'Università di Torino .
Disegno acquerellato,
1841
(Torino, Biblioteca Reale).
scuole di latinità, caso piuttosto straordinario per l'epoca di costruzione appositamen–
te progettata per uso scolastico. L'edificio, consistente in due altissimi piani, era suddi–
viso in dieci spicchi, illuminati da grandi finestre, nove dei quali destinati ad aule: una
sistemazione che, se favoriva il controllo disciplinare dal centro, ricordando il modello
penitenziario del Panopticon, si era rivelata tuttavia inadatta per la mancanza di corri–
doi e quindi per la scarsa circolazione dell' aria
12.
Per ovviare all'eccessivo affollamento del collegio l'amministrazione aveva provve–
duto sin dal 1831 ad aprirne uno nuovo, il terzo a Torino, detto di Porta Nuova, al
fondo dell' attuale via Carlo Alberto, dapprima con solamente la sesta, quinta e quarta,
o scuole inferiori di latinità, a cui si erano aggiunte la grammatica, l'umanità e dal '45
la retorica. Secondo un ordinamento didattico che risaliva nella sostanza alle costitu–
zioni del 1771, l'insegnamento delle scuole di latinità, cui accedevano i giovanetti che
dimostrassero di aver «appreso a dovere il Catechismo, la Dottrina Cristiana e li prin–
cipii della gramatica italiana»13 era imperniato sulle
humanae litterae.
Un lungo per–
corso fatto di interminabili esercizi grammaticali e sintattici doveva condurre alla
piena padronanza della lingua latina e alla conoscenza dei classici, in modo tale da
poterne gustare i «sommi pregi e le bellezze», ma anche di rendere atti a prove orato–
rie che ne mettessero a profitto le idee, le espressioni e lo stile. Solo di recente, con le
Istruzioni
del 1840, si era aperto il corso inferiore alle esigenze di quanti «dopo i loro
primi anni saranno per abbandonare lo studio», dando maggiore spazio all'insegna–
mento della lingua italiana (che, non dimentichiamolo, per quei ragazzi, abituati a par–
lare in piemontese, equivaleva a una lingua straniera) e introducendo nuove discipline,
12
MARIo
DAPRÀ,
La
fondazione dell'edilizia scolastica
in Italia. Contributo per un'analisi storica,
in
«Edilizia sco-
lastica e cuJturale», gennaio-aprile 1986, pp. 79-80.
13
Regie Patenti 23 luglio 1822. art. 63.
179


















