
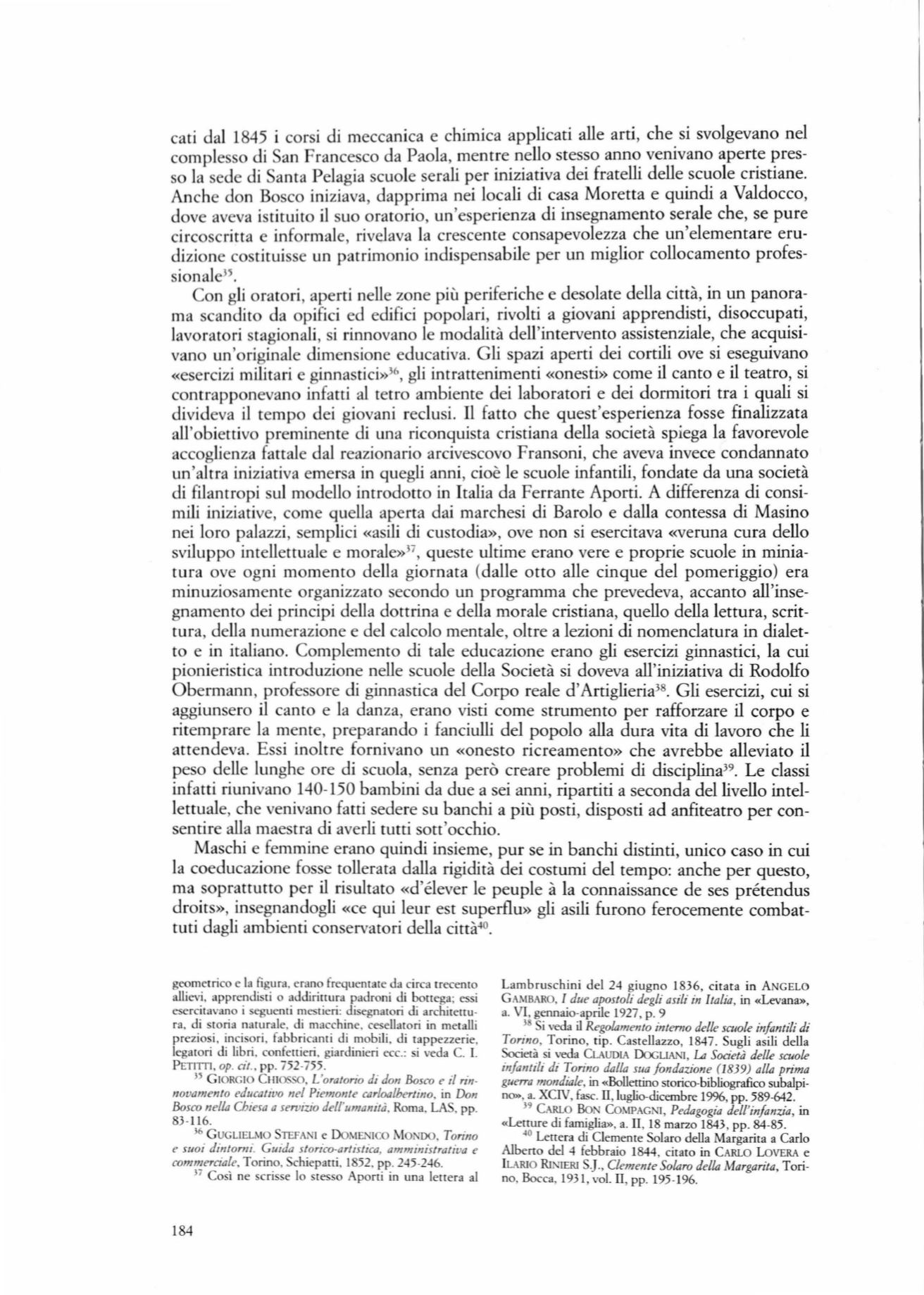
cati dal 1845 i corsi di meccanica e chimica applicati alle arti, che si svolgevano nel
complesso di San Francesco da Paola, mentre nello stesso anno venivano aperte pres–
so la sede di anta Pelagia scuole serali per iniziativa dei fratelli delle scuole cristiane.
Anch don Bosco iniziava, dapprima nei locali di casa Moretta e quindi a Valdocco,
d v aveva i tituit il suo oratorio, un 'esperienza di insegnamento serale che, se pure
circoscritta e informale, rivelava la crescente consapevolezza che un'elementare eru–
dizion co tituisse un patrimonio indispensabile per un miglior collocamento profes–
sional
3'.
on gli oratori, aperti nelle zone più periferiche e desolate della città, in un panora–
ma scandit da opifici ed edifici popolari, rivolti a giovani apprendisti, disoccupati,
lavoratori stagionali , si rinnovano le modalità dell'intervento assistenziale, che acquisi–
vano un 'originale dimensione educativa. Gli spazi aperti dei cortili ove si eseguivano
«esercizi militari e ginnas tici»36, gli intrattenimenti «onesti» come
il
canto e
il
teatro, si
contrapponevano infatti al tetro ambiente dei laboratori e dei dormitori tra i quali si
divideva
il
tempo dei giovani reclusi. Il fatto che quest'esperienza fosse finalizzata
all 'obiettivo preminente di una riconquista cristiana della società spiega la favorevole
accoglienza fattale dal reazionario arcivescovo Fransoni, che aveva invece condannato
un 'altra iniziativa emersa in quegli anni, cioè le scuole infantili, fondate da una società
di filantropi sul modello introdotto in Italia da Ferrante Aporti. A differenza di consi–
mili iniziative, come qu lla aperta dai marchesi di Barolo e dalla contessa
di
Masino
nei loro palazzi , emplici «asili di custodia», ove non si esercitava «veruna cura dello
viluppo intellettuale e morale»37, queste ultime erano vere e proprie scuole in minia–
tura ove ogni momento della giornata (dalle otto alle cinque del pomeriggio) era
minuziosam nte organizzato secondo un programma che prevedeva, accanto all'inse–
gnamento dei principi della dottrina e della morale cristiana, quello della lettura, scrit–
tura, della numerazione e del calcolo mentale, oltre a lezioni di nomenclatura in dialet–
to e in italiano. Complemento di tale educazione erano gli esercizi ginnastici, la cui
pionieristica introduzione nelle scuole della Società si doveva all'iniziativa di Rodolfo
bermann , profe sore di ginnastica del Corpo reale d'Artiglieria
38 •
Gli esercizi, cui si
aggiuns ro il canto e la danza, erano visti come strumento per rafforzare
il
corpo e
ritemprare la mente, preparando i fanciulli del popolo alla dura vita di lavoro che li
attendeva . E si inoltr fornivano un «onesto ricreamento» che avrebbe alleviato
il
p o delle lungh ore di scuola, senza però creare problemi
di
disciplina
39 •
Le classi
infatti riunivano 140-150 bambini da due a sei anni, ripartiti a seconda del livello intel–
lettual , che venivano fatti sedere su banchi a più posti, disposti ad anfiteatro per con-
entire alla mae tra di averli tutti sott'occhio.
Ma chi e femmine l'ano quindi insieme, pur se in banchi distinti, unico caso in cui
la co ducazione fo se tollerata dalla rigidità dei costumi del tempo: anche per questo,
ma oprattutto per il ri ultato «d'élever le peuple à la connaissance de ses prétendus
droits», in gnandogli «ce qui leur est superflu» gli asili furono ferocemente combat–
tuti dagli ambi nti con ervatori della città
40 .
geometrico e la figura, erano frequentate da circa trecento
allievi , appren li ti o addirittura padroni di bo ttega; essi
esercitavano i seguenù mestieri : d isegn ato ri di architettu–
ra, di storia natu rale, d i macchine, ce ellatori in metalli
preziosi, incisori , fabbrica nti di mobili, di tappezzerie,
legatori di libri, confetlieri , giardinieri ece.: si veda .
I.
PETITII,
op. cit.,
pp. 752-755.
n GIORG IO CHIOSSO,
L'oratorio di dOI/ Bosco e il rin–
novamel/to educativo nel Piemol/te carloalbertino,
in
Don
Bosco nello Chiesa a servizio dell'umanità,
Roma, LAS, pp.
83-116.
}6
G UG LI ELMO TEFA I e DOME ICO MONDO,
Torino
e suoi dintorni. Guida storico-artistica, amministrativa e
commerciale,
Torino , chiepatti, 1852, pp. 245 -246.
}ì
Così ne sc risse lo stesso Aporti in una lettera al
184
Lambruschini del 24 giugno 1836, citata in ANGELO
G AMBARO,
I due apostoli degli asili in Italia ,
in «Levana»,
a. VI, gennaio-aprile 1927, p. 9
}S
Si veda il
Regolomento interno delle scuole infantili di
Torino,
Torino, tip o Castellazzo, 1847. Sugli asili della
Società si veda CLAUDIA DoGLIANI,
La
Società delle scuole
infantili di Torino dallo sua fonda zione
(1839)
allo prima
gue" a mondiale,
in «Bollettino storico-bibliografico subalpi–
no», a. XCIV, fase. II, luglio-dicembre 1996, pp. 589-642.
}9
CARLO BON COMPAGNI,
Pedagogia dell'infanzia,
in
«Letture di famiglia», a. II, 18 marzo 1843 , pp. 84-85.
40
Lettera di Clemente Solaro della Margarita a Carlo
Alberto del 4 febb raio 1844, citato in CARLO LOVERA e
ILARIO fu IERI S.J.,
Clemente Soloro dello Margarita,
Tori–
no, Bocca, 193 1, voI. II, pp. 195 -196.


















