
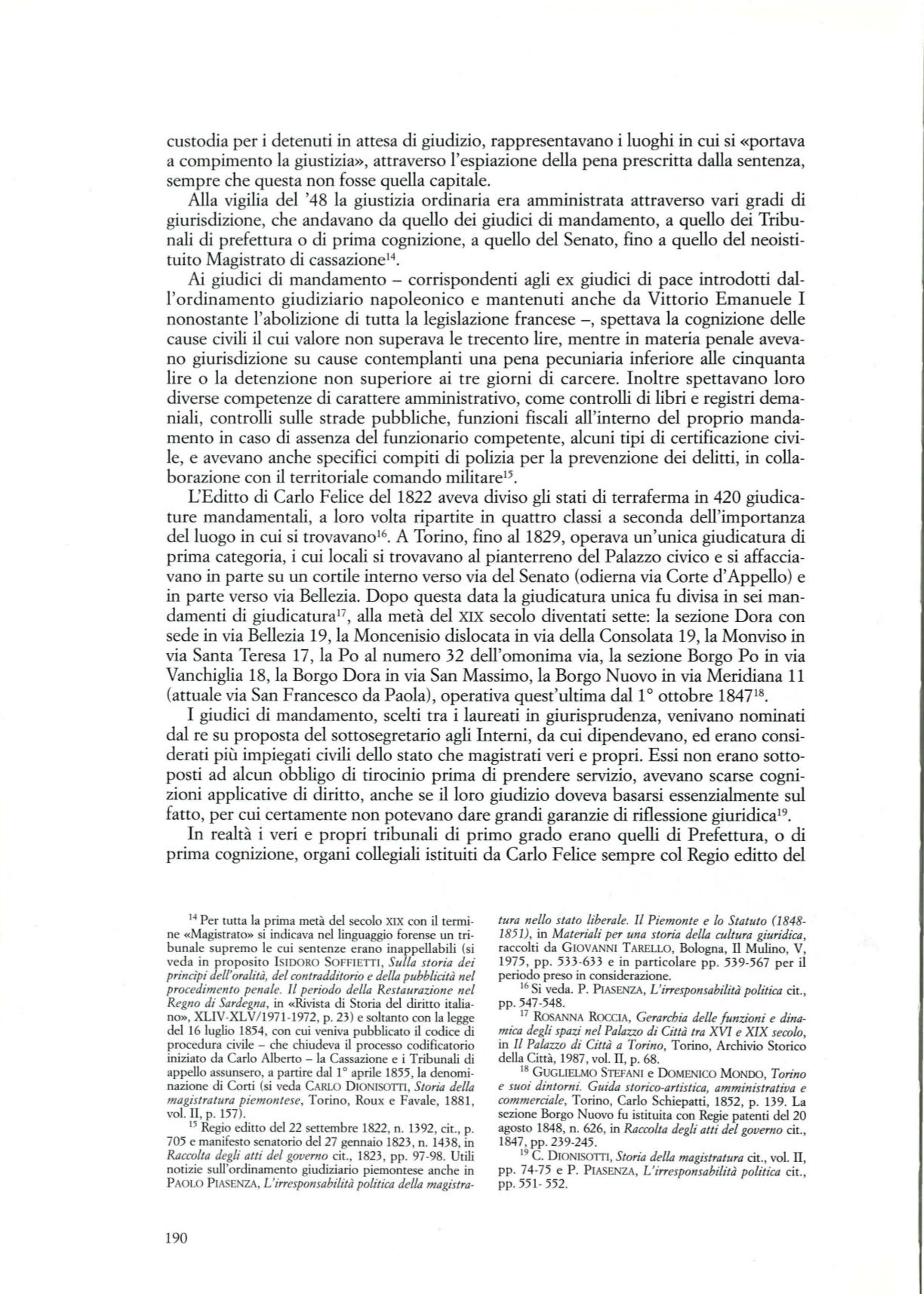
custodia per i detenuti in attesa di giudizio, rappresentavano i luoghi in cui si «portava
a compimento la giustizia», attraverso l'espiazione della pena prescritta dalla sentenza,
sempre che questa non fosse quella capitale.
Alla vigilia del '48 la giustizia ordinaria era amministrata attraverso vari gradi di
giurisdizione, che andavano da quello dei giudici di mandamento, a quello dei Tribu–
nali di prefettura o di prima cognizione, a quello del Senato, fino a quello del neoisti–
tuito Magistrato di cassazione
'4.
Ai giudici di mandamento - corrispondenti agli ex giudici di pace introdotti dal–
l'ordinamento giudiziario napoleonico e mantenuti anche da Vittorio Emanuele I
nonostante l'abolizione di tutta la legislazione francese - , spettava la cognizione delle
cause civili il cui valore non superava le trecento lire, mentre in materia penale aveva–
no giurisdizione su cause contemplanti una pena pecuniaria inferiore alle cinquanta
lire o la detenzione non superiore ai tre giorni di carcere. Inoltre spettavano loro
diverse competenze di carattere amministrativo, come controlli di libri e registri dema–
niali, controlli sulle strade pubbliche, funzioni fiscali all'interno del proprio manda–
mento in caso di assenza del funzionario competente, alcuni tipi di certificazione civi–
le, e avevano anche specifici compiti di polizia per la prevenzione dei delitti, in colla–
borazione con il territoriale comando militare
15 •
L'Editto di Carlo Felice del 1822 aveva diviso gli stati di terraferma in 420 giudica–
ture mandamentali, a loro volta ripartite in quattro classi a seconda dell'importanza
del luogo in cui si trovavano
16 .
A Torino, fino al 1829, operava un'unica giudicatura di
prima categoria, i cui locali si trovavano al pianterreno del Palazzo civico e si affaccia–
vano in parte su un cortile interno verso via del Senato (odierna via Corte d'Appello) e
in parte verso via Bellezia. Dopo questa data la giudicatura unica fu divisa in sei man–
damenti di giudicatura
l7 ,
alla metà del
XIX
secolo diventati sette: la sezione Dora con
sede in via Bellezia 19, la Moncenisio dislocata in via della Consolata 19, la Monviso in
via Santa Teresa 17, la Po al numero 32 dell'omonima via, la sezione Borgo Po in via
Vanchiglia 18, la Borgo Dora in via San Massimo, la Borgo Nuovo in via Meridiana Il
(attuale via San Francesco da Paola), operativa quest'ultima dallo ottobre 1847
18 •
I giudici di mandamento, scelti tra i laureati in giurisprudenza, venivano nominati
dal re su proposta del sottosegretario agli Interni, da cui dipendevano, ed erano consi–
derati più impiegati civili dello stato che magistrati veri e propri. Essi non erano sotto–
posti ad alcun obbligo di tirocinio prima di prendere servizio, avevano scarse cogni–
zioni applicative di diritto, anche se il loro giudizio doveva basarsi essenzialmente sul
fatto , per cui certamente non potevano dare grandi garanzie di riflessione giuridica
l9 .
In realtà i veri e propri tribunali di primo grado erano quelli di Prefettura, o di
prima cognizione, organi collegiali istituiti da Carlo Felice sempre col Regio editto del
14
Per tutta la prima metà del secolo XIX con
il
termi–
ne «Magistrato» si indicava nel linguaggio forense un tri–
bunale supremo le cui sentenze erano inappellabili (si
veda in proposito ISIDORO SOFFIETTI,
Sulla storia dei
princiPi dell'oralità, del contradditorio e della pubblicità nel
procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel
Regno di Sardegna,
in
«Rivista di Storia del diritto italia–
no», XLIV-XLV/ 1971-1972, p. 23) e soltanto con la legge
del 16 luglio 1854, con cui veniva pubblicato il codice di
procedura civile - che chiudeva il processo codificatorio
iniziato da Carlo Alberto - la Cassazione e i Tribunali di
appello assunsero, a partire dall Oaprile 1855 , la denomi–
nazione di Corti (si veda CARLO DI0NISOTT1,
Storia della
magistratura piemontese,
Torino, Roux e Favale, 1881 ,
voI. II, p. 157).
15
Regio editto del 22 settembre 1822, n. 1392, cit., p.
705 e manifesto senatorio del 27 gennaio 1823, n. 1438, in
Raccolta degli atti del governo
cit., 1823 , pp. 97-98. Utili
notizie sull'ordinamento giudiziario piemontese anche in
PAOLO PlASENZA,
L'irresponsabilità politica della magistra-
190
tura nello stato liberale. Il Piemonte e lo Statuto (1848-
1851), in
Materiali per una storia della cultura giuridica,
raccolti da GIOVANNI TARELLO, Bologna, Il Mulino, V,
1975 , pp. 533-633 e in particolare pp. 539-567 per il
periodo preso in considerazione.
16
Si veda. P. PIASENZA,
L'irresponsabilità politica
cit.,
pp. 547-548.
17
ROSANNA ROCCIA,
Gerarchia delle funzioni e dina–
mica degli spazi nel Palazzo di Città tra XVI e XIX secolo,
in
Il Palazzo di Città a Torino,
Torino, Archivio Storico
della Città, 1987, voLlI, p. 68.
18
GUGLIELMO STEFANI e DOMENICO MONDO,
Torino
e suoi dintorni. Guida storico-artistica, amministrativa e
commerciale,
Torino, Carlo Schiepatti, 1852, p. 139. La
sezione Borgo Nuovo
fu
istituita con Regie patenti del 20
agosto 1848, n. 626, in
Raccolta degli atti del governo
cit.,
1847, pp. 239-245.
19
C.
DIONISOTTI,
Storia della magistratura
cit., voI. II,
pp. 74-75 e P. PIASENZA,
L'irresponsabilità politica
ci
t. ,
pp. 551 - 552.


















