
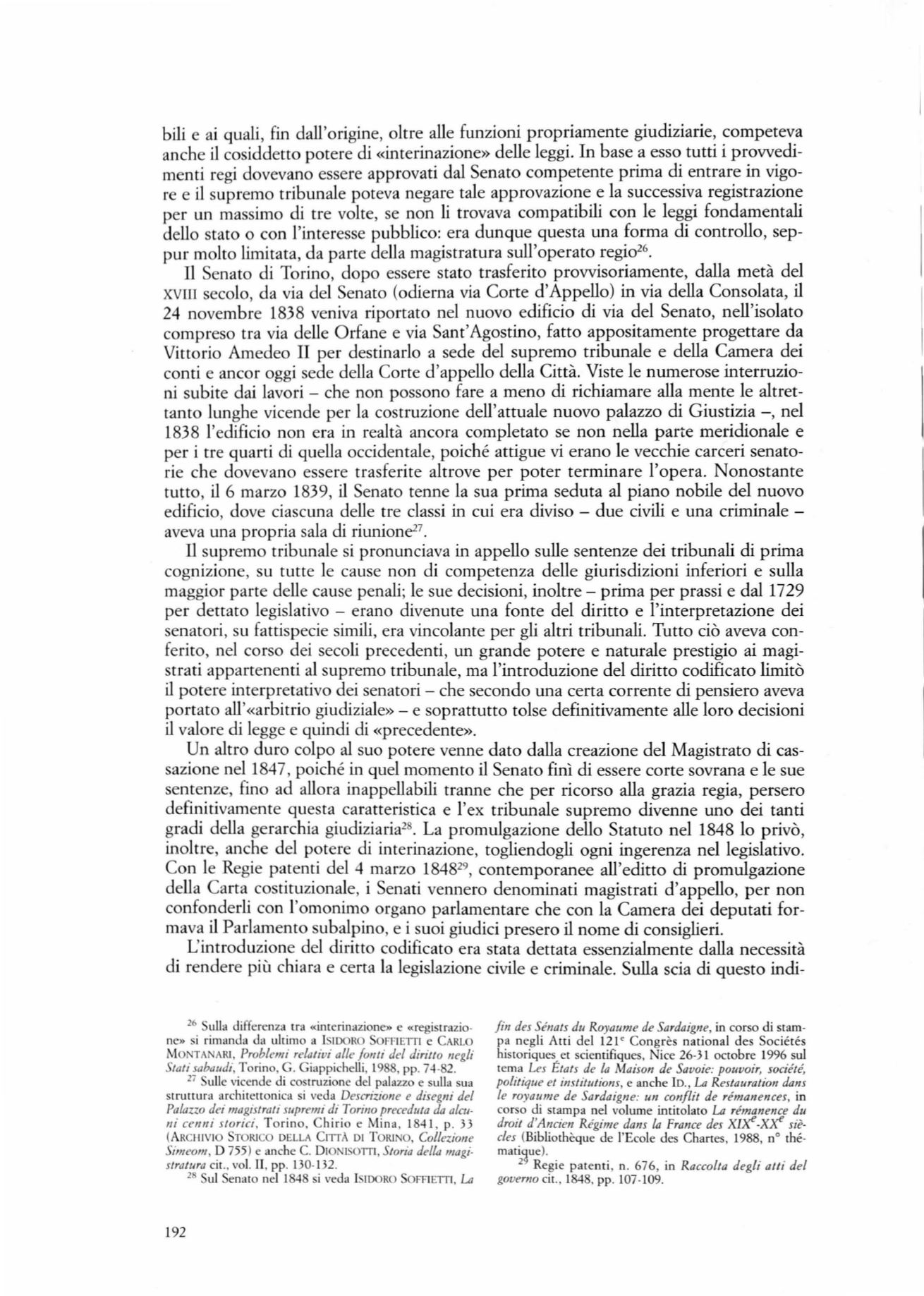
bili e ai quali, fin dall 'origine, oltre alle funzioni propriamente giudiziarie, competeva
anche
il
cosiddetto potere di «interinazione» delle leggi. In base a esso tutti i provvedi–
menti regi dovevano essere approvati dal Senato competente prima di entrare in vigo–
re e il supremo tribunale poteva negare tale approvazione e la successiva registrazione
per un massimo di tre volte, se non li trovava compatibili con le leggi fondamentali
dello stato o con l'interesse pubblico: era dunque questa una forma di controllo, sep–
pur molto limitata, da parte della magistratura sull'operato regio
26
•
Il Senato di Torino, dopo essere stato trasferito provvisoriamente, dalla metà del
xvm
secolo, da via del Senato (odierna via Corte d'Appello) in via della Consolata, il
24 novembre 1838 veniva riportato nel nuovo edificio di via del Senato, nell'isolato
compreso tra via delle Orfane e via Sant'Agostino, fatto appositamente progettare da
Vittorio Amedeo II per destinarlo a sede del supremo tribunale e della Camera dei
conti e ancor oggi sede della Corte d 'appello della Città. Viste le numerose interruzio–
ni subite dai lavori - che non possono fare a meno di richiamare alla mente le altret–
tanto lunghe vicende per la costruzione dell'attuale nuovo palazzo di Giustizia - , nel
1838 l'edificio non era in realtà ancora completato se non nella parte meridionale e
per i tre quarti di quella occidentale, poiché attigue vi erano le vecchie carceri senato–
rie che dovevano essere trasferite altrove per poter terminare l'opera. Nonostante
tutto, il 6 marzo 1839, il Senato tenne la sua prima seduta al piano nobile del nuovo
edificio, dove ciascuna delle tre classi in cui era diviso - due civili e una criminale -
aveva una propria sala di riunione
27 .
Il supremo tribunale si pronunciava in appello sulle sentenze dei tribunali di prima
cognizione, su tutte le cause non di competenza delle giurisdizioni inferiori e sulla
maggior parte delle cause penali; le sue decisioni, inoltre - prima per prassi e dal 1729
per dettato legislativo - erano divenute una fonte del diritto e l'interpretazione dei
senatori, su fattispecie simili, era vincolante per gli altri tribunali. Tutto ciò aveva con–
ferito, nel corso dei secoli precedenti, un grande potere e naturale prestigio ai magi–
strati appartenenti al supremo tribunale, ma l'introduzione del diritto codificato limitò
il
potere interpretativo dei senatori - che secondo una certa corrente di pensiero aveva
portato all'«arbitrio giudiziale» - e soprattutto tolse definitivamente alle loro decisioni
il
valore di legge e quindi di «precedente».
Un altro duro colpo al suo potere venne dato dalla creazione del Magistrato di cas-
azion nel 1847 , poiché in quel momento il Senato finì di essere corte sovrana e le sue
sent nze, fino ad allora inappellabili tranne che per ricorso alla grazia regia, persero
definitivam nte questa caratteristica e l'ex tribunale supremo divenne uno dei tanti
gradi della gerarchia gi udizia ria
28 •
La promulgazione dello Statuto nel 1848 lo privò,
inoltr , anche del potere di interinazione, togliendogli ogni ingerenza nel legislativo.
on le Regi patenti del 4 marzo 1848
29 ,
contemporanee all'editto di promulgazione
d lla arta co tituzionale, i Senati vennero denominati magistrati d'appello, per non
confonderli con l omonimo organo parlamentare che con la Camera dei deputati for–
mava
il
Parlamento subalpino, e i suoi giudici presero il nome di consiglieri.
L'introduzion del diritto codificato era stata dettata essenzialmente dalla necessità
di r ndere più chiara e certa la legislazione civile e criminale. Sulla scia di questo indi-
26
ulla differenza Ira «inlerinazione» c «registrazio–
ne» si rimanda da ultimo a l 'IDORO OFFIETrI e CARLO
Ma TA ARI,
Problemi relalivi alle fOllli del dirillo lIegli
51ali saba/ldi,
Torino, G . G iappicheUi, 19 8, pp. 74-82.
lì
ulle vicende di costruzione del palazzo e sulla sua
struttura architellonica si veda
Descrizione e disegni del
Palazzo dei magislrali mpremi di Torino precedula da alcu–
Ili cellni slorici,
To rin o , C hirio e lin a, 1841 , p. 33
(ARCHI IO STORI O DELLA CITrA DI TORI O,
Collezione
5imeom,
D 755) e an che
C.
DIO l a Tri,
510ria della magi–
slralura
ciI., voI.
n,
pp. 130-132.
28
Sul Senato nel 1848 si veda ISIDORO SOFFIETrI,
Lo
192
fin des 5énats du Royaume de 5ardaigne,
in corso di stam–
pa negli Atti del 121
e
Congrès national des Sociétés
historiques et scientifiques, Nice 26-31 octobre 1996 sul
tema
Les Élats de la Maison de 5avoie: pouvoir, société,
politique et imtitutiom,
e anche ID.,
Lo
Restauration dans
le royaume de 5ardaigne: un conflit de rémanences,
in
corso di stampa nel volume intitolato
Lo
rémanence du
droit d'Ancien Régime dans la France des Xlx!-Xx! siè–
cles
(Bibliothèque de l'Ecoie des Chartes, 1988, nO thé–
mati~ue) .
2
Regie patenti , n. 676, in
Raccolta degli atti del
governo
ciI. , 1848, pp. 107-109.


















