
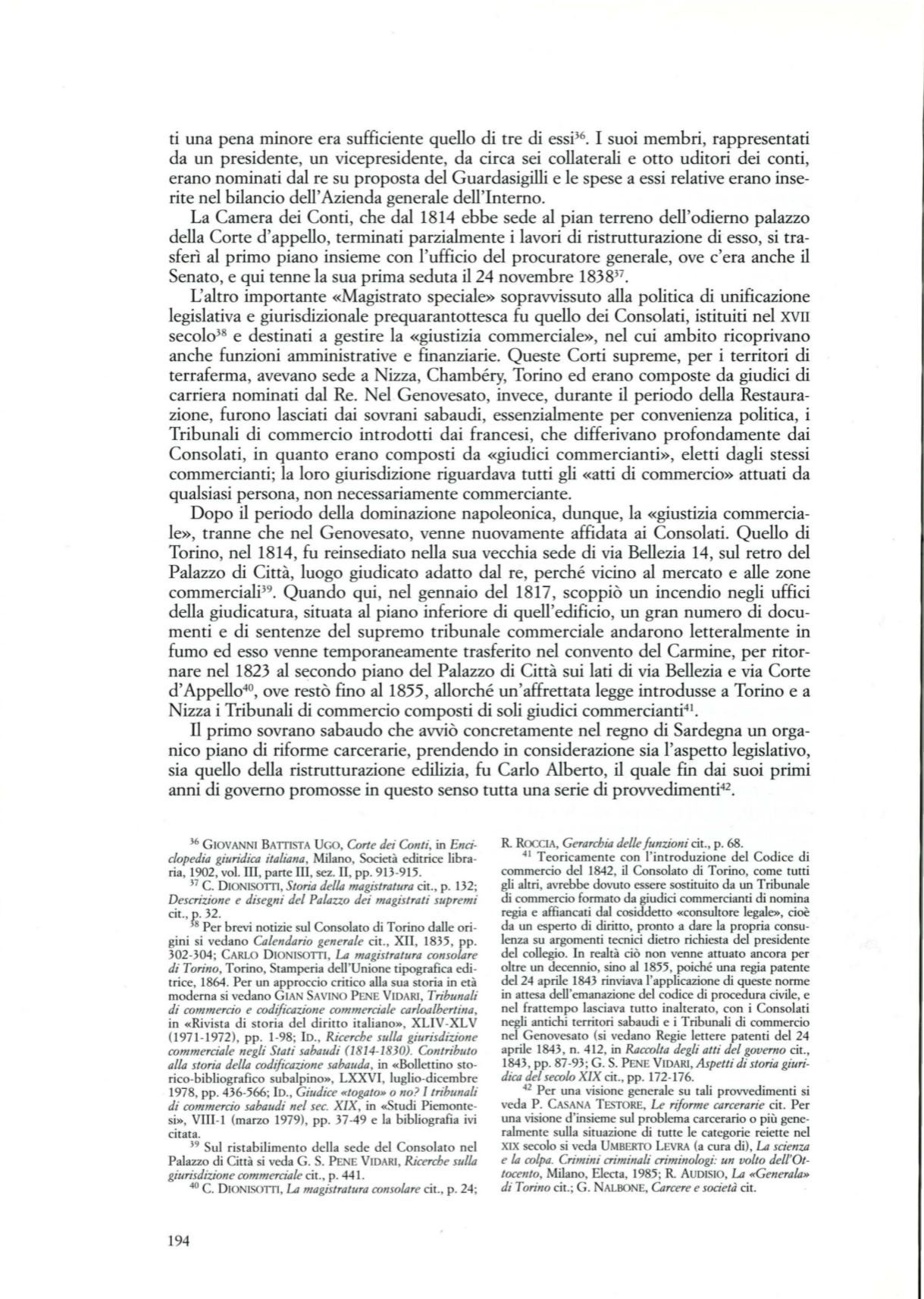
ti una pena minore era sufficiente quello di tre di essi
36 •
I suoi membri, rappresentati
da un presidente, un vicepresidente, da circa sei collaterali e otto uditori dei conti,
erano nominati dal re su proposta del Guardasigilli e le spese a essi relative erano inse–
rite nel bilancio dell'Azienda generale dell'Interno.
La Camera dei Conti, che dal 1814 ebbe sede al pian terreno dell'odierno palazzo
della Corte d'appello, terminati parzialmente i lavori di ristrutturazione di esso, si tra–
sferì al primo piano insieme con l'ufficio del procuratore generale, ove c'era anche il
Senato, e qui tenne la sua prima seduta il 24 novembre 1838
37 .
L'altro importante «Magistrato speciale» sopravvissuto alla politica di unificazione
legislativa e giurisdizionale prequarantottesca fu quello dei Consolati, istituiti nel
XVII
secol0
38
e destinati a gestire la «giustizia commerciale», nel cui ambito ricoprivano
anche funzioni amministrative e finanziarie. Queste Corti supreme, per i territori di
terraferma, avevano sede a Nizza, Chambéry, Torino ed erano composte da giudici di
carriera nominati dal Re. Nel Genovesato, invece, durante il periodo della Restaura–
zione, furono lasciati dai sovrani sabaudi, essenzialmente per convenienza politica, i
Tribunali di commercio introdotti dai francesi, che differivano profondamente dai
Consolati, in quanto erano composti da «giudici commercianti», eletti dagli stessi
commercianti; la loro giurisdizione riguardava tutti gli «atti di commercio» attuati da
qualsiasi persona, non necessariamente commerciante.
Dopo il periodo della dominazione napoleonica, dunque, la «giustizia commercia–
le», tranne che nel Genovesato, venne nuovamente affidata ai Consolati. Quello di
Torino, nel 1814, fu reinsediato nella sua vecchia sede di via Bellezia 14, sul retro del
Palazzo di Città, luogo giudicato adatto dal re, perché vicino al mercato e alle zone
commerciali
39 •
Quando qui, nel gennaio del 1817 , scoppiò un incendio negli uffici
della giudicatura, situata al piano inferiore di quell 'edificio, un gran numero di docu–
menti e di sentenze del supremo tribunale commerciale andarono letteralmente in
fumo ed esso venne temporaneamente trasferito nel convento del Carmine, per ritor–
nare nel 1823 al secondo piano del Palazzo di Città sui lati di via Bellezia e via Corte
d'Appell0
40 ,
ove restò fino al 1855 , allorché un'affrettata legge introdusse a Torino e a
Nizza i Tribunali di commercio composti di soli giudici commercianti
41 •
Il primo sovrano sabaudo che avviò concretamente nel regno di Sardegna un orga–
nico piano di riforme carcerarie, prendendo in considerazione sia l'aspetto legislativo,
sia quello della ristrutturazione edilizia, fu Carlo Alberto, il quale fin dai suoi primi
anni di governo promosse in questo senso tutta una serie di provvedimenti
42 .
36
GIOVANNI BATTISTA UGO,
Corte dei Conti,
in
Enci–
clopedia giuridica italiana,
Milano, Società editrice libra–
ria, 1902, voI. III, parte III, sez. II, pp. 913 -915.
37
C.
DIONISOTTI,
Storia della magistratura
cit., p. 132;
Descrizione e disegni del Palazzo dei magistrati supremi
cit. '
fa'
32.
8
Per brevi notizie sul Consolato di Torino dalle ori–
gini si vedano
Calendario generale
cit., XII, 1835, pp.
302 -304; CARLO DION ISOTTI,
La magistratura consolare
di Torino,
Torino, Stamperia dell'Unione tipografica edi–
trice, 1864. Per un approccio critico alla sua storia in età
moderna si vedano GIAN SAVINO PENE VIDARJ,
Tribunali
di commercio e codificazione commerciale carloalbertina,
in «Rivista di sto ria del di ritto italiano», XLIV-XLV
(197 1-1972), pp. 1-98; ID.,
Ricerche sulla giurisdizione
commerciale negli Stati sabaudi (18 14- 1830). Contributo
alla storia della codzficazione sabauda,
in «Bollettino sto–
rico-bibliografico subalpino», LXXVI, luglio-dicembre
1978, pp. 436-566; ID. ,
Giudice «togato» o no? I tribunali
di commercio sabaudi nel sec. X IX,
in «Studi Piemonte–
si», VIII-1 (marzo 1979), pp. 37-49 e la bibliografia ivi
citata.
39
Sul ristabilimento dell a sede del Consolato nel
Palazzo di Città si veda G. S. PENE VIDARI,
Ricerche sulla
giurisdizione commerciale
cit., p . 441.
40
C.
DIONISOTTI,
La magistratura consolare
cit., p. 24;
194
R.
ROCCIA,
Gerarchia delle funzioni
cit., p. 68.
41
Teoricamente con l'introduzione del Codice di
commercio del 1842, il Consolato di Torino, come tutti
gli altri, avrebbe dovuto essere sostituito da un T ribunale
di commercio formato da giudici commercianti di nomina
regia e affiancati dal cosiddetto «consultore legale», cioè
da un esperto di diritto, pronto a dare la propria consu–
lenza su argomenti tecnici dietro richiesta del presidente
del collegio. In realtà ciò non venne attuato ancora per
oltre un decennio, sino al 1855, poiché una regia patente
del 24 aprile 1843 rinviava l'applicazione di queste norme
in attesa dell'emanazione del codice di procedura civile, e
nel frattempo lasciava tutto inalterato, con i Consolati
negli antichi territori sabaudi e i Tribunali
di
commercio
nel Genovesato (si vedano Regie lettere patenti del 24
aprile 1843 , n. 412, in
Raccolta degli atti del governo
cit.,
1843, pp. 87-93; G. S. PENE VIDARI,
A spetti di storia giuri–
dica del secolo XIX
cit., pp. 172-176.
42
Per una visione generale su tali provvedimenti si
veda P . CASANA TESTORE,
Le riforme carcerarie
citoPer
una visione d'insieme sul p roblema carcerario o più gene–
ralmente sulla situazione di tutte le categorie reiette nel
XIX
secolo si veda UMBERTO LEVRA (a cura di),
La
scienza
e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ot–
tocento,
Milano, Electa, 1985;
R.
AUDISIO,
La
«Generala»
di Torino
cit.; G. NALBONE,
Carcere e società
cit.


















