
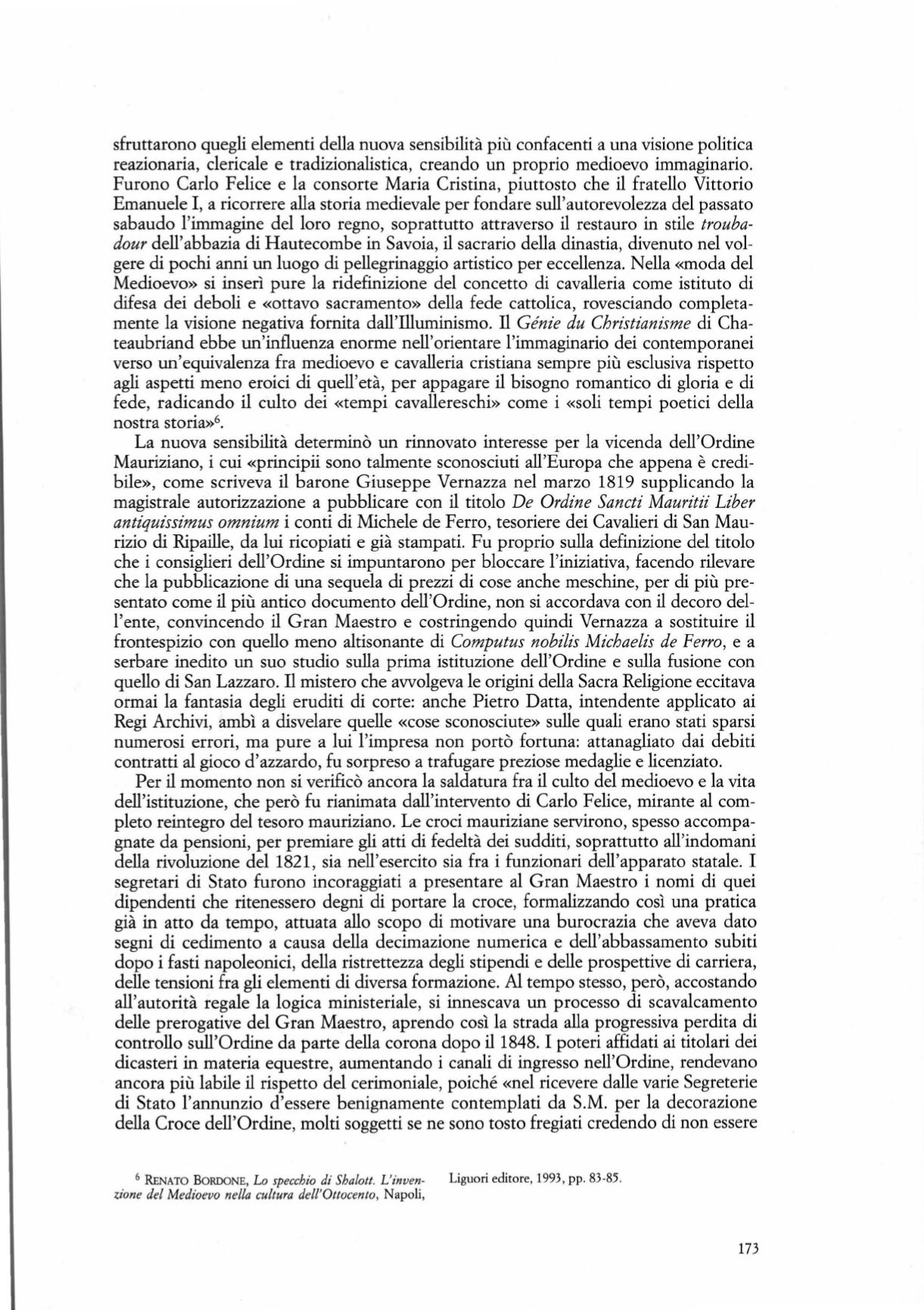
sfruttarono quegli elementi della nuova sensibilità più confacenti a una visione politica
reazionaria, clericale e tradizionalistica, creando un proprio medioevo immaginario.
Furono Carlo Felice e la consorte Maria Cristina, piuttosto che il fratello Vittorio
Emanuele I, a ricorrere alla storia medievale per fondare sull'autorevolezza del passato
sabaudo l'immagine del loro regno, soprattutto attraverso il restauro in stile
trouba–
dour
dell'abbazia di Hautecombe in Savoia, il sacrario della dinastia, divenuto nel vol–
gere di pochi anni un luogo di pellegrinaggio artistico per eccellenza. Nella «moda del
Medioevo» si inserì pure la ridefinizione del concetto di cavalleria come istituto di
difesa dei deboli e «ottavo sacramento» della fede cattolica, rovesciando completa–
mente la visione negativa fornita dall'Illuminismo. Il
Génie du Christianisme
di Cha–
teaubriand ebbe un'influenza enorme nell'orientare l'immaginario dei contemporanei
verso un' equivalenza fra medioevo e cavalleria cristiana sempre più esclusiva rispetto
agli aspetti meno eroici di quell'età, per appagare il bisogno romantico di gloria e di
fede, radicando
il
culto dei «tempi cavallereschi» come i «soli tempi poetici della
nostra storia»6.
La nuova sensibilità determinò un rinnovato interesse per la vicenda dell'Ordine
Mauriziano, i cui «principii sono talmente sconosciuti all'Europa che appena
è
credi–
bile», come scriveva
il
barone Giuseppe Vernazza nel marzo 1819 supplicando la
magistrale autorizzazione a pubblicare con il titolo
De Ordine Sancti Mauritii Liber
antiquissimus omnium
i conti di Michele de Ferro, tesoriere dei Cavalieri di San Mau–
rizio di Ripaille, da lui ricopiati e già stampati. Fu proprio sulla definizione del titolo
che i consiglieri dell'Ordine si impuntarono per bloccare l'iniziativa, facendo rilevare
che la pubblicazione di una sequela di prezzi di cose anche meschine, per di più pre–
sentato come il più antico documento dell'Ordine, non si accordava con il decoro del–
l'ente, convincendo il Gran Maestro e costringendo quindi Vernazza a sostituire il
frontespizio con quello meno altisonante di
Computus nobilis Michaelis de Ferro,
e a
serbare inedito un suo studio sulla prima istituzione dell'Ordine e sulla fusione con
quello di San Lazzaro. Il mistero che avvolgeva le origini della Sacra Religione eccitava
ormai la fantasia degli eruditi di corte: anche Pietro Datta, intendente applicato ai
Regi Archivi, ambì a disvelare quelle «cose sconosciute» sulle quali erano stati sparsi
numerosi errori, ma pure a lui l'impresa non portò fortuna: attanagliato dai debiti
contratti al gioco d'azzardo, fu sorpreso a trafugare preziose medaglie e licenziato.
Per il momento non si verificò ancora la saldatura fra il culto del medioevo e la vita
dell'istituzione, che però fu rianimata dall'intervento di Carlo Felice, mirante al com–
pleto reintegro del tesoro mauriziano. Le croci mauriziane servirono, spesso accompa–
gnate da pensioni, per premiare gli atti di fedeltà dei sudditi, soprattutto all'indomani
della rivoluzione del 1821, sia nell'esercito sia fra i funzionari dell'apparato statale. I
segretari di Stato furono incoraggiati a presentare al Gran Maestro i nomi di quei
dipendenti che ritenessero degni di portare la croce, formalizzando così una pratica
già in atto da tempo, attuata allo scopo di motivare una burocrazia che aveva dato
segni di cedimento a causa della decimazione numerica e dell' abbassamento subiti
dopo i fasti napoleonici, della ristrettezza degli stipendi e delle prospettive di carriera,
delle tensioni fra gli elementi di diversa formazione. Al tempo stesso, però, accostando
all' autorità regale la logica ministeriale, si innescava un processo di scavalcamento
delle prerogative del Gran Maestro, aprendo così la strada alla progressiva perdita di
controllo sull'Ordine da parte della corona dopo il 1848. I poteri affidati ai titolari dei
dicasteri in materia equestre, aumentando i canali di ingresso nell'Ordine, rendevano
ancora più labile il rispetto del cerimoniale, poiché «nel ricevere dalle varie Segreterie
di Stato l'annunzio d'essere benignamente contemplati da S.M. per la decorazione
della Croce dell'Ordine, molti soggetti se ne sono tosto fregiati credendo di non essere
6 RENATO BORDONE,
Lo specchio di Shalott. L'inven-
Liguori editore,
1993,
pp.
83-85.
zione del Medioevo nella cultura dell'Ottocento,
Napoli,
173


















