
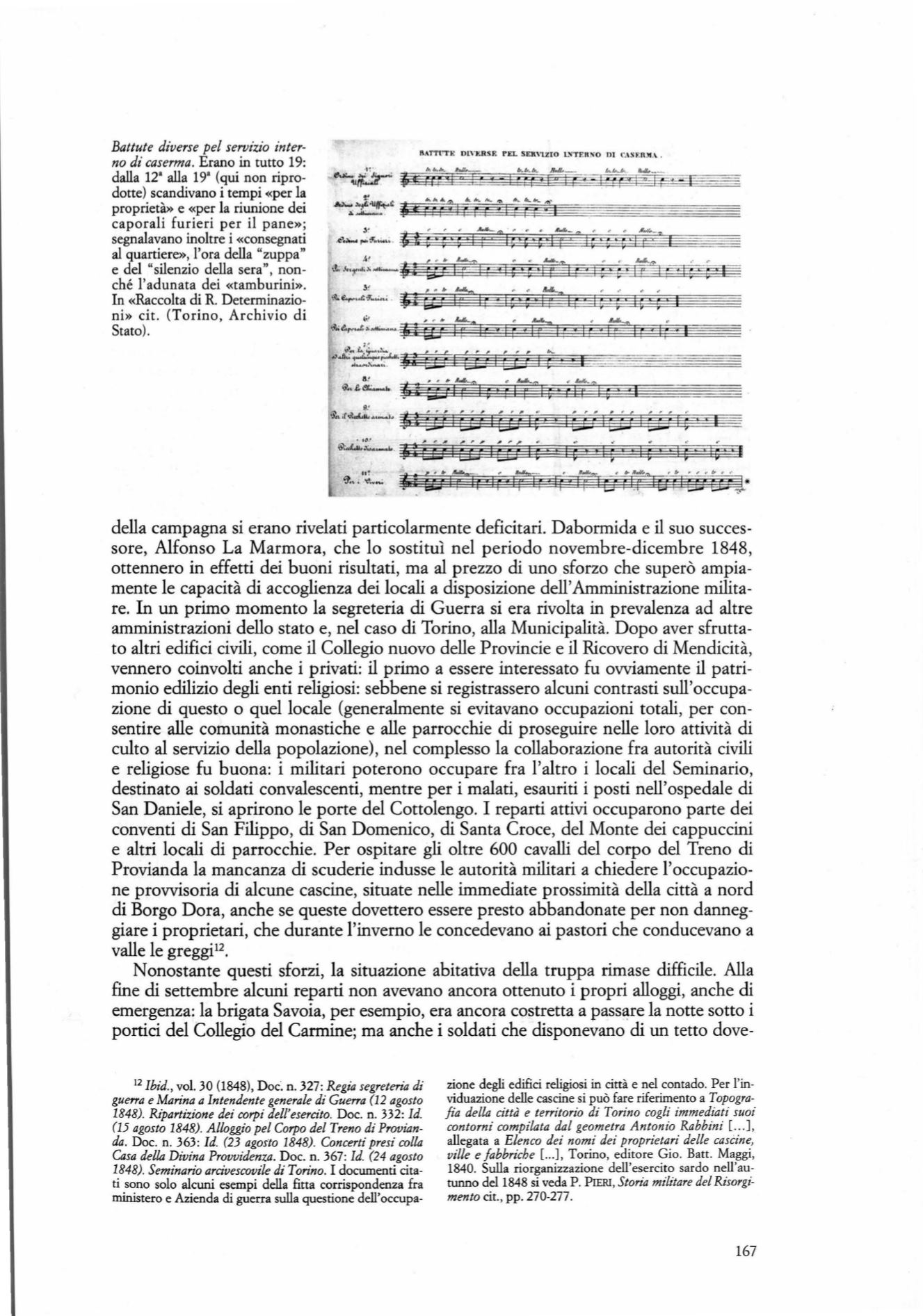
Battute diverse pel servizio inter–
no di caserma.
Erano in tutto 19:
dalla 12' alla 19' (qui non ripro–
dotte) scandivano i tempi «per la
proprietà» e «per la riunione dei
caporali furieri per
il
pane»;
segnalavano inoltre i «consegnati
al quartiere», l'ora della "zuppa"
e del "silenzio della sera", non–
ché l'adunata dei «tamburini».
In «Raccolta di
R.
Determinazio–
ni»
dt.
(Torino, Archivio di
Stato) .
R.\T1'(T E DIV•.:nSF! PEL SER"iZIO L""TEItNO DI'
l':\SF:n~:\ .
-II
~
.
~" .,,"'
....
~t'
MIl"
A.Jt:r
r
8uU=m__•
<'
W
~
'rl(ull"(!l
,'tr
r r
"
tr
~,'
"
!I!.~II= I· lr
I l Ir Il EJ==E O I I.( IUFICbCLl J*
della campagna si erano rivelati particolarmente deficitari. Dabormida e il suo succes–
sore, Alfonso La Marmora, che lo sostituì nel periodo novembre-dicembre 1848,
ottennero in effetti dei buoni risultati, ma al prezzo di uno sforzo che superò ampia–
mente le capacità di accoglienza dei locali a disposizione dell'Amministrazione milita–
re. In un primo momento la segreteria di Guerra si era rivolta in prevalenza ad altre
amministrazioni dello stato e, nel caso di Torino, alla Municipalità. Dopo aver sfrutta–
to altri edifici civili, come il Collegio nuovo delle Provincie e il Ricovero di Mendicità,
vennero coinvolti anche i privati: il primo a essere interessato fu ovviamente il patri–
monio edilizio degli enti religiosi: sebbene si registrassero alcuni contrasti sull'occupa–
zione di questo o quel locale (generalmente si evitavano occupazioni totali, per con–
sentire alle comunità monastiche e alle parrocchie di proseguire nelle loro attività di
culto al servizio della popolazione), nel complesso la collaborazione fra autorità civili
e religiose fu buona: i militari poterono occupare fra l'altro i locali del Seminario,
destinato ai soldati convalescenti, mentre per i malati, esauriti i posti nell'ospedale di
San Daniele, si aprirono le porte del Cottolengo. I reparti attivi occuparono parte dei
conventi di San Filippo, di San Domenico, di Santa Croce, del Monte dei cappuccini
e altri locali di parrocchie. Per ospitare gli oltre 600 cavalli del corpo del Treno di
Provianda la mancanza di scuderie indusse le autorità militari a chiedere l'occupazio–
ne provvisoria di alcune cascine, situate nelle immediate prossimità della città a nord
di Borgo Dora, anche se queste dovettero essere presto abbandonate per non danneg–
giare i proprietari, che durante l'inverno le concedevano ai pastori che conducevano a
valle le greggi
12.
Nonostante questi sforzi, la situazione abitativa della truppa rimase difficile. Alla
fine
di
settembre alcuni reparti non avevano ancora ottenuto i propri alloggi, anche di
emergenza: la brigata Savoia, per esempio, era ancora costretta a
pass~re
la notte sotto i
portici del Collegio del Carmine; ma anche i soldati che disponevano di un tetto dove-
12
Ibid.,
voI. 30 (1848), Doc. n. 327:
Regia segreteria di
gue"a e Marina a Intendente generale di Gue"a
(12
agosto
1848). Ripartizione dei corpi dell'esercito.
Doc. n . 332:
Id.
(15 agosto
1848).
Alloggio pel Corpo del Treno di Provian–
da.
Doc. n. 363:
Id.
(23
agosto
1848).
Concerti presi colla
Casa della Divina Provvidenza.
Doc. n. 367:
Id.
(24
agosto
1848). Seminario arcivescovile di Torino.
I
documenti cita–
ti sono solo alcuni esempi della fitta corrispondenza fra
ministero e Azienda di guerra sulla questione dell'occupa-
zione degli edifici religiosi in città e nel contado. Per l'in–
viduazione delle cascine si può fare riferimento a
Topogra–
fia della città e territorio di Torino cogli immediati suoi
contorni compilata dal geometra Antonio Rabbini
[...
l,
allegata a
Elenco dei nomi dei proprietari delle cascine,
ville e fabbriche
[...
l,
Torino, editore Gio. Batt. Maggi,
1840. Sulla riorganizzazione dell'esercito sardo nell'au–
tunno del 1848 si veda P . PIERI,
Storia militare del Risorgi–
mento
cit.,
pp. 270-277.
167


















