
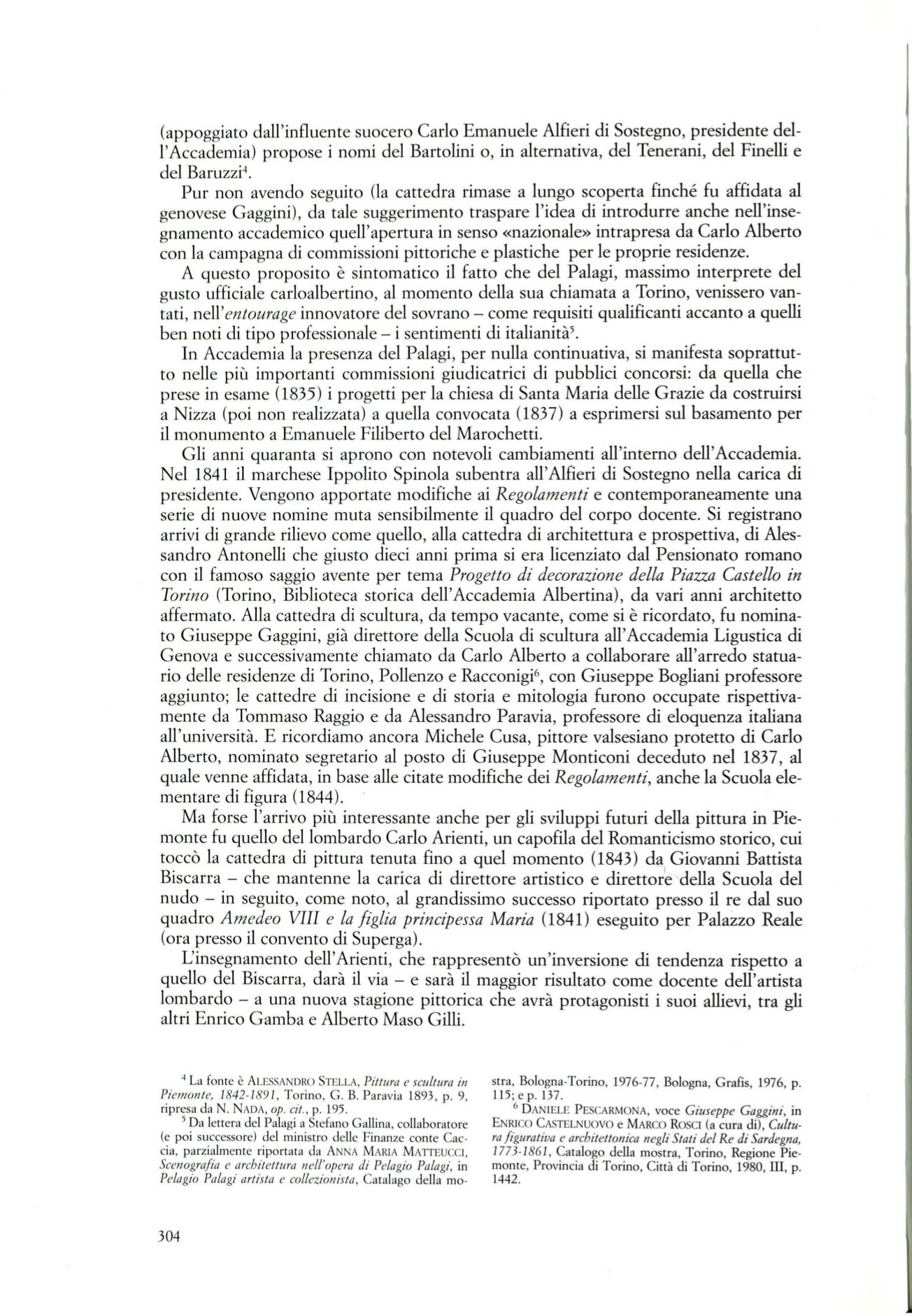
(appoggiato dall'influente suocero Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, presidente del-
1'Accademia) propose i nomi del Bartolini o, in alternativa, del Tenerani, del Finelli e
del Baruzzi
4 •
Pur non avendo seguito (la cattedra rimase a lungo scoperta finché fu affidata al
genovese Gaggini), da tale suggerimento traspare l'idea di introdurre anche nell'inse–
gnamento accademico quell'apertura in senso «nazionale» intrapresa da Carlo Alberto
con la campagna di commissioni pittoriche e plastiche per le proprie residenze.
A questo proposito
è
sintomatico il fatto che del Palagi, massimo interprete del
gusto ufficiale carloalbertino, al momento della sua chiamata a Torino, venissero van–
tati, nell'
entourage
innovatore del sovrano - come requisiti qualificanti accanto a quelli
ben noti di tipo professionale - i sentimenti di italianità
5 .
In Accademia la presenza del Palagi, per nulla continuativa, si manifesta soprattut–
to nelle più importanti commissioni giudicatrici di pubblici concorsi: da quella che
prese in esame (1835 ) i progetti per la chiesa di Santa Maria delle Grazie da costruirsi
a Nizza (poi non realizzata) a quella convocata (1837) a esprimersi sul basamento per
il monumento a Emanuele Filiberto del Marochetti.
Gli anni quaranta si aprono con notevoli cambiamenti all'interno dell'Accademia.
Nel 1841 il marchese Ippolito Spinola subentra all'Alfieri di Sostegno nella carica di
presidente. Vengono apportate modifiche ai
Regolamenti
e contemporaneamente una
serie di nuove nomine muta sensibilmente il quadro del corpo docente. Si registrano
arrivi di grande rilievo come quello, alla cattedra di architettura e prospettiva, di Ales–
sandro Antonelli che giusto dieci anni prima si era licenziato dal Pensionato romano
con il famoso saggio avente per tema
Progetto di decorazione della Piazza Castello in
Torino
(Torino, Biblioteca storica dell'Accademia Albertina), da vari anni architetto
affermato. Alla cattedra di scultura, da tempo vacante, come si
è
ricordato, fu nomina–
to Giuseppe Gaggini, già direttore della Scuola di scultura all 'Accademia Ligustica di
Genova e successivamente chiamato da Carlo Alberto a collaborare all' arredo statua–
rio delle residenze di Torino, Pollenzo e Racconigi
6 ,
con Giuseppe Bogliani professore
aggiunto; le cattedre di incisione e di storia e mitologia furono occupate rispettiva–
mente da Tommaso Raggio e da Alessandro Paravia, professore di eloquenza italiana
all'università. E ricordiamo ancora Michele Cusa, pittore valsesiano protetto di Carlo
Alberto, nominato segretario al posto di Giuseppe Monticoni deceduto nel 1837, al
quale venne affidata, in base alle citate modifiche dei
Regolamenti,
anche la Scuola ele–
mentare di figura (1844 ).
Ma forse l'arrivo più interessante anche per gli sviluppi futuri della pittura in Pie–
monte fu quello del lombardo Carlo Arienti, un capofila del Romanticismo storico, cui
toccò la cattedra di pittura tenuta fino a quel momento (1843) da Giovanni Battista
Biscarra - che mantenne la carica di direttore artistico e
direttor~
della Scuola del
nudo - in seguito, come noto, al grandissimo successo riportato presso il re dal suo
quadro
Amedeo VIII e la figlia principessa Maria
(1841) eseguito per Palazzo Reale
(ora presso il convento di Superga).
L'insegnamento dell 'Arienti, che rappresentò un 'inversione di tendenza rispetto a
quello del Biscarra, darà
il
via - e sarà
il
maggior risultato come docente dell'artista
lombardo - a una nuova stagione pittorica che avrà protagonisti i suoi allievi, tra gli
altri Enrico Gamba e Alberto Maso Gilli.
4
La fonte
è
ALESSANDRO STELLA ,
Pittura e scultura in
Piemonte,
1842- 189 1, Torino, G. B. Paravia 1893, p. 9,
ripresa da N. NADA,
op.
cit.,
p. 195.
5
Da lettera del Palagi a Stefano Gallina, collabo ratore
(e poi successore) del ministro delle Finanze conte Cac–
cia, parzialmente riportata da ANNA MARlA MATTEUCCI,
Scenografia e architettura nell'opera di Pelagio Palagi,
in
Pelagio Palagi artista e collezionista ,
Catalago della mo-
304
stra, Bologna-To rino, 1976-77, Bologna, G rafis, 1976, p .
115; e
p.
137.
6
DAN IELE P ESCARMONA, voce
Giuseppe Gaggini,
in
ENRlCO CASTELNUOVO e MARCO ROSCI (a cura di) ,
Cultu–
ra figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna,
1773-186 1, Catalogo della mostra, Torino, Regione Pie–
monte, P rovincia di Torino, Città di Torino, 1980, III, p .
1442.


















