
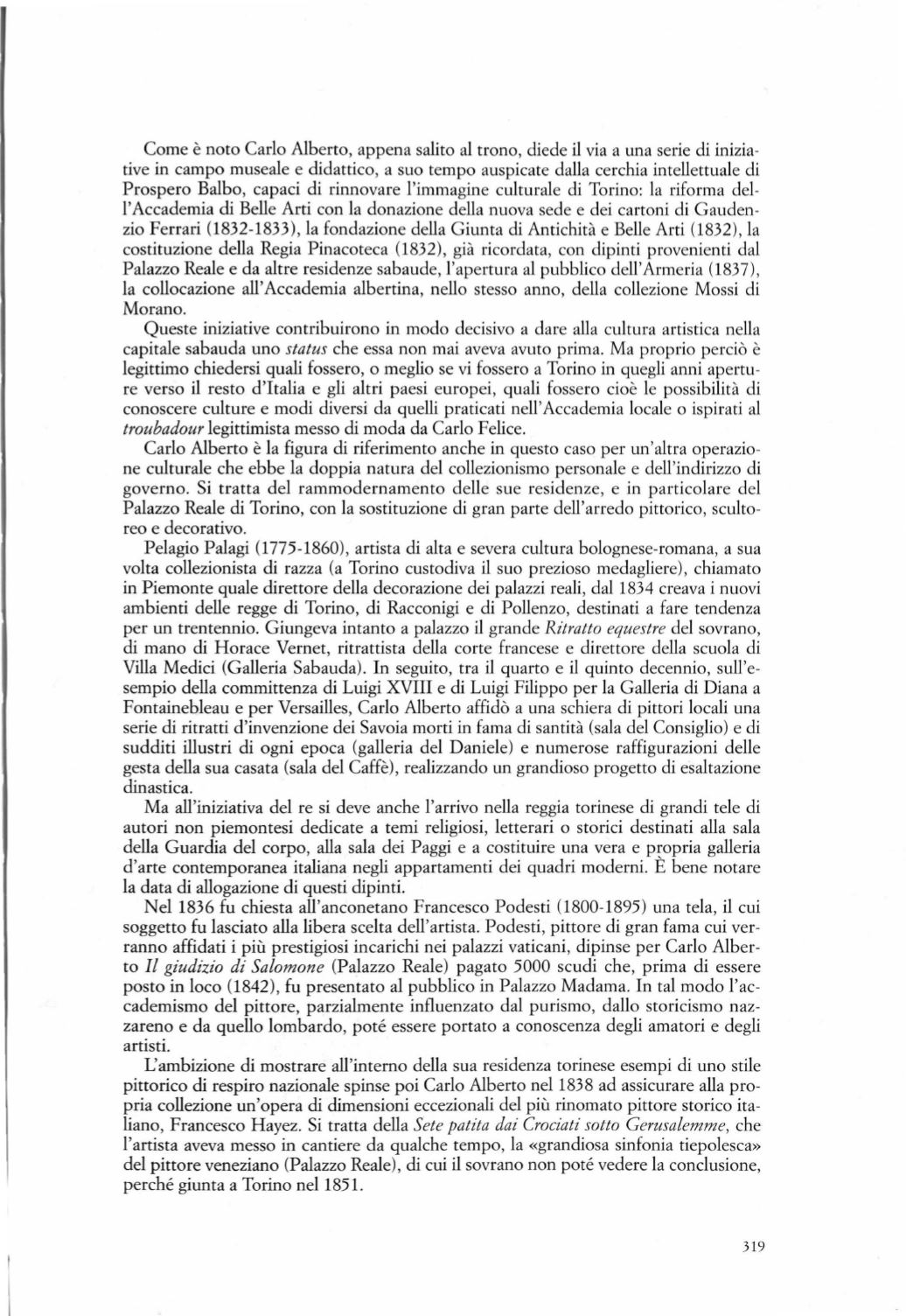
Come è noto Carlo Alberto, appena salito al trono, diede il via a una serie di inizia–
tive in campo museale e didattico, a suo tempo auspicate dalla cerchia intellettuale di
Prospero Balbo, capaci di rinnovare l'immagine culturale di Torino: la riforma del–
l'Accademia di Belle Arti con la donazione della nuova sede e dei cartoni di Gauden–
zio Ferrari (1832-1833), la fondazione della Giunta di Antichità e Belle Arti (1832), la
costituzione della Regia Pinacoteca (1832), già ricordata, con dipinti provenienti dal
Palazzo Reale e da altre residenze sabaude, l'apertura al pubblico dell'Armeria (1837),
la collocazione all'Accademia albertina, nello stesso anno, della collezione Mossi di
Morano.
Queste iniziative contribuirono in modo decisivo a dare alla cultura artistica nella
capitale sabauda uno
status
che essa non mai aveva avuto prima. Ma proprio perciò è
legittimo chiedersi quali fossero, o meglio se vi fossero a Torino in quegli anni apertu–
re verso il resto d'Italia e gli altri paesi europei, quali fossero cioè le possibilità di
conoscere culture e modi diversi da quelli praticati nell'Accademia locale o ispirati al
troubadour
legittimista messo di moda da Carlo Felice.
Carlo Alberto è la figura di riferimento anche in questo caso per un 'altra operazio–
ne culturale che ebbe la doppia natura del collezionismo personale e dell'indirizzo di
governo. Si tratta del rammodernamento delle sue residenze, e in particolare del
Palazzo Reale di Torino, con la sostituzione di gran parte dell' arredo pittorico, sculto–
reo e decorativo.
Pelagio Palagi (1775-1860), artista di alta e severa cultura bolognese-romana, a sua
volta collezionista di razza (a Torino custodiva il suo prezioso medagliere) , chiamato
in Piemonte quale direttore della decorazione dei palazzi reali, dal 1834 creava i nuovi
ambienti delle regge di Torino, di Racconigi e di Pollenzo, destinati a fare tendenza
per un trentennio. Giungeva intanto a palazzo il grande
Ritratto equestre
del sovrano,
di mano di Horace Vernet, ritrattista della corte francese e direttore della scuola di
Villa Medici (Galleria Sabauda). In seguito, tra il quarto e il quinto decennio, sull'e–
sempio della committenza di Luigi XVIII e di Luigi Filippo per la Galleria di Diana a
Fontainebleau e per Versailles, Carlo Alberto affidò a una schiera di pittori locali una
serie di ritratti d'invenzione dei Savoia morti in fama di santità (sala del Consiglio) e di
sudditi illustri di ogni epoca (galleria del Daniele) e numerose raffigurazioni delle
gesta della sua casata (sala del Caffè), realizzando un grandioso progetto di esaltazione
dinastica.
Ma all'iniziativa del re si deve anche l'arrivo nella reggia torinese di grandi tele di
autori non piemontesi dedicate a temi religiosi, letterari o storici destinati alla sala
della Guardia del corpo, alla sala dei Paggi e a costituire una vera e propria galleria
d'arte contemporanea italiana negli appartamenti dei quadri moderni.
È
bene notare
la data di allogazione di questi dipinti.
Nel 1836 fu chiesta all'anconetano Francesco Podesti (1800-1895) una tela, il cui
soggetto fu lasciato alla libera scelta dell 'artista. Podesti, pittore di gran fama cui ver–
ranno affidati i più prestigiosi incarichi nei palazzi vaticani, dipinse per Carlo Alber–
to
Il giudizio di Salomone
(Palazzo Reale) pagato 5000 scudi che, prima di essere
posto in loco (1842), fu presentato al pubblico in Palazzo Madama. In tal modo l'ac–
cademismo del pittore, parzialmente influenzato dal purismo, dallo storicismo naz–
zareno e da quello lombardo, poté essere portato a conoscenza degli amatori e degli
artisti.
L'ambizione di mostrare all'interno della sua residenza torinese esempi di uno stile
pittorico di respiro nazionale spinse poi Carlo Alberto nel 1838 ad assicurare alla pro–
pria collezione un'opera di dimensioni eccezionali del più rinomato pittore storico ita–
liano, Francesco Hayez. Si tratta della
Sete patita dai Crociati sotto Gerusalemme,
che
l'artista aveva messo in cantiere da qualche tempo , la «grandiosa sinfonia tiepolesca»
del pittore veneziano (Palazzo Reale), di cui il sovrano non poté vedere la conclusione,
perché giunta a Torino nel 1851.
319


















