
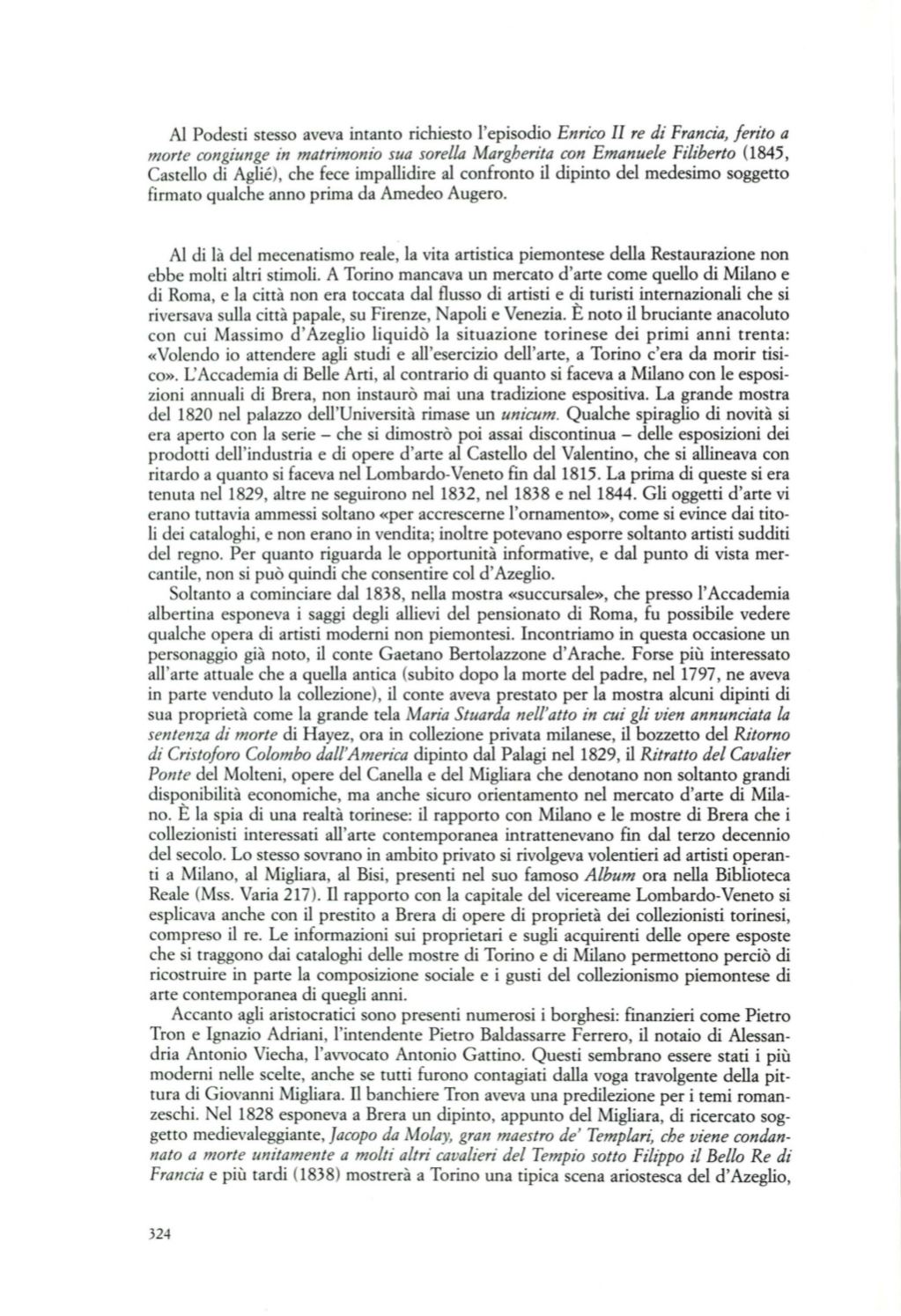
Al Podesti stesso aveva intanto richiesto l'episodio
Enrico II re di Francia, ferito a
morte congiunge in matrimonio sua sorella Margherita con Emanuele Filiberto (1845,
Castello di Aglié), che fece impallidire al confronto il dipinto del medesimo soggetto
firmato qualche anno prima da Amedeo Augero.
Al di là del mecenatismo reale, la vita artistica piemontese della Restaurazione non
ebbe molti altri stimoli. A Torino mancava un mercato d'arte come quello di Milano e
di Roma, e la città non era toccata dal flusso di artisti e di turisti internazionali che si
riversava sulla città papale, su Firenze, Napoli e Venezia.
È
noto il bruciante anacoluto
con cui Massimo d'Azeglio liquidò la situazione torinese dei primi anni trenta:
«Volendo io attendere agli studi e all'esercizio dell'arte, a Torino c'era da morir tisi–
co». L'Accademia di Belle Arti, al contrario di quanto si faceva a Milano con le esposi–
zioni annuali di Brera, non instaurò mai una tradizione espositiva. La grande mostra
del 1820 nel palazzo dell'Università rimase un
unicum.
Qualche spiraglio di novità si
era aperto con la serie - che si dimostrò poi assai discontinua - delle esposizioni dei
prodotti dell'industria e di opere d'arte al Castello del Valentino, che si allineava con
ritardo a quanto si faceva nel Lombardo-Veneto fin dal 1815. La prima di queste si era
tenuta nel 1829, altre ne seguirono nel 1832, nel 1838 e nel 1844. Gli oggetti d'arte vi
erano tuttavia ammessi soltano «per accrescerne l'ornamento», come si evince dai tito–
li dei cataloghi, e non erano in vendita; inoltre potevano esporre soltanto artisti sudditi
del regno. Per quanto riguarda le opportunità informative, e dal punto di vista mer–
cantile, non si può quindi che consentire col d'Azeglio.
Soltanto a cominciare dal 1838, nella mostra «succursale», che presso l'Accademia
albertina esponeva i saggi degli allievi del pensionato di Roma, fu possibile vedere
qualche opera di artisti moderni non piemontesi. Incontriamo in questa occasione un
personaggio già noto, il conte Gaetano Bertolazzone d'Arache. Forse più interessato
all 'arte attuale che a quella antica (subito dopo la morte del padre, nel 1797, ne aveva
in parte venduto la collezione), il conte aveva prestato per la mostra alcuni dipinti di
sua proprietà come la grande tela
Maria Stuarda nell'atto in cui gli vien annunciata la
sentenza di morte
di Hayez, ora in collezione privata milanese, il bozzetto del
Ritorno
di Cristoforo Colombo dall'America
dipinto dal Palagi nel 1829, il
Ritratto del Cavalier
Ponte
del Molteni, opere del Canella e del Migliara che denotano non soltanto grandi
disponibilità economiche, ma anche sicuro orientamento nel mercato d'arte
di
Mila–
no.
È
la spia di una realtà torinese: il rapporto con Milano e le mostre di Brera che i
collezionisti interessati all'arte contemporanea intrattenevano fin dal terzo decennio
del secolo. Lo stesso sovrano in ambito privato si rivolgeva volentieri ad artisti operan–
ti a Milano, al Migliara, al Bisi, presenti nel suo famoso
Album
ora nella Biblioteca
Reale (Mss. Varia 217). Il rapporto con la capitale del vicereame Lombardo-Veneto si
esplicava anche con il prestito a Brera di opere di proprietà dei collezionisti torinesi,
compreso il re. Le informazioni sui proprietari e sugli acquirenti delle opere esposte
che si traggono dai cataloghi delle mostre di Torino e di Milano permettono perciò
di
ricostruire in parte la composizione sociale e i gusti del collezionismo piemontese di
arte contemporanea di quegli anni.
Accanto agli aristocratici sono presenti numerosi i borghesi: finanzieri come Pietro
Tron e Ignazio Adriani, l'intendente Pietro Baldassarre Ferrero, il notaio di Alessan–
dria Antonio Viecha, l'avvocato Antonio Gattino. Questi sembrano essere stati i più
moderni nelle scelte, anche se tutti furono contagiati dalla voga travolgente della pit–
tura di Giovanni Migliara. Il banchiere Tron aveva una predilezione per i temi roman–
zeschi. Nel 1828 esponeva a Brera un dipinto , appunto del Migliara, di ricercato sog–
getto medievaleggiante,
Jacopo da Molay, gran maestro de' Templart; che viene condan–
nato a morte unitamente a molti altri cavalieri del Tempio sotto Filippo il Bello Re di
Francia
e più tardi (1838) mostrerà a Torino una tipica scena ariostesca del d'Azeglio,
324


















