
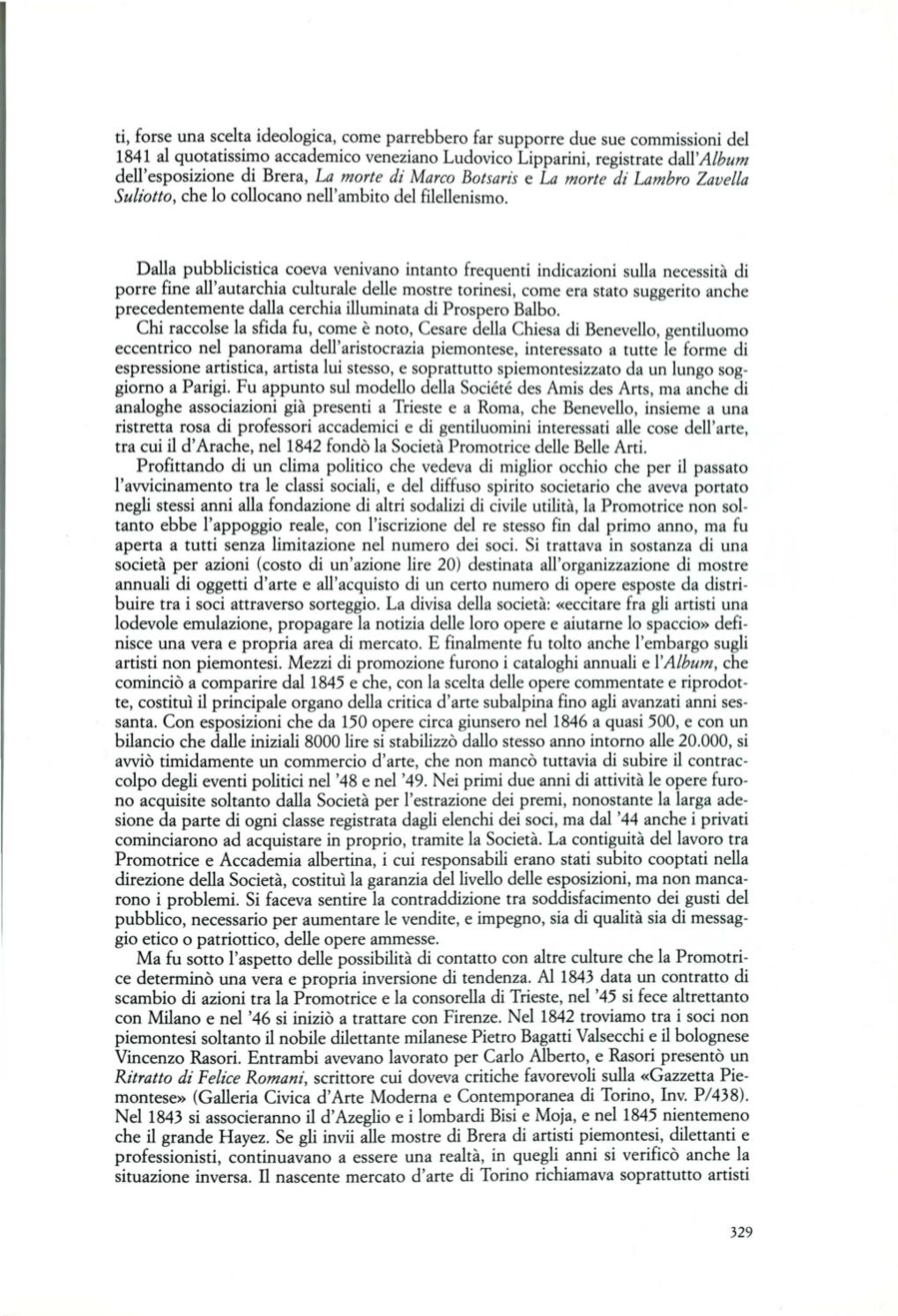
ti, forse una scelta ideologica, come parrebbero far supporre due sue commissioni del
1841 al quotatissimo accademico veneziano Ludovico Lipparini, registrate
dall'Album
dell'esposizione di Brera,
La morte di Marco Botsaris
e
La morte di Lambro Zavella
Suliotto,
che lo collocano nell' ambito del filellenismo.
Dalla pubblicistica coeva venivano intanto frequenti indicazioni sulla necessità di
porre fine all'autarchia culturale delle mostre torinesi, come era stato suggerito anche
precedentemente dalla cerchia illuminata di Prospero Balbo.
Chi raccolse la sfida fu, come è noto, Cesare della Chiesa di Benevello, gentiluomo
eccentrico nel panorama dell'aristocrazia piemontese, interessato a tutte le forme di
espressione artistica, artista lui stesso, e soprattutto spiemontesizzato da un lungo sog–
giorno a Parigi. Fu appunto sul modello della Société des Amis des Arts, ma anche di
analoghe associazioni già presenti a Trieste e a Roma , che Benevello, insieme a una
ristretta rosa di professori accademici e di gentiluomini interessati alle cose dell 'arte,
tra cui il d'Arache, nel 1842 fondò la Società Promotrice delle Belle Arti.
Profittando di un clima politico che vedeva di miglior occhio che per il passato
l'avvicinamento tra le classi sociali, e del diffuso spirito societario che aveva portato
negli stessi anni alla fondazione di altri sodalizi di civile utilità, la Promotrice non sol–
tanto ebbe l'appoggio reale, con l'iscrizione del re stesso fin dal primo anno, ma fu
aperta a tutti senza limitazione nel numero dei soci. Si trattava in sostanza di una
società per azioni (costo di un'azione lire 20) destinata all'organizzazione di mostre
annuali di oggetti d'arte e all'acquisto di un certo numero di opere esposte da distri–
buire tra i soci attraverso sorteggio. La divisa della società: «eccitare fra gli artisti una
lodevole emulazione, propagare la notizia delle loro opere e aiutarne lo spaccio» defi–
nisce una vera e propria area di mercato. E finalmente fu tolto anche l'embargo sugli
artisti non piemontesi. Mezzi di promozione furono i cataloghi annuali e
l'Album,
che
cominciò a comparire dal 1845 e che, con la scelta delle opere commentate e riprodot–
te, costituì il principale organo della critica d'arte subalpina fino agli avanzati anni ses–
santa. Con esposizioni che da 150 opere circa giunsero nel 1846 a quasi 500, e con un
bilancio che dalle iniziali 8000 lire si stabilizzò dallo stesso anno intorno alle 20.000, si
avviò timidamente un commercio d'arte, che non mancò tuttavia di subire il contrac–
colpo degli eventi politici nel '48 e nel '49. Nei primi due anni di attività le opere furo–
no acquisite soltanto dalla Società per l'estrazione dei premi, nonostante la larga ade–
sione da parte di ogni classe registrata dagli elenchi dei soci, ma dal'44 anche i privati
cominciarono ad acquistare in proprio, tramite la Società. La contiguità del lavoro tra
Promotrice e Accademia albertina, i cui responsabili erano stati subito cooptati nella
direzione della Società, costituì la garanzia del livello delle esposizioni, ma non manca–
rono i problemi. Si faceva sentire la contraddizione tra soddisfacimento dei gusti del
pubblico, necessario per aumentare le vendite, e impegno, sia di qualità sia di messag–
gio etico o patriottico, delle opere ammesse.
Ma fu sotto l'aspetto delle possibilità di contatto con altre culture che la Promotri–
ce determinò una vera e propria inversione di tendenza. Al 1843 data un contratto
di
scambio
di
azioni tra la Promotrice e la consorella di Trieste, nel '45 si fece altrettanto
con Milano e nel '46 si iniziò a trattare con Firenze. Nel 1842 troviamo tra i soci non
piemontesi soltanto il nobile dilettante milanese Pietro Bagatti Valsecchi e il bolognese
Vincenzo Rasori. Entrambi avevano lavorato per Carlo Alberto, e Rasori presentò un
Ritratto di Felice Romani,
scrittore cui doveva critiche favorevoli sulla «Gazzetta Pie–
montese» (Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Inv.
P/438).
Nel 1843 si associeranno il d'Azeglio e i lombardi Bisi e Moja, e nel 1845 nientemeno
che il grande Hayez. Se gli invii alle mostre di Brera di artisti piemontesi, dilettanti e
professionisti, continuavano a essere una realtà, in quegli anni si verificò anche la
situazione inversa.
il
nascente mercato d'arte
di
Torino richiamava soprattutto artisti
329


















