
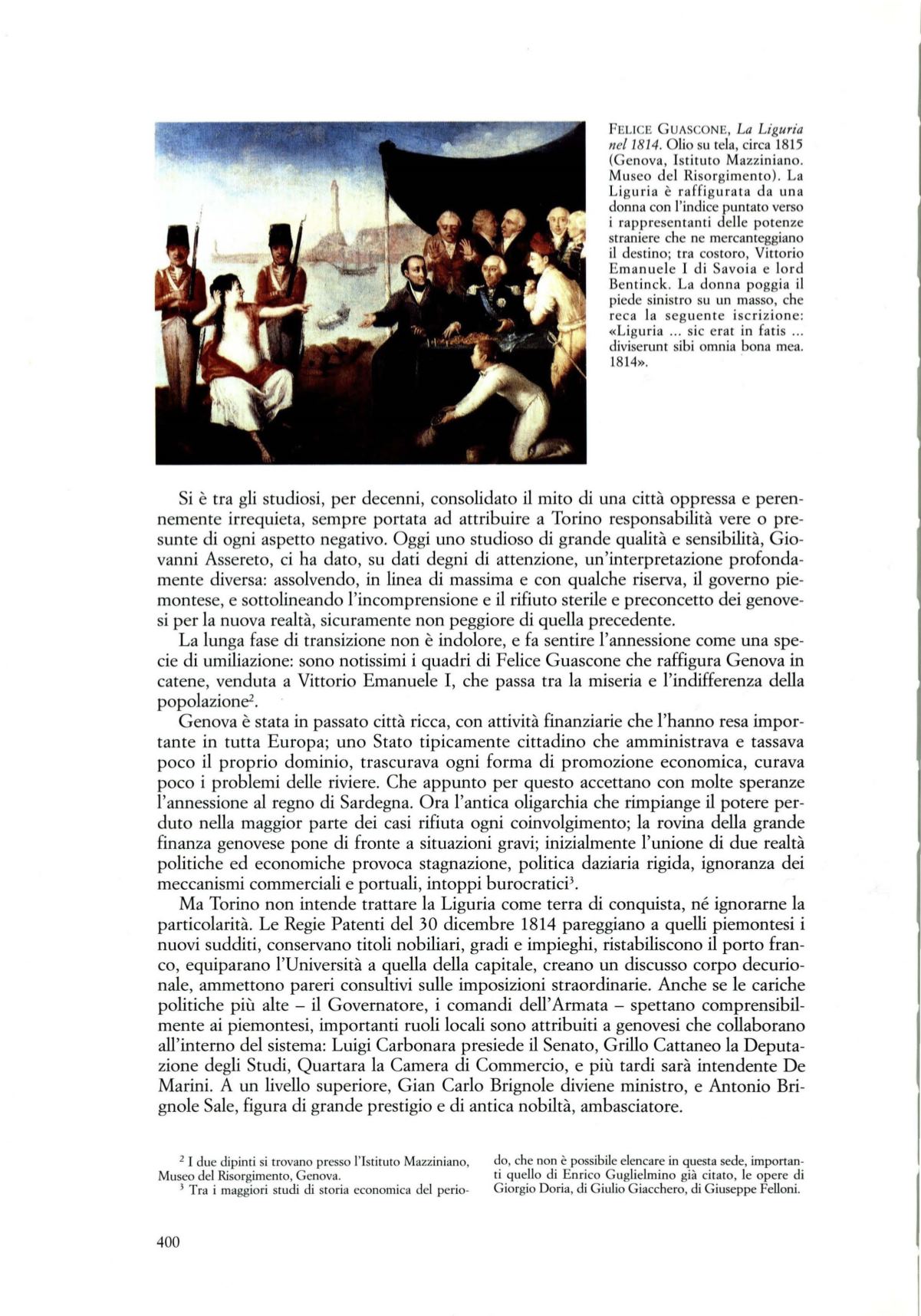
FELICE GUASCONE,
La Liguria
nel
1814. Olio su tela, circa 1815
(Genova, Istituto Mazziniano.
Museo del Risorgimento) . La
Liguria è raffigurata da una
donna con l'indice puntato verso
i rappresentanti delle potenze
straniere che ne mercanteggiano
il
destino; tra costoro, Vittorio
Emanuele I di Savoia e lord
Bentinck. La donna poggia il
piede sinistro su un masso, che
reca la seguente iscrizione:
«Liguria ... sic erat in fatis ...
diviserunt sibi omnia bona mea.
1814».
Si
è
tra gli studiosi, per decenni, consolidato il mito di una città oppressa e peren–
nemente irrequieta, sempre portata ad attribuire a Torino responsabilità vere o pre–
sunte di ogni aspetto negativo. Oggi uno studioso di grande qualità e sensibilità, Gio–
vanni Assereto, ci ha dato, su dati degni di attenzione, un'interpretazione profonda–
mente diversa: assolvendo, in linea di massima e con qualche riserva, il governo pie–
montese, e sottolineando l'incomprensione e il rifiuto sterile e preconcetto dei genove–
si per la nuova realtà, sicuramente non peggiore di quella precedente.
La lunga fase di transizione non è indolore, e fa sentire l'annessione come una spe–
cie di umiliazione: sono notissimi i quadri di Felice Guascone che raffigura Genova in
catene, venduta a Vittorio Emanuele
I,
che passa tra la miseria e l'indifferenza della
popolazione2.
Genova è stata in passato città ricca, con attività finanziarie che l'hanno resa impor–
tante in tutta Europa; uno Stato tipicamente cittadino che amministrava e tassava
poco
il
proprio dominio, trascurava ogni forma di promozione economica, curava
poco i problemi delle riviere. Che appunto per questo accettano con molte speranze
l'annessione al regno di Sardegna. Ora l'antica oligarchia che rimpiange il potere per–
duto nella maggior parte dei casi rifiuta ogni coinvolgimento; la rovina della grande
finanza genovese pone di fronte a situazioni gravi; inizialmente l'unione di due realtà
politiche ed economiche provoca stagnazione, politica daziaria rigida, ignoranza dei
meccanismi commerciali e portuali, intoppi burocratici
3 .
Ma Torino non intende trattare la Liguria come terra di conquista, né ignorarne la
particolarità. Le Regie Patenti del 30 dicembre
1814
pareggiano a quelli piemontesi i
nuovi sudditi, conservano titoli nobiliari, gradi e impieghi, ristabiliscono il porto fran–
co, equiparano l'Università a quella della capitale, creano un discusso corpo decurio–
naIe, ammettono pareri consultivi sulle imposizioni straordinarie. Anche se le cariche
politiche più alte -
il
Governatore, i comandi dell'Armata - spettano comprensibil–
mente ai piemontesi, importanti ruoli locali sono attribuiti a genovesi che collaborano
all'interno del sistema: Luigi Carbonara presiede il Senato, Grillo Cattaneo la Deputa–
zione degli Studi, Quartara la Camera di Commercio, e più tardi sarà intendente De
Marini. A un livello superiore, Gian Carlo Brignole diviene ministro, e Antonio Bri–
gnole Sale, figura di grande prestigio e di antica nobiltà, ambasciatore.
2
I due dipinti si trovano presso l'Istituto Mazziniano,
Museo del Risorgimento, Genova.
3
Tra i maggiori studi di storia economica del perio-
400
do, che non è possibile elencare
in
questa sede, importan–
ti quello di Enrico Guglielmino già citato, le opere di
G iorgio Doria, di Giulio Giacchero, di Giuseppe Felloni.


















